
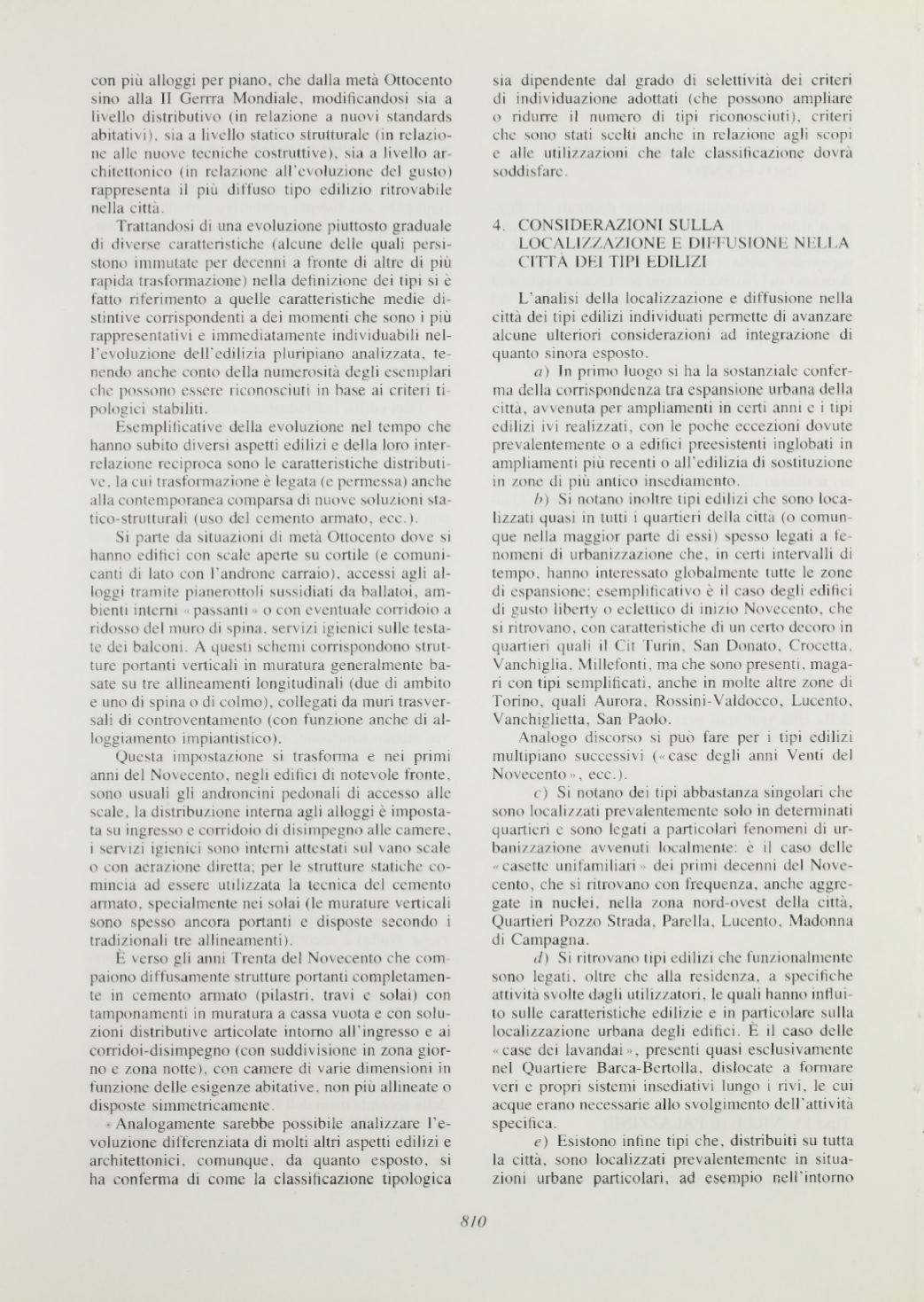
con più alloggi per piano, che dalla metà Ottocento
sino alla II Gerrra Mondiale, modificandosi sia a
livello distributivo (in relazione a nuovi standards
abitativi), sia a livello statico strutturale (in relazio-
ne alle nuove tecniche costruttive), sia a livello ar-
chitettonico (in relazione all'evoluzione del gusto)
rappresenta il più diffuso tipo edilizio ritrovabile
nella città.
Trattandosi di una evoluzione piuttosto graduale
di diverse caratteristiche (alcune delle quali persi-
stono immutate per decenni a fronte di altre di più
rapida trasformazione) nella definizione dei tipi si è
fatto riferimento a quelle caratteristiche medie di-
stintive corrispondenti a dei momenti che sono i più
rappresentativi e immediatamente individuabili nel-
l'evoluzione dell'edilizia pluripiano analizzata, te-
nendo anche conto della numerosità degli esemplari
che possono essere riconosciuti in base ai criteri ti-
pologici stabiliti.
Esemplificative della evoluzione nel tempo che
hanno subito diversi aspetti edilizi e della loro inter-
relazione reciproca sono le caratteristiche distributi-
ve, la cui trasformazione è legata (e permessa) anche
alla contemporanea comparsa di nuove soluzioni sta-
tico-strutturali (uso del cemento armato, ecc.).
Si parte da situazioni di metà Ottocento dove si
hanno edifici con scale aperte su cortile (e comuni-
canti di lato con l'androne carraio), accessi agli al-
loggi tramite pianerottoli sussidiati da ballatoi, am-
bienti interni «passanti» o con eventuale corridoio a
ridosso del muro di spina, servizi igienici sulle testa-
te dei balconi. A questi schemi corrispondono strut-
ture portanti verticali in muratura generalmente ba-
sate su tre allineamenti longitudinali (due di ambito
e uno di spina o di colmo), collegati da muri trasver-
sali di controventamento (con funzione anche di al-
loggiamento impiantistico).
Questa impostazione si trasforma e nei primi
anni del Novecento, negli edifici di notevole fronte,
sono usuali gli androncini pedonali di accesso alle
scale, la distribuzione interna agli alloggi è imposta-
ta su ingresso e corridoio di disimpegno alle camere,
i servizi igienici sono interni attestati sul vano scale
o con aerazione diretta; per le strutture statiche co-
mincia ad essere utilizzata la tecnica del cemento
armato, specialmente nei solai (le murature verticali
sono spesso ancora portanti e disposte secondo i
tradizionali tre allineamenti).
È verso gli anni Trenta del Novecento che com-
paiono diffusamente strutture portanti completamen-
te in cemento armato (pilastri, travi e solai) con
tamponamenti in muratura a cassa vuota e con solu-
zioni distributive articolate intorno all'ingresso e ai
corridoi-disimpegno (con suddivisione in zona gior-
no e zona notte), con camere di varie dimensioni in
funzione delle esigenze abitative, non più allineate o
disposte simmetricamente.
• Analogamente sarebbe possibile analizzare l'e-
voluzione differenziata di molti altri aspetti edilizi e
architettonici, comunque, da quanto esposto, si
ha conferma di come la classificazione tipologica
sia dipendente dal grado di selettività dei criteri
di individuazione adottati (che possono ampliare
o ridurre il numero di tipi riconosciuti), criteri
che sono stati scelti anche in relazione agli scopi
e alle utilizzazioni che tale classificazione dovrà
soddisfare.
4. CONSIDERAZIONI SULLA
LOCALIZZAZIONE E DIFFUSIONE NELLA
CITTÀ DEI TIPI EDILIZI
L'analisi della localizzazione e diffusione nella
città dei tipi edilizi individuati permette di avanzare
alcune ulteriori considerazioni ad integrazione di
quanto sinora esposto.
a) In primo luogo si ha la sostanziale confer-
ma della corrispondenza tra espansione urbana della
città, avvenuta per ampliamenti in certi anni e i tipi
edilizi ivi realizzati, con le poche eccezioni dovute
prevalentemente o a edifici preesistenti inglobati in
ampliamenti più recenti o all'edilizia di sostituzione
in zone di più antico insediamento.
b) Si notano inoltre tipi edilizi che sono loca-
lizzati quasi in tutti i quartieri della città (o comun-
que nella maggior parte di essi) spesso legati a fe-
nomeni di urbanizzazione che, in certi intervalli di
tempo, hanno interessato globalmente tutte le zone
di espansione; esemplificativo è il caso degli edifici
di gusto liberty o eclettico di inizio Novecento, che
si ritrovano, con caratteristiche di un certo decoro in
quartieri quali il Cit Turin, San Donato, Crocetta,
Vanchiglia, Millefonti, ma che sono presenti, maga-
ri con tipi semplificati, anche in molte altre zone di
Torino, quali Aurora, Rossini-Valdocco, Lucento,
Vanchiglietta, San Paolo.
Analogo discorso si può fare per i tipi edilizi
multipiano successivi (« case degli anni Venti del
Novecento >,, ecc.) .
c) Si notano dei tipi abbastanza singolari che
sono localizzati prevalentemente solo in determinati
quartieri e sono legati a particolari fenomeni di ur-
banizzazione avvenuti localmente: è il caso delle
« casette unifamiliari » dei primi decenni del Nove-
cento, che si ritrovano con frequenza, anche aggre-
gate in nuclei, nella zona nord-ovest della città,
Quartieri Pozzo Strada, Parella, Lucento, Madonna
di Campagna.
d) Si ritrovano tipi edilizi che funzionalmente
sono legati, oltre che alla residenza, a specifiche
attività svolte dagli utilizzatori, le quali hanno influi-
to sulle caratteristiche edilizie e in particolare sulla
localizzazione urbana degli edifici. È il caso delle
«case dei lavandai» , presenti quasi esclusivamente
nel Quartiere Barca-Bertolla, dislocate a formare
veri e propri sistemi insediativi lungo i rivi, le cui
acque erano necessarie allo svolgimento dell'attività
specifica.
e)
Esistono infine tipi che, distribuiti su tutta
la città, sono localizzati prevalentemente in situa-
zioni urbane particolari, ad esempio nell'intorno
810


















