
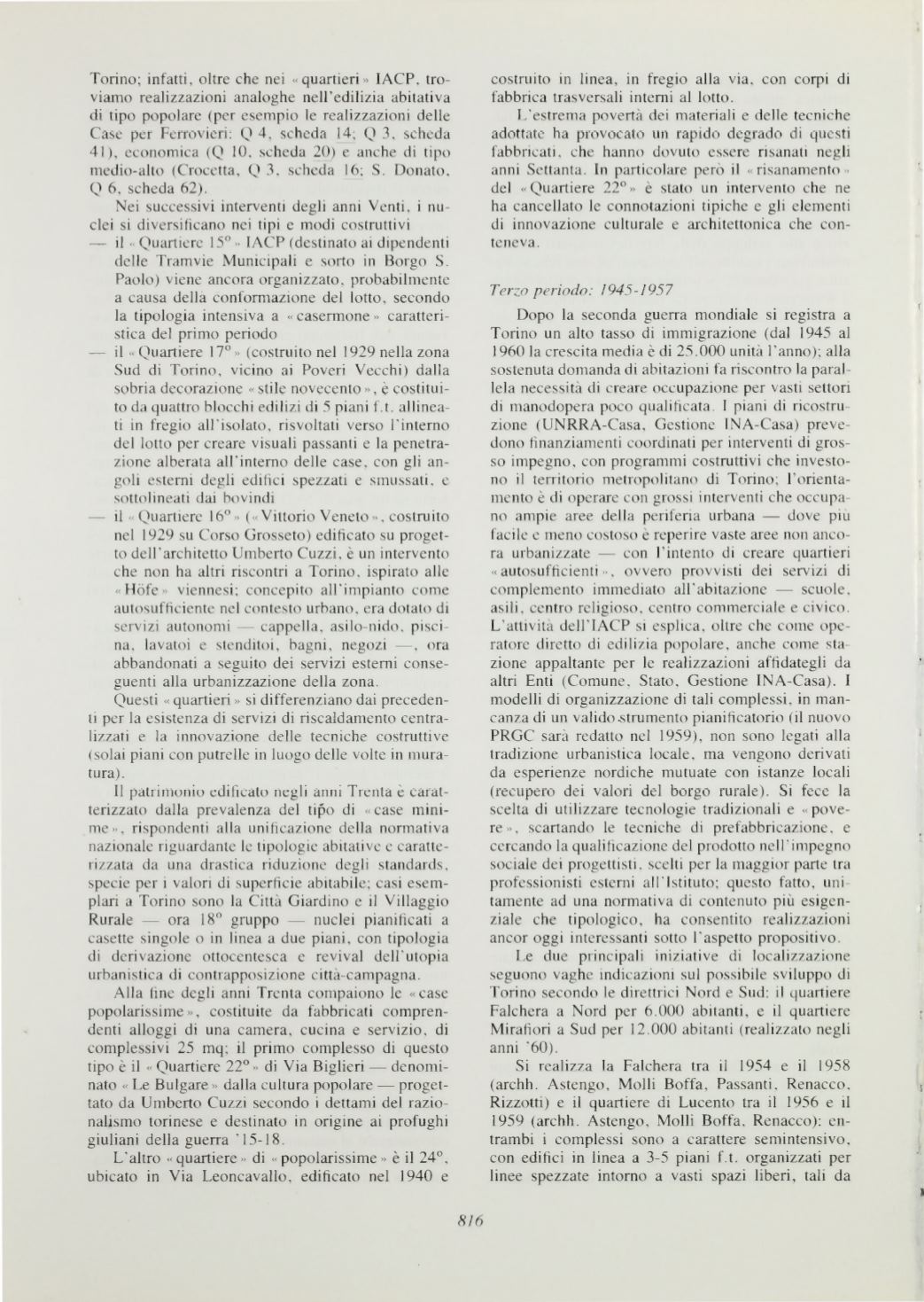
Torino; infatti, oltre che nei «quartieri» IACP, tro-
viamo realizzazioni analoghe nell'edilizia abitativa
di tipo popolare (per esempio le realizzazioni delle
Case per Ferrovieri: Q 4, scheda 14; Q 3, scheda
41), economica (Q 10, scheda 20) e anche di tipo
medio-alto (Crocetta, Q 3, scheda 16; S. Donato,
Q 6, scheda 62).
Nei successivi interventi degli anni Venti, i nu-
clei si diversificano nei tipi e modi costruttivi
— il « Quartiere 15° » IACP (destinato ai dipendenti
delle Tramvie Municipali e sorto in Borgo S.
Paolo) viene ancora organizzato, probabilmente
a causa della conformazione del lotto, secondo
la tipologia intensiva a « casermone » caratteri-
stica del primo periodo
— il « Quartiere 17°» (costruito nel 1929 nella zona
Sud di Torino, vicino ai Poveri Vecchi) dalla
sobria decorazione « stile novecento » ,
è
costitui-
to da quattro blocchi edilizi di 5 piani f.t. allinea-
ti in fregio all'isolato, risvoltati verso l'interno
del lotto per creare visuali passanti e la penetra-
zione alberata all'interno delle case, con gli an-
goli esterni degli edifici spezzati e smussati, e
sottolineati dai bovindi
il « Quartiere 16° » (»Vittorio Veneto » , costruito
nel 1929 su Corso Grosseto) edificato su proget-
to dell'architetto Umbe rto Cuzzi, è un intervento
che non ha altri riscontri a Torino, ispirato alle
Hòfe » viennesi; concepito all'impianto come
autosufficiente nel contesto urbano, era dotato di
servizi autonomi cappella, asilo-nido, pisci-
na, lavatoi e stenditoi, bagni, negozi —, ora
abbandonati a seguito dei servizi esterni conse-
guenti alla urbanizzazione della zona.
Questi «quartieri» si differenziano dai preceden-
ti per la esistenza di servizi di riscaldamento centra-
lizzati e la innovazione delle tecniche costruttive
(solai piani con putrelle in luogo delle volte in mura-
tura).
Il patrimonio edificato negli anni Trenta è carat-
terizzato dalla prevalenza del tipo di « case mini-
me», rispondenti alla unificazione della normativa
nazionale riguardante le tipologie abitati ve e caratte-
rizzata da una drastica riduzione degli standards,
specie per i valori di superficie abitabile; casi esem-
plari a Torino sono la Città Giardino e il Villaggio
Rurale ora 18° gruppo nuclei pianificati a
casette singole o in linea a due piani, con tipologia
di derivazione ottocentesca e revival dell'utopia
urbanistica di contrapposizione città-campagna.
Alla fine degli anni Trenta compaiono le «case
popolarissime», costituite da fabbricati compren-
denti alloggi di una camera, cucina e servizio, di
complessivi 25 mq; il primo complesso di questo
tipo è il « Quartiere 22°» di Via Biglieri denomi-
nato « Le Bulgare» dalla cultura popolare proget-
tato da Umbe rto Cuzzi secondo i dettami del razio-
nalismo torinese e destinato in origine ai profughi
giuliani della guerra '15-18.
L'altro « quartiere » di « popolarissime »
è
il 24°,
ubicato in Via Leoncavallo, edificato nel 1940 e
costruito in linea, in fregio alla via, con corpi di
fabbrica trasversali interni al lotto.
L'estrema povertà dei materiali e delle tecniche
adottate ha provocato un rapido degrado di questi
fabbricati, che hanno dovuto essere risanati negli
anni Settanta. In particolare però il «risanamento»
del « Quartiere 22° »
è
stato un intervento che ne
ha cancellato le connotazioni tipiche e gli elementi
di innovazione culturale e architettonica che con-
teneva.
Terzo periodo: 1945-1957
Dopo la seconda guerra mondiale si registra a
Torino un alto tasso di immigrazione (dal 1945 al
1960 la crescita media è di 25.000 unità l'anno); alla
sostenuta domanda di abitazioni fa riscontro la paral-
lela necessità di creare occupazione per vasti settori
di manodopera poco qualificata. I piani di ricostru-
zione (UNRRA-Casa, Gestione INA-Casa) preve-
dono finanziamenti coordinati per interventi di gros-
so impegno, con programmi costruttivi che investo-
no il territorio metropolitano di Torino; l'orienta-
mento
è
di operare con grossi interventi che occupa-
no ampie aree della periferia urbana — dove più
facile e meno costoso è reperire vaste aree non anco-
ra urbanizzate con l'intento di creare quartieri
autosufficienti » , ovvero provvisti dei servizi di
complemento immediato all'abitazione scuole,
asili, centro religioso, centro commerciale e civico.
L'attività dell'IACP si esplica, oltre che come ope-
ratore diretto di edilizia popolare, anche come sta-
zione appaltante per le realizzazioni affidategli da
altri Enti (Comune, Stato, Gestione INA-Casa). I
modelli di organizzazione di tali complessi, in man-
canza di un valido .strumento pianificatorio (il nuovo
PRGC sarà redatto nel 1959), non sono legati alla
tradizione urbanistica locale, ma vengono derivati
da esperienze nordiche mutuate con istanze locali
(recupero dei valori del borgo rurale). Si fece la
scelta di utilizzare tecnologie tradizionali e «pove-
re», scartando le tecniche di prefabbricazione, e
cercando la qualificazione del prodotto nell'impegno
sociale dei progettisti, scelti per la maggior parte tra
professionisti esterni all'Istituto; questo fatto, uni-
tamente ad una normativa di contenuto più esigen-
ziale che tipologico, ha consentito realizzazioni
ancor oggi interessanti sotto l'aspetto propositivo.
Le due principali iniziative di localizzazione
seguono vaghe indicazioni sul possibile sviluppo di
Torino secondo le direttrici Nord e Sud: il quartiere
Falchera a Nord per 6.000 abitanti, e il quartiere
Mirafiori a Sud per 12.000 abitanti (realizzato negli
anni '60).
Si realizza la Falchera tra il 1954 e il 1958
(archh. Astengo, Molli Boffa, Passanti, Renacco,
Rizzotti) e il quartiere di Lucento tra il 1956 e il
1959 (archh. Astengo, Molli Boffa, Renacco): en-
trambi i complessi sono a carattere semintensivo,
con edifici in linea a 3-5 piani f.t. organizzati per
linee spezzate intorno a vasti spazi liberi, tali da
816


















