
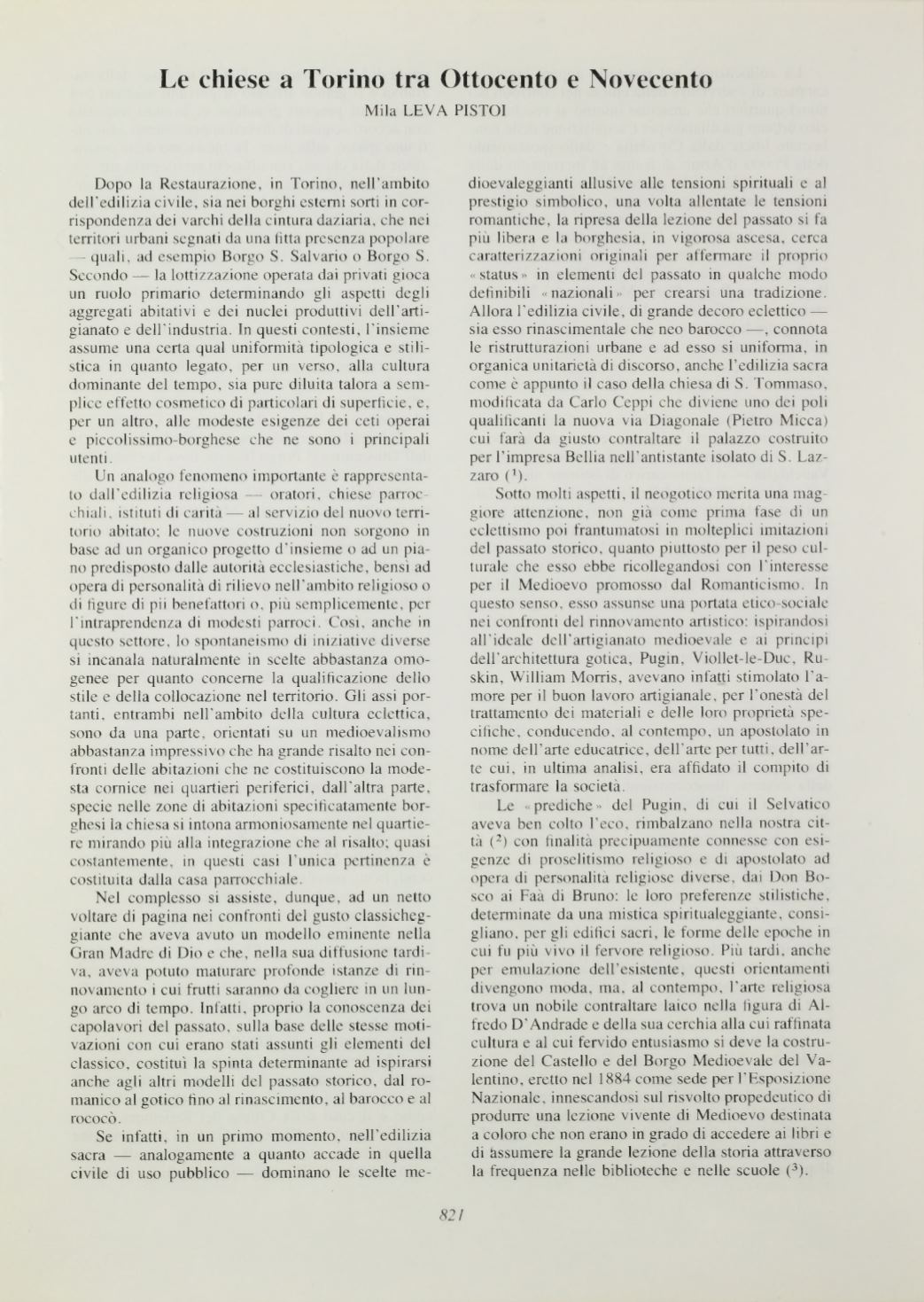
Le chiese a Torino tra Ottocento e Novecento
Mila LEVA PISTOI
Dopo la Restaurazione, in Torino, nell'ambito
dell'edilizia civile, sia nei borghi esterni sorti in cor-
rispondenza dei varchi della cintura daziaria, che nei
territori urbani segnati da una fitta presenza popolare
— quali, ad esempio Borgo S. Salvario o Borgo S.
Secondo — la lottizzazione operata dai privati gioca
un ruolo primario determinando gli aspetti degli
aggregati abitativi e dei nuclei produttivi dell'arti-
gianato e dell'industria. In questi contesti, l'insieme
assume una certa qual uniformità tipologica e stili-
stica in quanto legato, per un verso, alla cultura
dominante del tempo, sia pure diluita talora a sem-
plice effetto cosmetico di particolari di superficie, e,
per un altro, alle modeste esigenze dei ceti operai
e piccolissimo-borghese che ne sono i principali
utenti.
Un analogo fenomeno importante è rappresenta-
to dall'edilizia religiosa — oratori, chiese parroc-
chiali, istituti di carità al servizio del nuovo terri-
torio abitato; le nuove costruzioni non sorgono in
base ad un organico progetto d'insieme o ad un pia-
no predisposto dalle autorità ecclesiastiche, bensì ad
opera di personalità di rilievo nell'ambito religioso o
di figure di pii benefattori o, più semplicemente, per
l'intraprendenza di modesti parroci. Così, anche in
questo settore, lo spontaneismo di iniziative diverse
si incanala naturalmente in scelte abbastanza omo-
genee per quanto concerne la qualificazione dello
stile e della collocazione nel territorio. Gli assi por-
tanti, entrambi nell'ambito della cultura eclettica,
sono da una parte, orientati su un medioevalismo
abbastanza impressivo che ha grande risalto nei con-
fronti delle abitazioni che ne costituiscono la mode-
sta cornice nei quartieri periferici, dall'altra parte,
specie nelle zone di abitazioni specificatamente bor-
ghesi la chiesa si intona armoniosamente nel quartie-
re mirando più alla integrazione che al risalto; quasi
costantemente, in questi casi l'unica pertinenza è
costituita dalla casa parrocchiale.
Nel complesso si assiste, dunque, ad un netto
voltare di pagina nei confronti del gusto classicheg-
giante che aveva avuto un modello eminente nella
Gran Madre di Dio e che, nella sua diffusione tardi-
va, aveva potuto maturare profonde istanze di rin-
novamento i cui frutti saranno da cogliere in un lun-
go arco di tempo. Infatti, proprio la conoscenza dei
capolavori del passato, sulla base delle stesse moti-
vazioni con cui erano stati assunti gli elementi del
classico, costituì la spinta determinante ad ispirarsi
anche agli altri modelli del passato storico, dal ro-
manico al gotico fino al rinascimento, al barocco e al
rococò.
Se infatti, in un primo momento, nell'edilizia
sacra analogamente a quanto accade in quella
civile di uso pubblico dominano le scelte me-
dioevaleggianti allusive alle tensioni spirituali e al
prestigio simbolico, una volta allentate le tensioni
romantiche, la ripresa della lezione del passato si fa
più libera e la borghesia, in vigorosa ascesa, cerca
caratterizzazioni originali per affermare il proprio
« status » in elementi del passato in qualche modo
definibili « nazionali » per crearsi una tradizione.
Allora l'edilizia civile, di grande decoro eclettico
sia esso rinascimentale che neo barocco —, connota
le ristrutturazioni urbane e ad esso si uniforma, in
organica unitarietà di discorso, anche l'edilizia sacra
come è appunto il caso della chiesa di S. Tommaso,
modificata da Carlo Ceppi che diviene uno dei poli
qualificanti la nuova via Diagonale (Pietro Micca)
cui farà da giusto contraltare il palazzo costruito
per l'impresa Bellia nell'antistante isolato di S. Laz-
zaro (
1
).
Sotto molti aspetti, il neogotico merita una mag-
giore attenzione, non già come prima fase di un
eclettismo poi frantumatosi in molteplici imitazioni
del passato storico, quanto piuttosto per il peso cul-
turale che esso ebbe ricollegandosi con l'interesse
per il Medioevo promosso dal Romanticismo. In
questo senso, esso assunse una portata etico-sociale
nei confronti del rinnovamento artistico: ispirandosi
all'ideale dell'artigianato medioevale e ai principi
dell'architettura gotica, Pugin, Viollet-le-Duc, Ru-
skin, William Morris, avevano infatti stimolato l'a-
more per il buon lavoro artigianale, per l'onestà del
trattamento dei materiali e delle loro proprietà spe-
cifiche, conducendo, al contempo, un apostolato in
nome dell'arte educatrice, dell'arte per tutti, dell'ar-
te cui, in ultima analisi, era affidato il compito di
trasformare la società.
Le «prediche» del Pugin, di cui il Selvatico
aveva ben colto l'eco, rimbalzano nella nostra cit-
tà (
2
) con finalità precipuamente connesse con esi-
genze di proselitismo religioso e di apostolato ad
opera di personalità religiose diverse, dai Don Bo-
sco ai Faà di Bruno: le loro preferenze stilistiche,
determinate da una mistica spiritualeggiante, consi-
gliano, per gli edifici sacri, le forme delle epoche in
cui fu più vivo il fervore religioso. Più tardi, anche
per emulazione dell'esistente, questi orientamenti
divengono moda, ma, al contempo, l'arte religiosa
trova un nobile contraltare laico nella figura di Al-
fredo D'Andrade e della sua cerchia alla cui raffinata
cultura e al cui fervido entusiasmo si deve la costru-
zione del Castello e del Borgo Medioevale del Va-
lentino, eretto nel 1884 come sede per l'Esposizione
Nazionale, innescandosi sul risvolto propedeutico di
produrre una lezione vivente di Medioevo destinata
a coloro che non erano in grado di accedere ai libri e
di fssumere la grande lezione della storia attraverso
la frequenza nelle biblioteche e nelle scuole (3).
82 1


















