
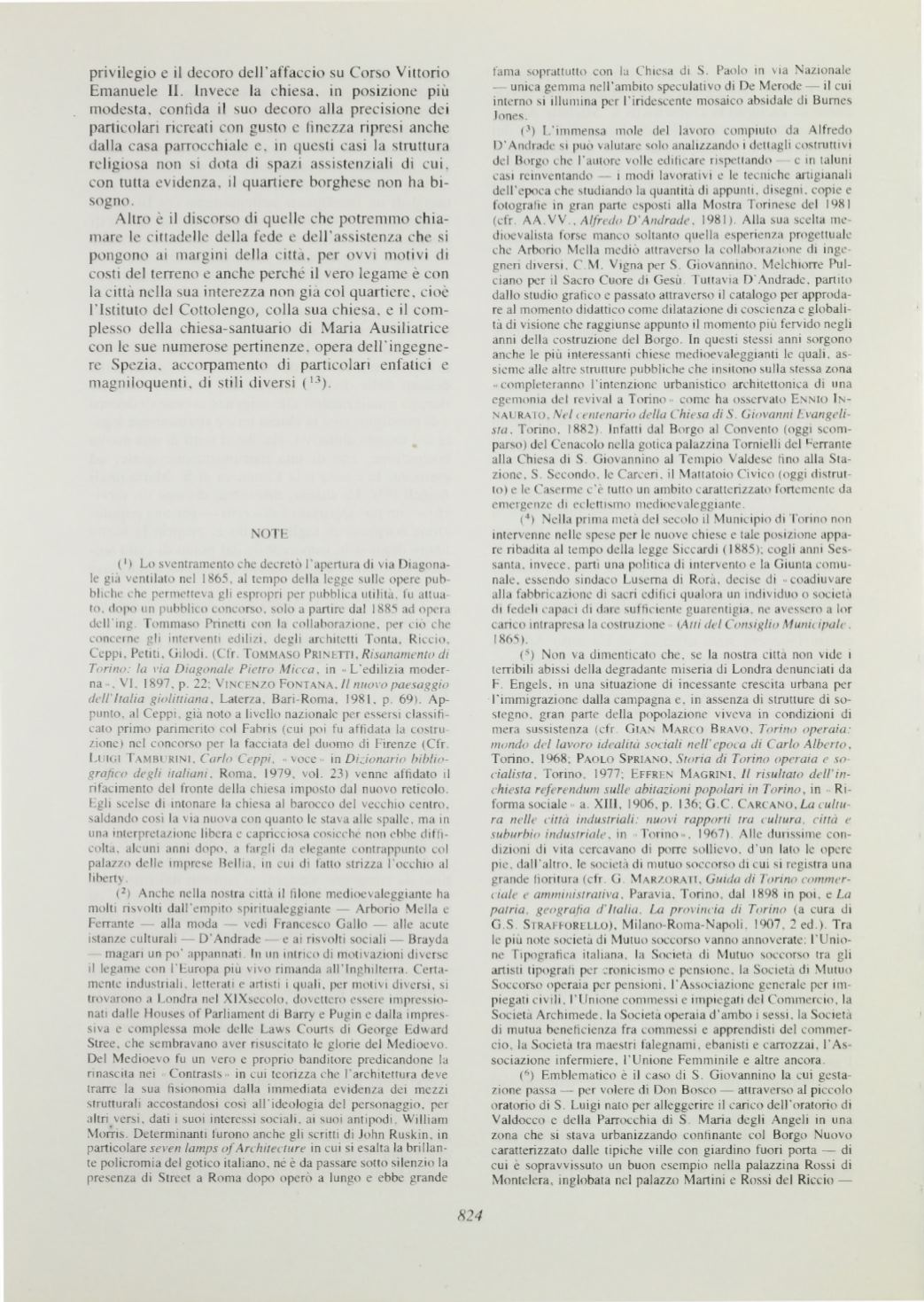
privilegio e il decoro dell'affaccio su Corso Vittorio
Emanuele II. Invece la chiesa, in posizione più
modesta, confida il suo decoro alla precisione dei
particolari ricreati con gusto e finezza ripresi anche
dalla casa parrocchiale e, in questi casi la struttura
religiosa non si dota di spazi assistenziali di cui,
con tutta evidenza, il quartiere borghese non ha bi-
sogno.
Altro
è
il discorso di quelle che potremmo chia-
mare le cittadelle della fede e dell'assistenza che si
pongono ai margini della città, per ovvi motivi di
costi del terreno e anche perché il vero legame
è
con
la città nella sua interezza non già col quartiere, cioè
l'Istituto del Cottolengo, colla sua chiesa, e il com-
plesso della chiesa-santuario di Maria Ausiliatrice
con le sue numerose pertinenze, opera dell'ingegne-
re Spezia, accorpamento di particolari enfatici e
magniloquenti, di stili diversi
(I3)
NOTE
(i) Lo sventramento che decretò l'apertura di via Diagona-
le già ventilato nel 1865, al tempo della legge sulle opere pub-
bliche che permetteva gli espropri per pubblica utilità, fu attua-
to, dopo un pubblico concorso, solo a partire dal 1885 ad opera
dell'ing. Tommaso Prinetti con la collaborazione, per ciò che
concerne gli interventi edilizi, degli architetti Tonta, Riccio,
Ceppi, Petiti, GIlodi. (Cfr. TOMMASO PRINETTI,
Risanamento di
Torino: la via Diagonale Pietro Micca, in «L'edilizia
moder-
na», VI, 1897, p. 22; VINCENZO FONTANA,
il nuovo
paesaggio
dell'Italia giolittiana,
Laterza, Bari-Roma, 1981, p. 69). Ap-
punto, al Ceppi, già noto a livello nazionale per essersi classifi-
cato primo parimerito col Fabris (cui poi fu affidata la costru-
zione) nel concorso per la facciata del duomo di Firenze (Cfr.
LUIGI TAMBURINI,
Carlo Ceppi, «
voce in
Dizionario biblio-
grafico degli italiani,
Roma, 1979, vol. 23) venne affidato
il
rifacimento del fronte della chiesa imposto dal nuovo reticolo.
Egli scelse di intonare la chiesa al barocco del vecchio centro,
saldando così la via nuova con quanto le stava alle spalle, ma
in
una interpretazione libera e capricciosa cosicché non ebbe diffi-
coltà, alcuni anni dopo, a fargli da elegante contrappunto col
palazzo delle imprese Bellia, in cui di fatto strizza l'occhio al
liberty.
(
2
) Anche nella nostra città il filone medioevaleggiante ha
molti risvolti dall'empito spiritualeggiante — Arborio Mella e
Ferrante — alla moda — vedi Francesco Gallo — alle acute
istanze culturali — D'Andrade — e ai risvolti sociali — Brayda
— magari un po' appannati. In un intrico di motivazioni diverse
il legame con l'Europa più vivo rimanda all'Inghilterra. Certa-
mente industriali, letterati e artisti
i
quali, per motivi diversi, si
trovarono a Londra nel XlXsecolo, dovettero essere impressio-
nati dalle Houses of Parliament di Barry e Pugin e dalla impres-
siva e complessa mole delle Laws Cou rts di George Edward
Stree, che sembravano aver risuscitato le glorie del Medioevo.
Del Medioevo fu un vero e proprio banditore predicandone la
rinascita nei «Contrasta» in
cui
teorizza che l'architettura deve
trarre la sua fisionomia dalla immediata evidenza dei mezzi
strutturali accostandosi così all'ideologia del personaggio, per
altri versi, dati i suoi interessi sociali, ai suoi antipodi, William
Morris. Determinanti furono anche gli scritti di John Ruskin, in
particolare
seven tamps of Architecture
in cui si esalta la brillan-
te policromia del gotico italiano, né è da passare sotto silenzio la
presenza di Street a Roma dopo operò a lungo e ebbe grande
fama soprattutto con la Chiesa di S. Paolo in via Nazionale
— unica gemma nell'ambito speculativo di De Merode — il cui
interno si illumina per l'iridescente mosaico absidale di Burnes
Jones.
(3) L'immensa mole del lavoro compiuto da Alfredo
D'Andrade si può valutare solo analizzando i dettagli costruttivi
del Borgo che l'autore volle edificare rispettando — e in taluni
casi reinventando — i modi lavorativi e le tecniche artigianali
dell'epoca che studiando la quantità di appunti, disegni, copie e
fotografie in gran parte esposti alla Mostra Torinese del 1981
(cfr.
AA.VV.,
Alfredo D'Andrade,
1981). Alla sua scelta me-
dioevalista forse manco soltanto quella esperienza progettuale
che Arborio Mella mediò attraverso la collaborazione di inge-
gneri diversi, C.M. Vigna per S. Giovannino, Melchiorre Pul-
ciano per il Sacro Cuore di Gesù. Tuttavia D'Andrade, partito
dallo studio grafico e passato attraverso il catalogo per approda-
re al momento didattico come dilatazione di coscienza e globali-
là di visione che raggiunse appunto il momento più fervido negli
anni della costruzione del Borgo. In questi stessi anni sorgono
anche le più interessanti chiese medioevaleggianti le quali, as-
sieme alle altre strutture pubbliche che insitono sulla stessa zona
completeranno l'intenzione urbanistico architettonica di una
egemonia del revival a Torino» come ha osservato ENNIO IN-
NAURATO,
Nel centenario della Chiesa di S. Giovanni Evangeli-
sta,
Torino, 1882). Infatti dal Borgo al Convento (oggi scom-
parso) del Cenacolo nella gotica palazzina Tornielli del Ferrante
alla Chiesa di S. Giovannino al Tempio Valdese fino alla Sta-
zione, S. Secondo, le Carceri, il Mattatoio Civico (oggi distrut-
to) e le Caserme c'è tutto un ambito caratterizzato fortemente da
emergenze di eclettismo medioevaleggiante.
(4) Nella prima metà del secolo il Municipio di Torino non
intervenne nelle spese per le nuove chiese e tale posizione appa-
re ribadita al tempo della legge Siccardi (1885); cogli anni Ses-
santa, invece, partì una politica di intervento e la Giunta comu-
nale, essendo sindaco Luserna di Rorà, decise di „ coadiuvare
alla fabbricazione di sacri edifici qualora un individuo o società
di fedeli capaci di dare sufficiente guarentigia, ne avessero a lor
carico intrapresa la costruzione
(Atti det Consiglio Municipale,
1865).
(5) Non va dimenticato che, se la nostra città non vide i
terribili abissi della degradante miseria di Londra denunciati da
F. Engels, in una situazione di incessante crescita urbana per
• l'immigrazione dalla campagna e, in assenza di strutture di so-
stegno, gran parte della popolazione viveva in condizioni di
mera sussistenza (cfr. GIAN MARCO BRAVO,
Torino operaia:
mondo del lavoro idealità sociali nell'epoca di Carlo Alberto,
Torino, 1968; PAOLO SPAIANO,
Storia di Torino operaia e so-
cialista,
Torino, 1977; EFFREN MAGRINI,
Il risultato dell'in-
chiesta referendum sulle abitazioni popolari in Torino,
in « Ri-
forma sociale .> a. XIII, 1906, p. 136; G.C. CARCANO,
La cultu-
ra nelte città industriali: nuovi rapporti tra cultura, città e
suburbio industriale,
in « Torino .. , 1967). Alle durissime con-
dizioni di vita cercavano di porre sollievo, d'un lato le opere
pie, dall'altro, le società di mutuo soccorso di cui si registra una
grande fioritura (cfr. G. MARZORATI,
Guida di Torino commer-
ciale e amministrativa,
Paravia, Torino, dal 1898 in poi, e
La
patria, geografia d'Italia, La provincia di Torino
(a cura di
G.S. STRAFFORELLO), Milano-Roma-Napoli. 1907, 2 ed.). Tra
le più note società di Mutuo soccorso vanno annoverate: l'Unio-
ne Tipografica italiana, la Società di Mutuo soccorso tra gli
artisti tipografi per cronicismo e pensione, la Società di Mutuo
Soccorso operaia per pensioni, l'Associazione generale per im-
piegati civili, l'Unione commessi e impiegati del Commercio, la
Società Archimede, la Società operaia d'ambo i sessi, la Società
di mutua beneticienza fra commessi e apprendisti del commer-
cio, la Società tra maestri falegnami, ebanisti e carrozzai, l'As-
sociazione infermiere, l'Unione Femminile e altre ancora.
(6) Emblematico
è
il caso di S. Giovannino la cui gesta-
zione passa — per volere di Don Bosco — attraverso al piccolo
oratorio di S. Luigi nato per alleggerire il carico dell'oratorio di
Valdocco e della Parrocchia di S. Maria degli Angeli in una
zona che si stava urbanizzando confinante col Borgo Nuovo
caratterizzato dalle tipiche ville con giardino fuori porta — di
cui è sopravvissuto un buon esempio nella palazzina Rossi di
Montelera, inglobata nel palazzo Martini e Rossi del Riccio —
824


















