
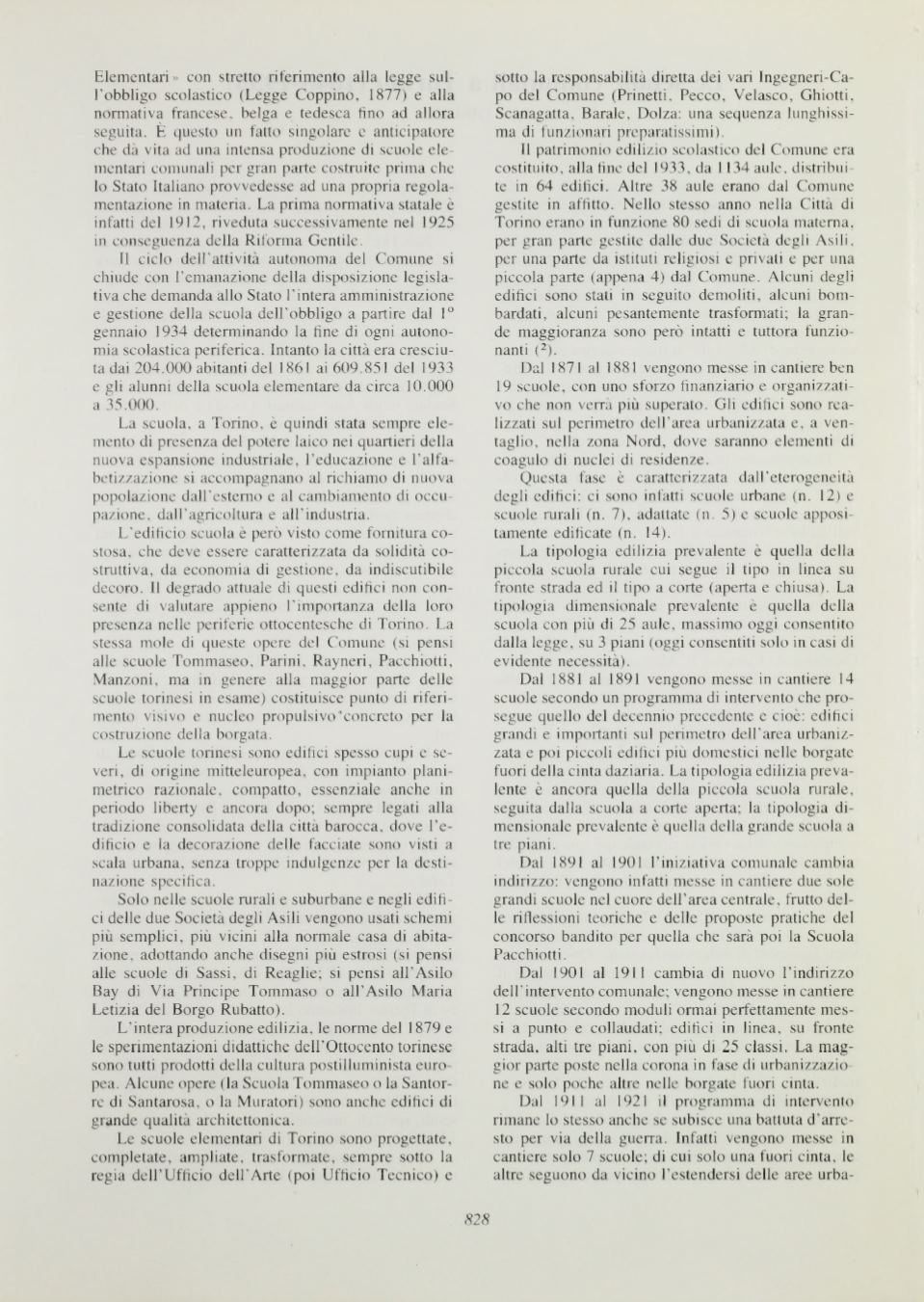
Elementari » con stretto riferimento alla legge sul-
l'obbligo scolastico (Legge Coppino, 1877) e alla
normativa francese, belga e tedesca fino ad allora
seguita. È questo un fatto singolare e anticipatore
che dà vita ad una intensa produzione di scuole ele-
mentari comunali per gran parte costruite prima che
lo Stato Italiano provvedesse ad una propria regola-
mentazione in materia. La prima normativa statale è
infatti del 1912, riveduta successivamente nel 1925
in conseguenza della Riforma Gentile.
Il ciclo dell'attività autonoma del Comune si
chiude con l'emanazione della disposizione legisla-
tiva che demanda allo Stato l'intera amministrazione
e gestione della scuola dell'obbligo a partire dal 1°
gennaio 1934 determinando la fine di ogni autono-
mia scolastica periferica. Intanto la città era cresciu-
ta dai 204.000 abitanti del 1861 ai 609.851 del 1933
e gli alunni della scuola elementare da circa 10.000
a 35.000.
La scuola, a Torino, è quindi stata sempre ele-
mento di presenza del potere laico nei quartieri della
nuova espansione industriale, l'educazione e l'alfa-
betizzazione si accompagnano al richiamo di nuova
popolazione dall'esterno e al cambiamento di occu-
pazione, dall'agricoltura e all'industria.
L'edificio scuola è però visto come fornitura co-
stosa, che deve essere caratterizzata da solidità co-
struttiva, da economia di gestione, da indiscutibile
decoro. Il degrado attuale di questi edifici non con-
sente di valutare appieno l'importanza della loro
presenza nelle periferie ottocentesche di Torino. La
stessa mole di queste opere del Comune (si pensi
alle scuole Tommaseo, Parini, Rayneri, Pacchiotti,
Manzoni, ma in genere alla maggior parte delle
scuole torinesi in esame) costituisce punto di riferi-
mento visivo e nucleo propulsivo'concreto per la
costruzione della borgata.
Le scuole torinesi sono edifici spesso cupi e se-
veri, di origine mitteleuropea, con impianto plani-
metrico razionale, compatto, essenziale anche in
periodo libe
rt
y e ancora dopo; sempre legati alla
tradizione consolidata della città barocca, dove l'e-
dificio e la decorazione delle facciate sono visti a
scala urbana, senza troppe indulgenze per la desti-
nazione specifica.
Solo nelle scuole rurali e suburbane e negli edifi-
ci delle due Società degli Asili vengono usati schemi
più semplici, più vicini alla normale casa di abita-
zione, adottando anche disegni più estrosi (si pensi
alle scuole di Sassi, di Reaglie; si pensi all'Asilo
Bay di Via Principe Tommaso o all'Asilo Maria
Letizia del Borgo Rubatto).
L'intera produzione edilizia, le norme del 1879 e
le sperimentazioni didattiche dell'Ottocento torinese
sono tutti prodotti della cultura postilluminista euro-
pea. Alcune opere (la Scuola Tommaseo o la Santor-
re di Santarosa, o la Muratori) sono anche edifici di
grande qualità architettonica.
Le scuole elementari di Torino sono progettate,
completate, ampliate, trasformate, sempre sotto la
regia dell'Ufficio dell'Arte (poi Ufficio Tecnico) e
sotto la responsabilità diretta dei vari Ingegneri-Ca-
po del Comune (Prinetti, Pecco, Velasco, Ghiotti,
Scanagatta, Barale, Dolza: una sequenza lunghissi-
ma di funzionari preparatissimi).
Il patrimonio edilizio scolastico del Comune era
costituito, alla fine del 1933, da 1134 aule, distribui-
te in 64 edifici. Altre 38 aule erano dal Comune
gestite in affitto. Nello stesso anno nella Città di
Torino erano in funzione 80 sedi di scuola materna,
per gran parte gestite dalle due Società degli Asili,
per una parte da istituti religiosi e privati e per una
piccola parte (appena 4) dal Comune. Alcuni degli
edifici sono stati in seguito demoliti, alcuni bom-
bardati, alcuni pesantemente trasformati; la gran-
de maggioranza sono però intatti e tuttora funzio-
nanti (
2
).
Dal 1871 al 1881 vengono messe in cantiere ben
19 scuole, con uno sforzo finanziario e organizzati-
vo che non verrà più superato. Gli edifici sono rea-
lizzati sul perimetro dell'area urbanizzata e, a ven-
taglio, nella zona Nord, dove saranno elementi di
coagulo di nuclei di residenze.
Questa fase è caratterizzata dall'eterogeneità
degli edifici: ci sono infatti scuole urbane (n. 12) e
scuole rurali (n. 7), adattate (n. 5) e scuole apposi-
tamente edificate (n. 14).
La tipologia edilizia prevalente è quella della
piccola scuola rurale cui segue il tipo in linea su
fronte strada ed il tipo a corte (aperta e chiusa). La
tipologia dimensionale prevalente è quella della
scuola con più di 25 aule, massimo oggi consentito
dalla legge, su 3 piani (oggi consentiti solo in casi di
evidente necessità).
Dal 1881 al 1891 vengono messe in cantiere 14
scuole secondo un programma di intervento che pro-
segue quello del decennio precedente e cioè: edifici
grandi e importanti sul perimetro dell'area urbaniz-
zata e poi piccoli edifici più domestici nelle borgate
fuori della cinta daziaria. La tipologia edilizia preva-
lente è ancora quella della piccola scuola rurale,
seguita dalla scuola a corte aperta; la tipologia di-
mensionale prevalente è quella della grande scuola a
tre piani.
Dal 1891 al 1901 l'iniziativa comunale cambia
indirizzo: vengono infatti messe in cantiere due sole
grandi scuole nel cuore dell'area centrale, frutto del-
le riflessioni teoriche e delle proposte pratiche del
concorso bandito per quella che sarà poi la Scuola
Pacchiotti.
Dal 1901 al 1911 cambia di nuovo l'indirizzo
dell'intervento comunale; vengono messe in cantiere
12 scuole secondo moduli ormai perfettamente mes-
si a punto e collaudati; edifici in linea, su fronte
strada, alti tre piani, con più di 25 classi. La mag-
gior parte poste nella corona in fase di urbanizzazio-
ne e solo poche altre nelle borgate fuori cinta.
Dal 1911 al 1921 il programma di intervento
rimane lo stesso anche se subisce una battuta d'arre-
sto per via della guerra. Infatti vengono messe in
cantiere solo 7 scuole; di cui solo una fuori cinta, le
altre seguono da vicino l'estendersi delle aree urba-
828


















