
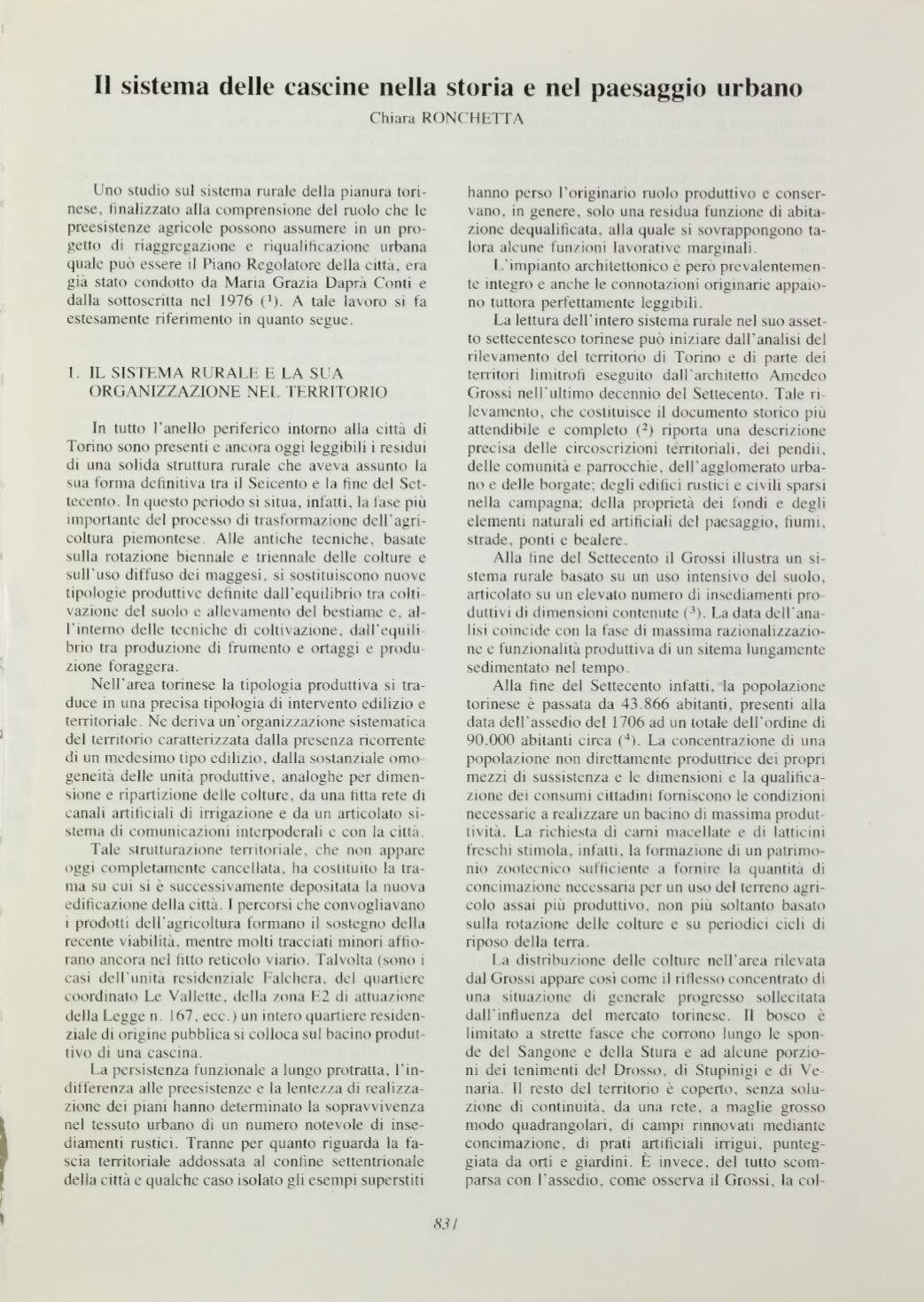
Il sistema delle cascine nella storia e nel paesaggio urbano
Chiara RONCHETTA
Uno studio sul sistema rurale della pianura tori-
nese, finalizzato alla comprensione del ruolo che le
preesistenze agricole possono assumere in un pro-
getto di riaggregazione e riqualificazione urbana
quale può essere il Piano Regolatore della città, era
già stato condotto da Maria Grazia Daprà Conti e
dalla sottoscritta nel 1976 (
1
). A tale lavoro si fa
estesamente riferimento in quanto segue.
1. IL SISTEMA RURALE E LA SUA
ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO
In tutto l'anello periferico intorno alla città di
Torino sono presenti e ancora oggi leggibili i residui
di una solida struttura rurale che aveva assunto la
sua forma definitiva tra il Seicento e la fine del Set-
tecento. In questo periodo si situa, infatti, la fase più
importante del processo di trasformazione dell'agri-
coltura piemontese. Alle antiche tecniche, basate
sulla rotazione biennale e triennale delle colture e
sull'uso diffuso dei maggesi, si sostituiscono nuove
tipologie produttive definite dall'equilibrio tra colti-
vazione del suolo e allevamento del bestiame e, al-
l'interno delle tecniche di coltivazione, dall'equili-
brio tra produzione di frumento e ortaggi e produ-
zione foraggera.
Nell'area torinese la tipologia produttiva si tra-
duce in una precisa tipologia di intervento edilizio e
territoriale. Ne deriva un'organizzazione sistematica
del territorio caratterizzata dalla presenza ricorrente
di un medesimo tipo edilizio, dalla sostanziale omo-
geneità delle unità produttive, analoghe per dimen-
sione e ripartizione delle colture, da una fitta rete di
canali artificiali di irrigazione e da un articolato si-
stema di comunicazioni interpoderali e con la città.
Tale strutturazione territoriale, che non appare
oggi completamente cancellata, ha costituito la tra-
ma su cui si è successivamente depositata la nuova
edificazione della città. I percorsi che convogliavano
i prodotti dell'agricoltura formano il sostegno della
recente viabilità, mentre molti tracciati minori affio-
rano ancora nel fitto reticolo viario. Talvolta (sono i
casi dell'unità residenziale Falchera, del quartiere
coordinato Le Vallette, della zona E2 di attuazione
della Legge n. 167, ecc.) un intero quartiere residen-
ziale di origine pubblica si colloca sul bacino produt-
tivo di una cascina.
La persistenza funzionale a lungo protratta, l'in-
differenza alle preesistenze e la lentezza di realizza-
zione dei piani hanno determinato la sopravvivenza
nel tessuto urbano di un numero notevole di inse-
diamenti rustici. Tranne per quanto riguarda la fa-
scia territoriale addossata al confine settentrionale
della città e qualche caso isolato gli esempi superstiti
hanno perso l'originario ruolo produttivo e conser-
vano, in genere, solo una residua funzione di abita-
zione dequalificata, alla quale si sovrappongono ta-
lora alcune funzioni lavorative marginali.
L'impianto architettonico è però prevalentemen-
te integro e anche le connotazioni originarie appaio-
no tuttora perfettamente leggibili.
La lettura dell'intero sistema rurale nel suo asset-
to settecentesco torinese può iniziare dall'analisi del
rilevamento del territorio di Torino e di parte dei
territori limitrofi eseguito dall'architetto Amedeo
Grossi nell'ultimo decennio del Settecento. Tale ri-
levamento, che costituisce il documento storico più
attendibile e completo (
2
) riporta una descrizione
precisa delle circoscrizioni territoriali, dei pendii,
delle comunità e parrocchie, dell'agglomerato urba-
no e delle borgate; degli edifici rustici e civili sparsi
nella campagna; della proprietà dei fondi e degli
elementi naturali ed artificiali del paesaggio, fiumi,
strade, ponti e bealere.
Alla fine del Settecento il Grossi illustra un si-
stema rurale basato su un uso intensivo del suolo,
articolato su un elevato numero di insediamenti pro-
duttivi di dimensioni contenute (
3
). La data dell'ana-
lisi coincide con la fase di massima razionalizzazio-
ne e funzionalità produttiva di un sitema lungamente
sedimentato nel tempo.
Alla fine del Settecento infatti, la popolazione
torinese è passata da 43.866 abitanti, presenti alla
data dell'assedio del 1706 ad un totale dell'ordine di
90.000 abitanti circa (
4
). La concentrazione di una
popolazione non direttamente produttrice dei propri
mezzi di sussistenza e le dimensioni e la qualifica-
zione dei consumi cittadini forniscono le condizioni
necessarie a realizzare un bacino di massima produt-
tività. La richiesta di carni macellate e di latticini
freschi stimola, infatti, la formazione di un patrimo-
nio zootecnico sufficiente a fornire la quantità di
concimazione necessaria per un uso del terreno agri-
colo assai più produttivo, non più soltanto basato
sulla rotazione delle colture e su periodici cicli di
riposo della terra.
La distribuzione delle colture nell'area rilevata
dal Grossi appare così come il riflesso concentrato di
una situazione di generale progresso sollecitata
dall'influenza del mercato torinese. Il bosco è
limitato a strette fasce che corrono lungo le spon-
de del Sangone e della Stura e ad alcune porzio-
ni dei tenimenti del Drosso, di Stupinigi e di Ve-
naria. Il resto del territorio è coperto, senza solu-
zione di continuità, da una rete, a maglie grosso
modo quadrangolari, di campi rinnovati mediante
concimazione, di prati artificiali irrigui, punteg-
giata da orti e giardini. È invece, del tutto scom-
parsa con l'assedio, come osserva il Grossi, la col-
831


















