
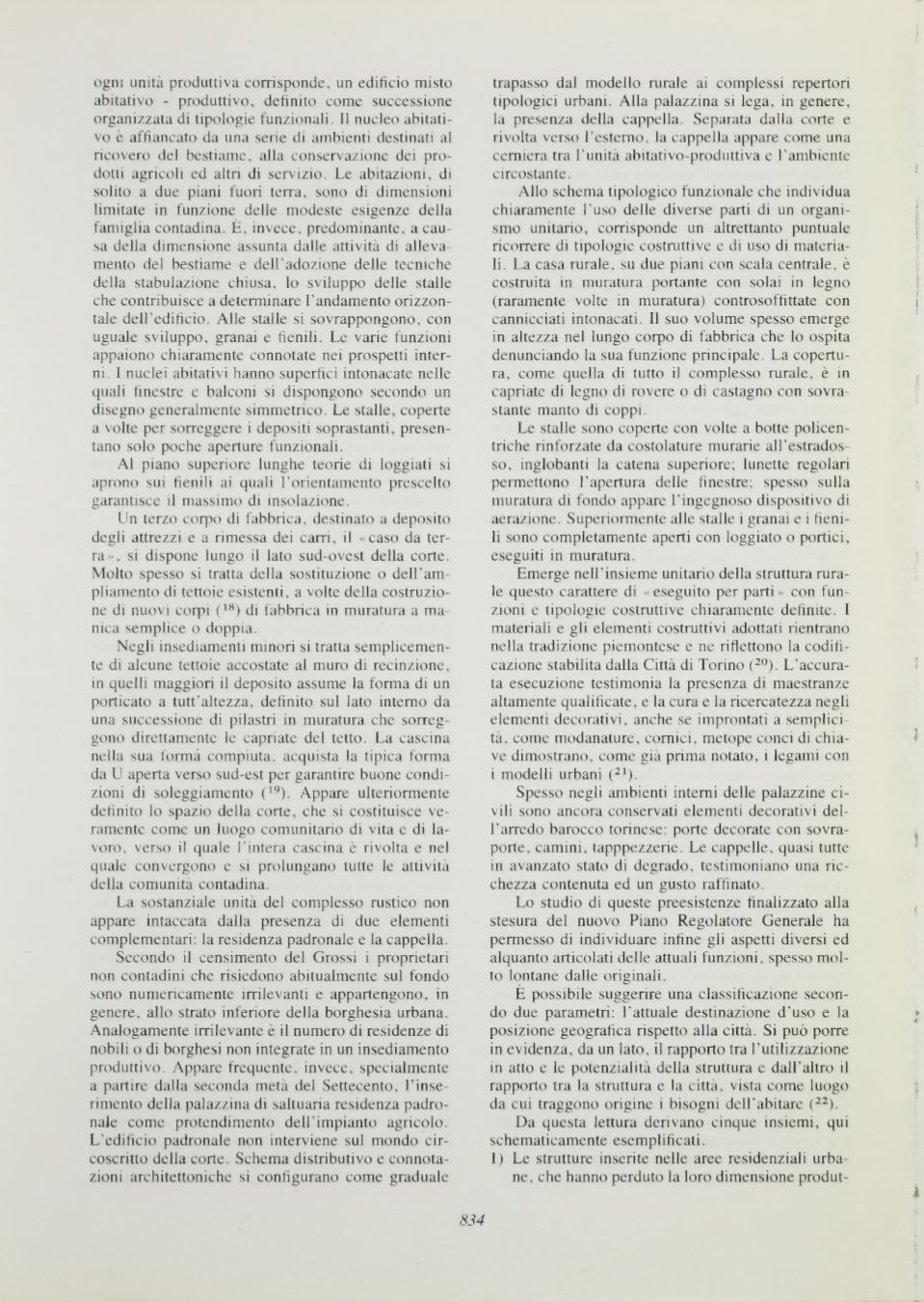
ogni unità produttiva corrisponde, un edificio misto
abitativo - produttivo, definito come successione
organizzata di tipologie funzionali. Il nucleo abitati-
vo è affiancato da una serie di ambienti destinati al
ricovero del bestiame, alla conservazione dei pro-
dotti agricoli ed altri di servizio. Le abitazioni, di
solito a due piani fuori terra, sono di dimensioni
limitate in funzione delle modeste esigenze della
famiglia contadina. È, invece, predominante, a cau-
sa della dimensione assunta dalle attività di alleva-
mento del bestiame e dell'adozione delle tecniche
della stabulazione chiusa, lo sviluppo delle stalle
che contribuisce a determinare l'andamento orizzon-
tale dell'edificio. Alle stalle si sovrappongono, con
uguale sviluppo, granai e fienili. Le varie funzioni
appaiono chiaramente connotate nei prospetti inter-
ni. I nuclei abitativi hanno superfici intonacate nelle
quali finestre e balconi si dispongono secondo un
disegno generalmente simmetrico. Le stalle, coperte
a volte per sorreggere i depositi soprastanti, presen-
tano solo poche aperture funzionali.
Al piano superiore lunghe teorie di loggiati si
aprono sui fienili ai quali l'orientamento prescelto
garantisce il massimo di insolazione.
Un terzo corpo di fabbrica, destinato a deposito
degli attrezzi e a rimessa dei carri, il « caso da ter-
ra», si dispone lungo il lato sud-ovest della corte.
Molto spesso si tratta della sostituzione o dell'am-
pliamento di tettoie esistenti, a volte della costruzio-
ne di nuovi corpi (
18
) di fabbrica in muratura a ma-
nica semplice o doppia.
Negli insediamenti minori si tratta semplicemen-
te di alcune tettoie accostate al muro di recinzione,
in quelli maggiori il deposito assume la forma di un
porticato a tutt'altezza, definito sul lato interno da
una successione di pilastri in muratura che sorreg-
gono direttamente le capriate del tetto. La cascina
nella sua formà compiuta, acquista la tipica forma
da U aperta verso sud-est per garantire buone condi-
zioni di soleggiamento (
19
). Appare ulteriormente
definito lo spazio della corte, che si costituisce ve-
ramente come un luogo comunitario di vita e di la-
voro, verso il quale l'intera cascina è rivolta e nel
quale convergono e si prolungano tutte le attività
della comunità contadina.
La sostanziale unità del complesso rustico non
appare intaccata dalla presenza di due elementi
complementari: la residenza padronale e la cappella.
Secondo il censimento del Grossi i proprietari
non contadini che risiedono abitualmente sul fondo
sono numericamente irrilevanti e appartengono, in
genere, allo strato inferiore della borghesia urbana.
Analogamente irrilevante è il numero di residenze di
nobili o di borghesi non integrate in un insediamento
produttivo. Appare frequente, invece, specialmente
a partire dalla seconda metà del Settecento, l'inse-
rimento della palazzina di saltuaria residenza padro-
nale come protendimento dell'impianto agricolo.
L'edificio padronale non interviene sul mondo cir-
coscritto della corte. Schema distributivo e connota-
zioni architettoniche si configurano come graduale
trapasso dal modello rurale ai complessi repertori
tipologici urbani. Alla palazzina si lega, in genere,
la presenza della cappella. Separata dalla corte e
rivolta verso l'esterno, la cappella appare come una
cerniera tra l'unità abitativo-produttiva e l'ambiente
circostante.
Allo schema tipologico funzionale che individua
chiaramente l'uso delle diverse parti di un organi-
smo unitario, corrisponde un altrettanto puntuale
ricorrere di tipologie costruttive e di uso di materia-
li. La casa rurale, su due piani con scala centrale, è
costruita in muratura portante con solai in legno
(raramente volte in muratura) controsoffittate con
cannicciati intonacati. Il suo volume spesso emerge
in altezza nel lungo corpo di fabbrica che lo ospita
denunciando la sua funzione principale. La copertu-
ra, come quella di tutto il complesso rurale, è in
capriate di legno di rovere o di castagno con sovra-
stante manto di coppi.
Le stalle sono coperte con volte a botte policen-
triche rinforzate da costolature murarie all'estrados-
so, inglobanti la catena superiore; lunette regolari
permettono l'apertura delle finestre; spesso sulla
muratura di fondo appare l'ingegnoso dispositivo di
aerazione. Superiormente alle stalle i granai e i fieni-
li sono completamente aperti con loggiato o portici,
eseguiti in muratura.
Emerge nell'insieme unitario della struttura rura-
le questo carattere di « eseguito per parti » con fun-
zioni e tipologie costruttive chiaramente definite. I
materiali e gli elementi costruttivi adottati rientrano
nella tradizione piemontese e ne riflettono la codifi-
cazione stabilita dalla Città di Torino (
20
). L'accura-
ta esecuzione testimonia la presenza di maestranze
altamente qualificate, e la cura e la ricercatezza negli
elementi decorativi, anche se improntati a semplici-
tà, come modanature, cornici, metope conci di chia-
ve dimostrano, come già prima notato, i legami con
i modelli urbani (
21
).
Spesso negli ambienti interni delle palazzine ci-
vili sono ancora conservati elementi decorativi del-
l'arredo barocco torinese: porte decorate con sovra-
porte, camini, tapppezzerie. Le cappelle, quasi tutte
in avanzato stato di degrado, testimoniano una ric-
chezza contenuta ed un gusto raffinato.
Lo studio di queste preesistenze finalizzato alla
stesura del nuovo Piano Regolatore Generale ha
permesso di individuare infine gli aspetti diversi ed
alquanto articolati delle attuali funzioni, spesso mol-
to lontane dalle originali.
È possibile suggerire una classificazione secon-
do due parametri: l'attuale destinazione d'uso e la
posizione geografica rispetto alla città. Si può porre
in evidenza, da un lato, il rapporto tra l'utilizzazione
in atto e le potenzialità della struttura e dall'altro il
rapporto tra la struttura e la città, vista come luogo
da cui traggono origine i bisogni dell'abitare (22).
Da questa lettura derivano cinque insiemi, qui
schematicamente esemplificati.
1) Le strutture inserite nelle aree residenziali urba-
ne, che hanno perduto la loro dimensione produt-
834


















