
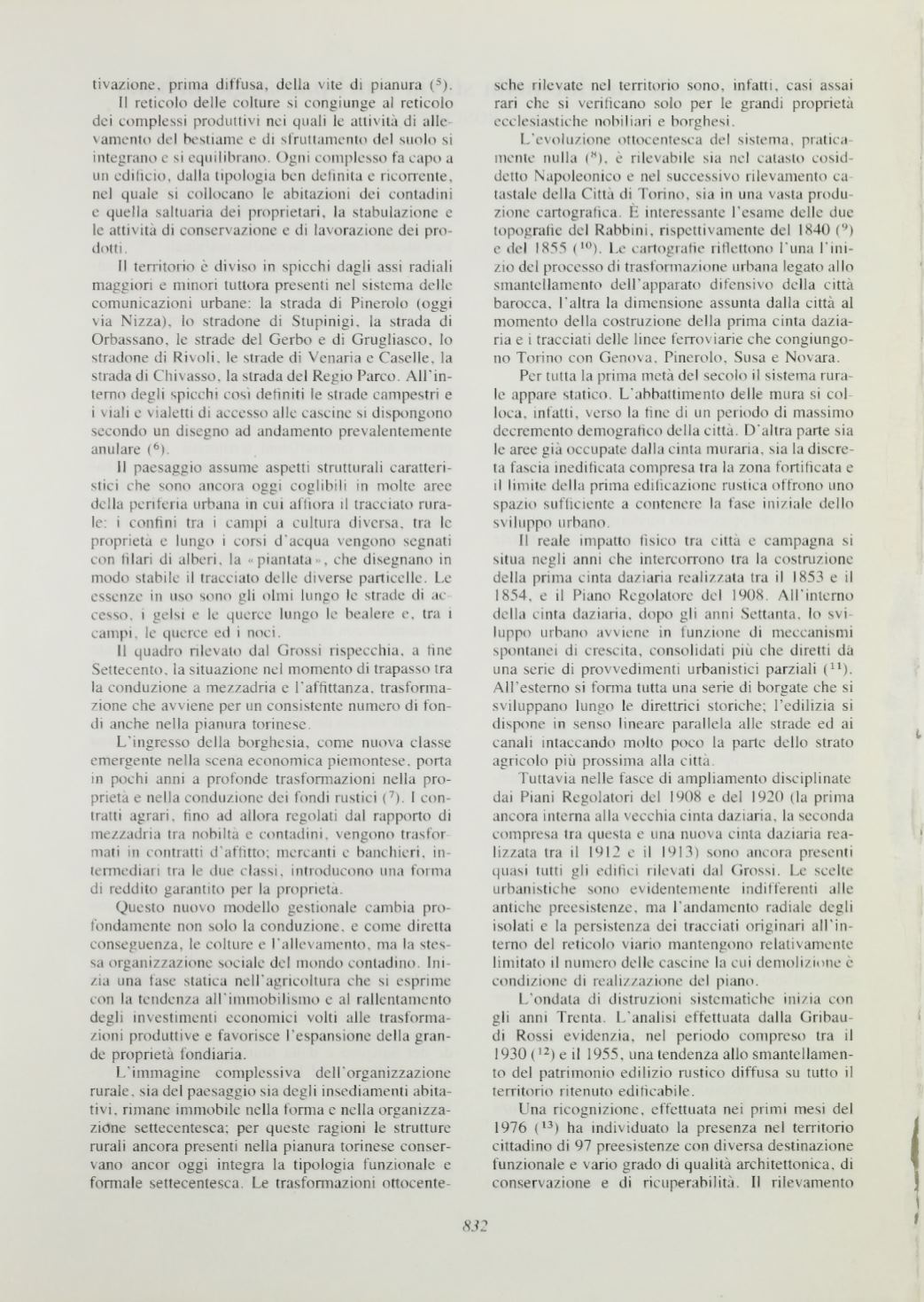
tivazione, prima diffusa, della vite di pianura (
5
).
II reticolo delle colture si congiunge al reticolo
dei complessi produttivi nei quali le attività di alle-
vamento del bestiame e di sfruttamento del suolo si
integrano e si equilibrano. Ogni complesso fa capo a
un edificio, dalla tipologia ben definita e ricorrente,
nel quale si collocano le abitazioni dei contadini
e quella saltuaria dei proprietari, la stabulazione e
le attività di conservazione e di lavorazione dei pro-
dotti.
Il territorio è diviso in spicchi dagli assi radiali
maggiori e minori tuttora presenti nel sistema delle
comunicazioni urbane: la strada di Pinerolo (oggi
via Nizza), lo stradone di Stupinigi, la strada di
Orbassano, le strade del Gerbo e di Grugliasco, lo
stradone di Rivoli, le strade di Venaria e Caselle, la
strada di Chivasso, la strada del Regio Parco. All'in-
terno degli spicchi così definiti le strade campestri e
i viali e vialetti di accesso alle cascine si dispongono
secondo un disegno ad andamento prevalentemente
anulare (
6
).
Il paesaggio assume aspetti strutturali caratteri-
stici che sono ancora oggi coglibili in molte aree
della periferia urbana in cui affiora il tracciato rura-
le: i confini tra i campi a cultura diversa, tra le
proprietà e lungo i corsi d'acqua vengono segnati
con filari di alberi, la «piantata», che disegnano in
modo stabile il tracciato delle diverse particelle. Le
essenze in uso sono gli olmi lungo le strade di ac-
cesso, i gelsi e le querce lungo le bealere e, tra i
campi, le querce ed i noci.
Il quadro rilevato dal Grossi rispecchia, a fine
Settecento, la situazione nel momento di trapasso tra
la conduzione a mezzadria e l'affittanza, trasforma-
zione che avviene per un consistente numero di fon-
di anche nella pianura torinese.
L'ingresso della borghesia, come nuova classe
emergente nella scena economica piemontese, porta
in pochi anni a profonde trasformazioni nella pro-
prietà e nella conduzione dei fondi rustici (
7
). I con-
tratti agrari, fino ad allora regolati dal rapporto di
mezzadria tra nobiltà e contadini, vengono trasfor-
mati in contratti d'affitto; mercanti e banchieri, in-
termediari tra le due classi, introducono una forma
di reddito garantito per la proprietà.
Questo nuovo modello gestionale cambia pro-
fondamente non solo la conduzione, e come diretta
conseguenza, le colture e l'allevamento, ma la stes-
sa organizzazione sociale del mondo contadino. Ini-
zia una fase statica nell'agricoltura che si esprime
con la tendenza all'immobilismo e al rallentamento
degli investimenti economici volti alle trasforma-
zioni produttive e favorisce l'espansione della gran-
de proprietà fondiaria.
L'immagine complessiva dell'organizzazione
rurale, sia del paesaggio sia degli insediamenti abita-
tivi, rimane immobile nella forma e nella organizza-
zione settecentesca; per queste ragioni le strutture
rurali ancora presenti nella pianura torinese conser-
vano ancor oggi integra la tipologia funzionale e
formale settecentesca. Le trasformazioni ottocente-
sche rilevate nel territorio sono, infatti, casi assai
rari che si verificano solo per le grandi proprietà
ecclesiastiche nobiliari e borghesi.
L'evoluzione ottocentesca del sistema, pratica-
mente nulla (
8
), è rilevabile sia nel catasto cosid-
detto Napoleonico e nel successivo rilevamento ca-
tastale della Città di Torino, sia in una vasta produ-
zione cartografica. È interessante l'esame delle due
topografie del Rabbini, rispettivamente del 1840 (
9
)
e del 1855 (
10
). Le cartografie riflettono l'una l'ini-
zio del processo di trasformazione urbana legato allo
smantellamento dell'apparato difensivo della città
barocca, l'altra la dimensione assunta dalla città al
momento della costruzione della prima cinta dazia-
ria e i tracciati delle linee ferroviarie che congiungo-
no Torino con Genova, Pinerolo, Susa e Novara.
Per tutta la prima metà del secolo il sistema rura-
le appare statico. L'abbattimento delle mura si col-
loca, infatti, verso la fine di un periodo di massimo
decremento demografico della città. D'altra parte sia
le aree già occupate dalla cinta muraria, sia la discre-
ta fascia inedificata compresa tra la zona fortificata e
il limite della prima edificazione rustica offrono uno
spazio sufficiente a contenere la fase iniziale dello
sviluppo urbano.
Il reale impatto fisico tra città e campagna si
situa negli anni che intercorrono tra la costruzione
della prima cinta daziaria realizzata tra il 1853 e il
1854, e il Piano Regolatore del 1908. All'interno
della cinta daziaria, dopo gli anni Settanta, lo svi-
luppo urbano avviene in funzione di meccanismi
spontanei di crescita, consolidati più che diretti
dà
una serie di provvedimenti urbanistici parziali (
11
).
All'esterno si forma tutta una serie di borgate che si
sviluppano lungo le direttrici storiche; l'edilizia si
dispone in senso lineare parallela alle strade ed ai
canali intaccando molto poco la parte dello strato
agricolo più prossima alla città.
Tuttavia nelle fasce di ampliamento disciplinate
dai Piani Regolatori del 1908 e del 1920 (la prima
ancora interna alla vecchia cinta daziaria, la seconda
compresa tra questa e una nuova cinta daziaria rea-
lizzata tra il 1912 e il 1913) sono ancora presenti
quasi tutti gli edifici rilevati dal Grossi. Le scelte
urbanistiche sono evidentemente indifferenti alle
antiche preesistenze, ma l'andamento radiale degli
isolati e la persistenza dei tracciati originari all'in-
terno del reticolo viario mantengono relativamente
limitato il numero delle cascine la cui demolizione
è
condizione di realizzazione del piano.
L'ondata di distruzioni sistematiche inizia con
gli anni Trenta. L'analisi effettuata dalla Gribau-
di Rossi evidenzia, nel periodo compreso tra il
1930 (
12
) e il 1955, una tendenza allo smantellamen-
to del patrimonio edilizio rustico diffusa su tutto il
territorio ritenuto edificabile.
Una ricognizione, effettuata nei primi mesi del
1976 (
13
) ha individuato la presenza nel territorio
cittadino di 97 preesistenze con diversa destinazione
funzionale e vario grado di qualità architettonica, di
conservazione e di ricuperabilità. Il rilevamento
832


















