
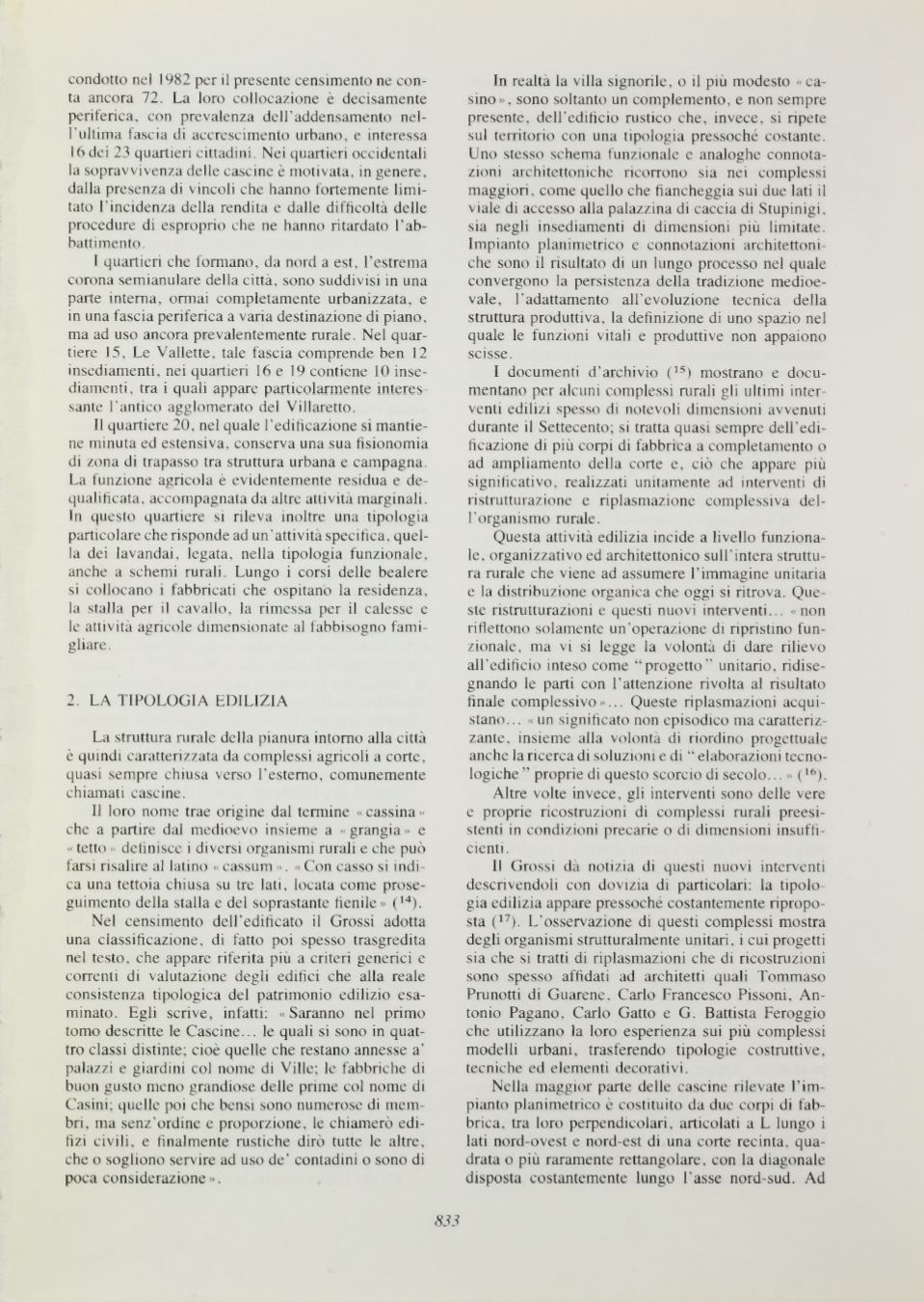
condotto nel 1982 per il presente censimento ne con-
ta ancora 72. La loro collocazione è decisamente
periferica, con prevalenza dell'addensamento nel-
l'ultima fascia di accrescimento urbano, e interessa
16 dei 23 quartieri cittadini. Nei quartieri occidentali
la sopravvivenza delle cascine è motivata, in genere,
dalla presenza di vincoli che hanno fortemente limi-
tato l'incidenza della rendita e dalle difficoltà delle
procedure di esproprio che ne hanno ritardato l'ab-
battimento.
I quartieri che formano, da nord a est, l'estrema
corona semianulare della città, sono suddivisi in una
parte interna, ormai completamente urbanizzata, e
in una fascia periferica a varia destinazione di piano,
ma ad uso ancora prevalentemente rurale. Nel quar-
tiere 15, Le Vallette, tale fascia comprende ben 12
insediamenti, nei quartieri 16 e 19 contiene 10 inse-
diamenti, tra i quali appare particolarmente interes-
sante l'antico agglomerato del Villaretto.
Il quartiere 20, nel quale l'edificazione si mantie-
ne minuta ed estensiva, conserva una sua fisionomia
di zona di trapasso tra struttura urbana e campagna.
La funzione agricola è evidentemente residua e de-
qualificata, accompagnata da altre attività marginali.
In questo quartiere si rileva inoltre una tipologia
particolare che risponde ad un'attività specifica, quel-
la dei lavandai, legata, nella tipologia funzionale,
anche a schemi rurali. Lungo i corsi delle bealere
si collocano i fabbricati che ospitano la residenza,
la stalla per il cavallo, la rimessa per il calesse e
le attività agricole dimensionate al fabbisogno fami-
gliare.
2. LA TIPOLOGIA EDILIZIA
La struttura rurale della pianura intorno alla città
è quindi caratterizzata da complessi agricoli a corte,
quasi sempre chiusa verso l'esterno, comunemente
chiamati cascine.
Il loro nome trae origine dal termine « cassina
»
che a partire dal medioevo insieme a « grangia » e
tetto » definisce i diversi organismi rurali e che può
farsi risalire al latino « cassum » . «Con casso si indi-
ca una tettoia chiusa su tre lati, locata come prose-
guimento della stalla e del soprastante fienile» (14).
Nel censimento dell'edificato il Grossi adotta
una classificazione, di fatto poi spesso trasgredita
nel testo, che appare riferita più a criteri generici
e
correnti di valutazione degli edifici che alla reale
consistenza tipologica del patrimonio edilizio esa-
minato. Egli scrive, infatti: « Saranno nel primo
torno descritte le Cascine... le quali si sono in quat-
tro classi distinte; cioè quelle che restano annesse a'
palazzi e giardini col nome di Ville; le fabbriche di
buon gusto meno grandiose delle prime col nome di
Casini; quelle poi che bensì sono numerose di mem-
bri, ma senz'ordine e proporzione, le chiamerò edi-
fizi civili, e finalmente rustiche dirò tutte le altre,
che o sogliono servire ad uso de' contadini o sono di
poca considerazione » .
In realtà la villa signorile, o il più modesto « ca-
sino », sono soltanto un complemento, e non sempre
presente, dell'edificio rustico che, invece, si ripete
sul territorio con una tipologia pressoché costante.
Uno stesso schema funzionale e analoghe connota-
zioni architettoniche ricorrono sia nei complessi
maggiori, come quello che fiancheggia sui due lati il
viale di accesso alla palazzina di caccia di Stupinigi,
sia negli insediamenti di dimensioni più limitate.
Impianto planimetrico e connotazioni architettoni-
che sono il risultato di un lungo processo nel quale
convergono la persistenza della tradizione medioe-
vale, l'adattamento all'evoluzione tecnica della
struttura produttiva, la definizione di uno spazio nel
quale le funzioni vitali e produttive non appaiono
scisse.
I documenti d'archivio (
15
) mostrano e docu-
mentano per alcuni complessi rurali gli ultimi inter-
venti edilizi spesso di notevoli dimensioni avvenuti
durante il Settecento; si tratta quasi sempre dell'edi-
ficazione di più corpi di fabbrica a completamento o
ad ampliamento della corte e, ciò che appare più
significativo, realizzati unitamente ad interventi di
ristrutturazione e riplasmazione complessiva del-
l'organismo rurale.
Questa attività edilizia incide a livello funziona-
le, organizzativo ed architettonico sull'intera struttu-
ra rurale che viene ad assumere l'immagine unitaria
e la distribuzione organica che oggi si ritrova. Que-
ste ristrutturazioni e questi nuovi interventi... « non
riflettono solamente un'operazione di ripristino fun-
zionale, ma vi si legge la volontà di dare rilievo
all'edificio inteso come "progetto" unitario, ridise-
gnando le parti con l'attenzione rivolta al risultato
finale complessivo»... Queste riplasmazioni acqui-
stano... « un significato non episodico ma caratteriz-
zante, insieme alla volontà di riordino progettuale
anche la ricerca di soluzioni e di " elaborazioni tecno-
logiche" proprie di questo scorcio di secolo...
» (16)
Altre volte invece, gli interventi sono delle vere
e
proprie ricostruzioni di complessi rurali preesi-
stenti in condizioni precarie o di dimensioni insuffi-
cienti.
Il Grossi dà notizia di questi nuovi interventi
descrivendoli con dovizia di particolari: la tipolo-
gia edilizia appare pressoché costantemente ripropo-
sta (
17
). L'osservazione di questi complessi mostra
degli organismi strutturalmente unitari, i cui progetti
sia che si tratti di riplasmazioni che di ricostruzioni
sono spesso affidati ad architetti quali Tommaso
Prunotti di Guarene, Carlo Francesco Pissoni, An-
tonio Pagano, Carlo Gatto e G. Battista Feroggio
che utilizzano la loro esperienza sui più complessi
modelli urbani, trasferendo tipologie costruttive,
tecniche ed elementi decorativi.
Nella maggior parte delle cascine rilevate l'im-
pianto planimetrico
è
costituito da due corpi di fab-
brica, tra loro perpendicolari, articolati a L lungo i
lati nord-ovest e nord-est di una corte recinta, qua-
drata o più raramente rettangolare, con la diagonale
disposta costantemente lungo l'asse nord-sud. Ad
833


















