
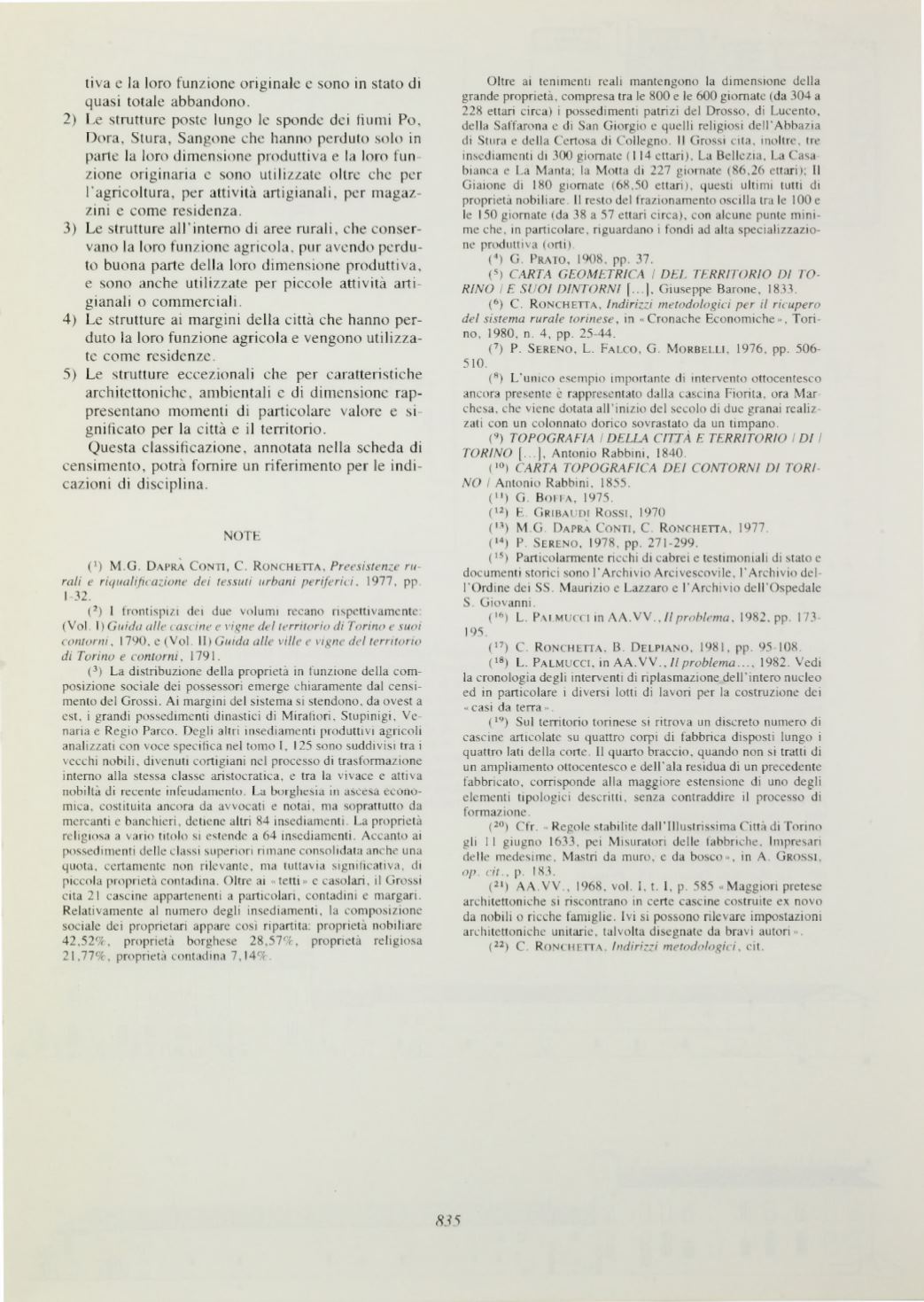
tiva e la loro funzione originale e sono in stato di
quasi totale abbandono.
2) Le strutture poste lungo le sponde dei fiumi Po,
Dora, Stura, Sangone che hanno perduto solo in
parte la loro dimensione produttiva e la loro fun-
zione originaria e sono utilizzate oltre che per
l'agricoltura, per attività artigianali, per magaz-
zini e come residenza.
3) Le strutture all'interno di aree rurali, che conser-
vano la loro funzione agricola, pur avendo perdu-
to buona parte della loro dimensione produttiva,
e sono anche utilizzate per piccole attività arti-
gianali o commerciali.
4) Le strutture ai margini della città che hanno per-
duto la loro funzione agricola e vengono utilizza-
te come residenze.
5) Le strutture eccezionali che per caratteristiche
architettoniche, ambientali e di dimensione rap-
presentano momenti di particolare valore e si-
gnificato per la città e il territorio.
Questa classificazione, annotata nella scheda di
censimento, potrà fornire un riferimento per le indi-
cazioni di disciplina.
NOTE
(1) M.G.
DAPRA CONTI,
C.
RONCHETTA,
Preesistenze ru-
rali
e riqualificazione dei tessuti urbani periferici,
1977, pp.
1-32.
(2) I frontispizi dei due volumi recano rispettivamente:
(Vol.
I) Guida alte cascine e vigne del territorio di Torino e suoi
contorni,
1790, e (Vol. II)
Guida alle ville e vigne del territorio
di Torino e contorni,
1791.
(
3
) La distribuzione della proprietà in funzione della com-
posizione sociale dei possessori emerge chiaramente dal censi-
mento del Grossi. Ai margini del sistema si stendono, da ovest a
est, i grandi possedimenti dinastici di Mirafiori, Stupinigi, Ve-
naria e Regio Parco. Degli altri insediamenti produttivi agricoli
analizzati con voce specifica nel torno 1, 125 sono suddivisi tra i
vecchi nobili, divenuti cortigiani nel processo di trasformazione
interno alla stessa classe aristocratica, e tra la vivace e attiva
nobiltà di recente infeudamento. La borghesia in ascesa econo-
mica, costituita ancora da avvocati e notai, ma soprattutto da
mercanti e banchieri, detiene altri 84 insediamenti. La proprietà
religiosa a vario titolo si estende a 64 insediamenti. Accanto ai
possedimenti delle classi superiori rimane consolidata anche una
quota, certamente non rilevante, ma tuttavia significativa, di
piccola proprietà contadina. Oltre ai «tetti» e casolari, il Grossi
cita 21 cascine appartenenti a particolari, contadini e margari.
Relativamente al numero degli insediamenti, la composizione
sociale dei proprietari appare così ripartita: proprietà nobiliare
42,52%, proprietà borghese 28,57%, proprietà religiosa
21,77%, proprietà contadina 7,14%.
Oltre ai tenimenti reali mantengono la dimensione della
grande proprietà, compresa tra le 800 e le 600 giornate (da 304 a
228 ettari circa) i possedimenti patrizi del Drosso, di Lucento,
della Saffarona e di San Giorgio e quelli religiosi dell'Abbazia
di Stura e della Certosa di Collegno. Il Grossi cita, inoltre, tre
insediamenti di 300 giornate (114 ettari), La Bellezia, La Casa-
bianca e La Manta; fa Motta di 227 giornate (86,26 ettari); Il
Giaione di 180 giornate (68,50 ettari), questi ultimi tutti di
proprietà nobiliare. Il resto del frazionamento oscilla tra le 100 e
le 150 giornate (da 38 a 57 ettari circa), con alcune punte mini-
me che, in particolare, riguardano i fondi ad alta specializzazio-
ne produttiva (orti).
(4) G.
PRATO,
1908, pp. 37.
(5) CARTA GEOMETRICA I DEL TERRITORIO DI TO-
RINO I E SUOI DINTORNI [...],
Giuseppe Barone, 1833.
(6) C.
RONCHETTA,
Indirizzi metodotogici per it ricupero
del sistema rurale torinese,
in «Cronache Economiche., Tori-
no, 1980, n. 4, pp. 25-44.
(7) P.
SERENO,
L.
FALCO,
G.
MORBELLI,
1976, pp. 506-
510.
(8) L'unico esempio importante di intervento ottocentesco
ancora presente è rappresentato dalla cascina Fiorita, ora Mar-
chesa, che viene dotata all'inizio del secolo di due granai realiz-
zati con un colonnato dorico sovrastato da un timpano.
(9) TOPOGRAFIA I DELLA CITTÀ E TERRITORIO I DI I
TORINO [...],
Antonio Rabbini, 1840.
(10) CARTA TOPOGRAFICA DEI CONTORNI DI TORI-
NO I
Antonio Rabbini, 1855.
(11) G.
BOFFA,
1975.
(12) E.
GRIBAUDI
RossI, 1970
(13) M.G.
DAPRA CONTI, C. RONCHETTA,
1977.
(14) P.
SERENO,
1978, pp. 271-299.
(15) Particolarmente ricchi di cabrei e testimoniali di stato e
documenti storici sono l'Archivio Arcivescovile, l'Archivio del-
l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e l'Archivio dell'Ospedale
S. Giovanni.
(16) L.
PALMUCCI
in
AA.VV.,
It problema,
1982, pp. 173-
195.
(17) C.
RONCHETTA,
B.
DELPIANO,
1981, pp. 95-108.
(18) L. PALMuccI, in
AA.VV.,
It problema...,
1982. Vedi
la cronologia degli interventi di riplasmazione dell'intero nucleo
ed in particolare i diversi lotti di lavori per la costruzione dei
«casi da terra».
(19) Sul territorio torinese si ritrova un discreto numero di
cascine articolate su quattro corpi di fabbrica disposti lungo i
quattro lati della corte. Il quarto braccio, quando non si tratti di
un ampliamento ottocentesco e dell'ala residua di un precedente
fabbricato, corrisponde alla maggiore estensione di uno degli
elementi tipologici descritti, senza contraddire il processo di
formazione.
(20) Cfr. „ Regole stabilite dall'Illustrissima Città di Torino
gli I I giugno 1633, pei Misuratori delle fabbriche, Impresari
delle medesime, Mastri da muro, e da bosco», in A.
GRoSsI,
op. cit.,
p. 183.
(21)
AA.VV., 1968, vol. I, t. I, p. 585 «Maggiori pretese
architettoniche si riscontrano in certe cascine costruite ex novo
da nobili o ricche famiglie. Ivi si possono rilevare impostazioni
architettoniche unitarie, tafvolta disegnate da bravi autori..
(22) C.
RONCHETTA.
Indirizzi metodologici, cit.
835


















