
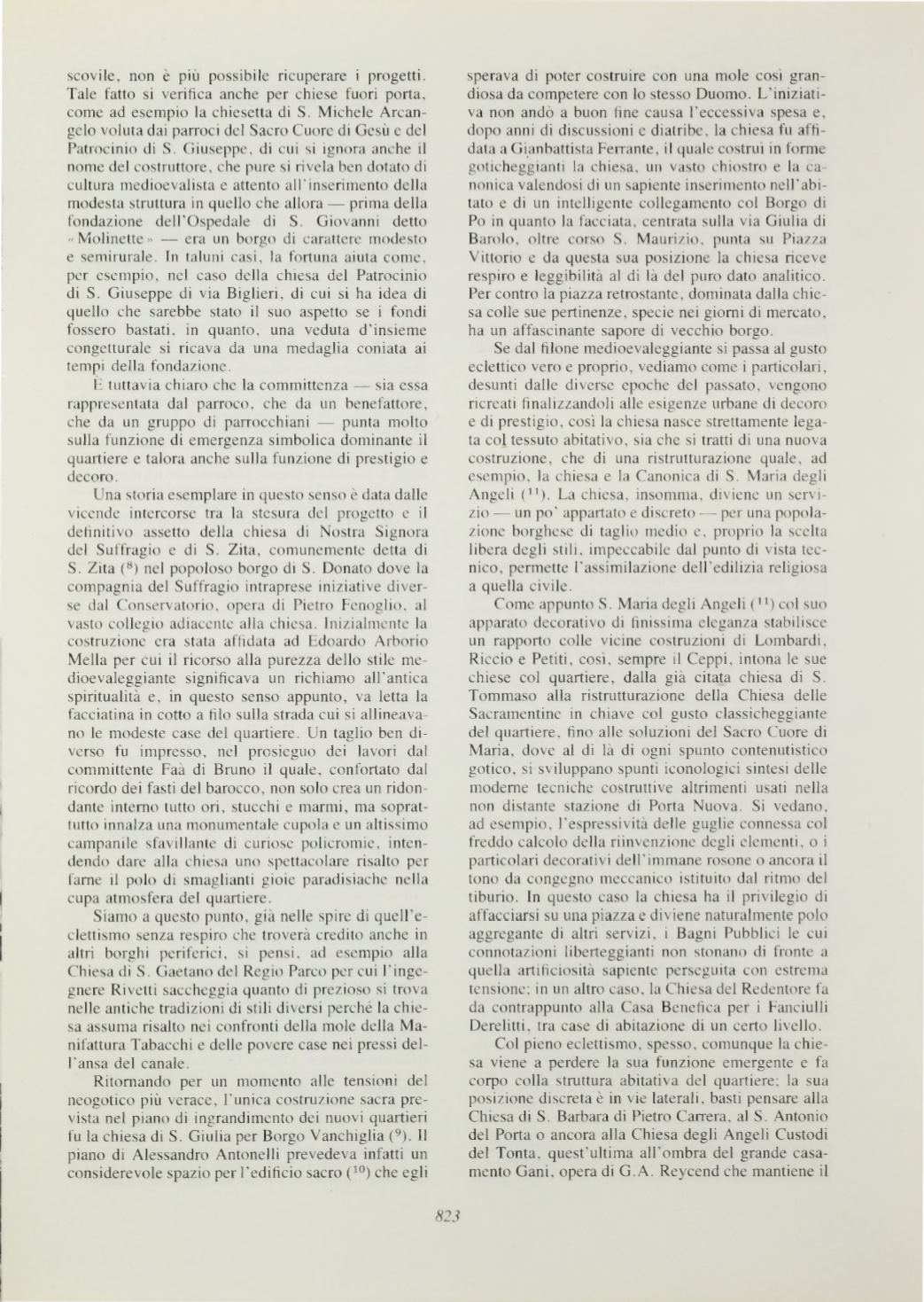
scovile, non è più possibile ricuperare i progetti.
Tale fatto si verifica anche per chiese fuori porta,
come ad esempio la chiesetta di S. Michele Arcan-
gelo voluta dai parroci del Sacro Cuore di Gesù e del
Patrocinio di S. Giuseppe, di cui si ignora anche il
nome del costruttore, che pure si rivela ben dotato
di
cultura medioevalista e attento all'inserimento della
modesta struttura in quello che allora — prima della
fondazione dell'Ospedale di S. Giovanni detto
Molinette » — era un borgo di carattere modesto
e semirurale. In taluni casi, la fortuna aiuta come,
per esempio, nel caso della chiesa del Patrocinio
di S. Giuseppe di via Biglieri, di cui si ha idea di
quello che sarebbe stato il suo aspetto se i fondi
fossero bastati, in quanto, una veduta d'insieme
congetturale si ricava da una medaglia coniata ai
tempi della fondazione.
E tuttavia chiaro che la committenza — sia essa
rappresentata dal parroco, che da un benefattore,
che da un gruppo di parrocchiani punta molto
sulla funzione di emergenza simbolica dominante il
quartiere e talora anche sulla funzione di prestigio e
decoro.
Una storia esemplare in questo senso è data dalle
vicende intercorse tra la stesura del progetto e il
definitivo assetto della chiesa di Nostra Signora
del Suffragio e di S. Zita, comunemente detta di
S. Zita (
8
) nel popoloso borgo di S. Donato dove la
compagnia del Suffragio intraprese iniziative diver-
se dal Conservatorio, opera di Pietro Fenoglio, al
vasto collegio adiacente alla chiesa. Inizialmente la
costruzione era stata affidata ad Edoardo Arborio
Mella per cui il ricorso alla purezza dello stile me-
dioevaleggiante significava un richiamo all'antica
spiritualità e, in questo senso appunto, va letta la
facciatina in cotto a filo sulla strada cui si allineava-
no le modeste case del quartiere. Un taglio ben di-
verso fu impresso, nel prosieguo dei lavori dal
committente Faà di Bruno il quale, confortato dal
ricordo dei fasti del barocco, non solo crea un ridon-
dante interno tutto ori, stucchi e marmi, ma soprat-
tutto innalza una monumentale cupola e un altissimo
campanile sfavillante di curiose policromie, inten-
dendo dare alla chiesa uno spettacolare risalto per
farne il polo di smaglianti gioie paradisiache nella
cupa atmosfera del quartiere.
Siamo a questo punto, già nelle spire di quell'e-
clettismo senza respiro che troverà credito anche in
altri borghi periferici, si pensi, ad esempio alla
Chiesa di S. Gaetano del Regio Parco per cui l'inge-
gnere Rivetti saccheggia quanto di prezioso si trova
nelle antiche tradizioni di stili diversi perché la chie-
sa assuma risalto nei confronti della mole della Ma-
nifattura Tabacchi e delle povere case nei pressi del-
l'ansa del canale.
Ritornando per un momento alle tensioni del
neogotico più verace, l'unica costruzione sacra pre-
vista nel piano di ingrandimento dei nuovi quartieri
fu la chiesa di S. Giulia per Borgo Vanchiglia (
9
). II
piano di Alessandro Antonelli prevedeva infatti un
considerevole spazio per l'edificio sacro (
10
) che egli
sperava di poter costruire con una mole così gran-
diosa da competere con lo stesso Duomo. L'iniziati-
va non andò a buon fine causa l'eccessiva spesa e,
dopo anni di discussioni e diatribe, la chiesa fu affi-
data a Gianbattista Ferrante, il quale costruì in forme
goticheggianti la chiesa, un vasto chiostro e la ca-
nonica valendosi di un sapiente inserimento nell'abi-
tato e di un intelligente collegamento col Borgo di
Po in quanto la facciata, centrata sulla via Giulia di
Barolo, oltre corso S. Maurizio, punta su Piazza
Vittorio e da questa sua posizione la chiesa riceve
respiro e leggibilità al di là del puro dato analitico.
Per contro la piazza retrostante, dominata dalla chie-
sa colle sue pertinenze, specie nei giorni di mercato,
ha un affascinante sapore di vecchio borgo.
Se dal filone medioevaleggiante si passa al gusto
eclettico vero e proprio, vediamo come i particolari,
desunti dalle diverse epoche del passato, vengono
ricreati finalizzandoli alle esigenze urbane di decoro
e di prestigio, così la chiesa nasce strettamente lega-
ta col tessuto abitativo, sia che si tratti di una nuova
costruzione, che di una ristrutturazione quale, ad
esempio, la chiesa e la Canonica di S. Maria degli
Angeli (
11
). La chiesa, insomma, diviene un servi-
zio un po' appartato e discreto — per una popola-
zione borghese di taglio medio e, proprio la scelta
libera degli stili, impeccabile dal punto di vista tec-
nico, permette l'assimilazione dell'edilizia religiosa
a quella civile.
Come appunto S. Maria degli Angeli
(11)
col suo
apparato decorativo di finissima eleganza stabilisce
un rapporto colle vicine costruzioni di Lombardi,
Riccio e Petiti, così, sempre
il
Ceppi, intona le sue
chiese col quartiere, dalla già citata chiesa di S.
Tommaso alla ristrutturazione della Chiesa delle
Sacramentine in chiave col gusto classicheggiante
del quartiere, fino alle soluzioni del Sacro Cuore di
Maria, dove al di là di ogni spunto contenutistico
gotico, si sviluppano spunti iconologici sintesi delle
moderne tecniche costruttive altrimenti usati nella
non distante stazione di Porta Nuova. Si vedano,
ad esempio, l'espressività delle guglie connessa col
freddo calcolo della riinvenzione degli elementi, o i
particolari decorativi dell'immane rosone o ancora il
tono da congegno meccanico istituito dal ritmo del
tiburio. In questo caso la chiesa ha il privilegio di
affacciarsi su una piazza e diviene naturalmente polo
aggregante di altri servizi, i Bagni Pubblici le cui
connotazioni liberteggianti non stonano di fronte a
quella artificiosità sapiente perseguita con estrema
tensione; in un altro caso, la Chiesa del Redentore fa
da contrappunto alla Casa Benefica per i Fanciulli
Derelitti, tra case di abitazione di un certo livello.
Col pieno eclettismo, spesso, comunque la chie-
sa viene a perdere la sua funzione emergente e fa
corpo colla struttura abitativa del quartiere; la sua
posizione discreta è in vie laterali, basti pensare alla
Chiesa di S. Barbara di Pietro Carrera, al S. Antonio
del Porta o ancora alla Chiesa degli Angeli Custodi
del Tonta, quest'ultima all'ombra del grande casa-
mento Gani, opera di G.A. Reycend che mantiene il
823


















