
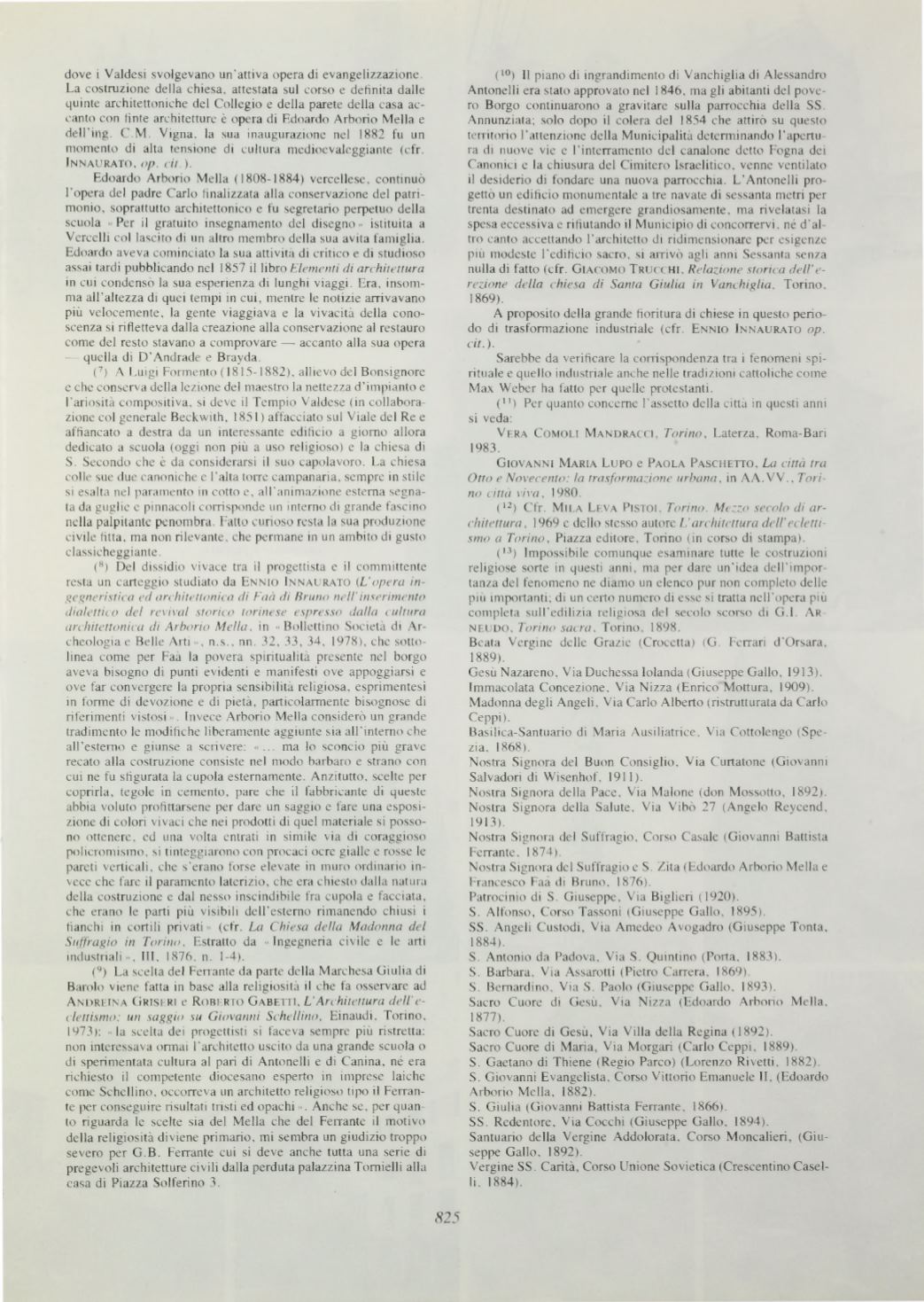
dove i Valdesi svolgevano un'attiva opera di evangelizzazione.
La costruzione della chiesa, attestata sul corso e definita dalle
quinte architettoniche del Collegio e della parete della casa ac-
canto con finte architetture è opera di Edoardo Arborio Mella e
dell'ing. C.M. Vigna, la sua inaugurazione nel 1882 fu un
momento di alta tensione di cultura medioevaleggiante (cfr.
INNAURATO,
op.
cit.).
Edoardo Arborio Mella (1808-1884) vercellese, continuò
l'opera del padre Carlo finalizzata alla conservazione del patri-
monio, soprattutto architettonico e fu segretario perpetuo della
scuola Per il gratuito insegnamento del disegno» istituita a
Vercelli col lascito di un altro membro della sua avita famiglia.
Edoardo aveva cominciato la sua attività di critico e di studioso
assai tardi pubblicando nel 1857 il libro
Elementi di architettura
in
cui condensò la sua esperienza di lunghi viaggi. Era, insom-
ma all'altezza di quei tempi in cui, mentre le notizie arrivavano
più velocemente, la gente viaggiava e la vivacità della cono-
scenza si rifletteva dalla creazione alla conservazione al restauro
come del resto stavano a comprovare — accanto alla sua opera
— quella di D'Andrade e Brayda.
(7) A Luigi Formento (1815-1882), allievo del Bonsignore
e che conserva della lezione del maestro la nettezza d'impianto e
l'ariosità compositiva, si deve il Tempio Valdese (in collabora-
zione col generale Beckwith, 1851) affacciato sul Viale del Re e
affiancato a destra da un interessante edificio a giorno allora
dedicato a scuola (oggi non più a uso religioso) e la chiesa di
S. Secondo che è da considerarsi il suo capolavoro. La chiesa
colle sue due canoniche e l'alta torre campanaria, sempre in stile
si esalta nel paramento in cotto e, all'animazione esterna segna-
ta da guglie e pinnacoli corrisponde un interno di grande fascino
nella palpitante penombra. Fatto curioso resta la sua produzione
civile fitta, ma non rilevante, che permane in un ambito di gusto
classicheggiante.
(8) Del dissidio vivace tra il progettista e il committente
resta un carteggio studiato da ENNIO INNAURATO
(L'opera in-
gegneristica ed architettonica di Faà di Bruno nett'inserimento
dialettico del revival storico torinese espresso datla cultura
architettonica di Arborio Mella,
in Bollettino Società di Ar-
cheologia e Belle Arti », n.s., nn. 32, 33, 34, 1978), che sotto-
linea come per Faà la povera spiritualità presente nel borgo
aveva bisogno di punti evidenti e manifesti ove appoggiarsi e
ove far convergere la propria sensibilità religiosa, esprimentesi
in forme di devozione e di pietà, particolarmente bisognose di
riferimenti vistosi». Invece Arborio Mella considerò un grande
tradimento le modifiche liberamente aggiunte sia all'interno che
all'esterno e giunse a scrivere: « ... ma lo sconcio più grave
recato alla costruzione consiste nel modo barbaro e strano con
cui ne fu sfigurata la cupola esternamente. Anzitutto, scelte per
coprirla, tegole in cemento, pare che il fabbricante di queste
abbia voluto profittarsene per dare un saggio e fare una esposi-
zione di colori vivaci che nei prodotti di quel materiale si posso-
no ottenere, ed una volta entrati in simile via di coraggioso
policromismo, si tinteggiarono con procaci ocre gialle e rosse le
pareti verticali, che s'erano forse elevate in muro ordinario in-
vece che fare il paramento laterizio, che era chiesto dalla natura
della costruzione e dal nesso inscindibile fra cupola e facciata,
che erano le parti più visibili dell'esterno rimanendo chiusi i
fianchi in cortili privati» (cfr.
La Chiesa detla Madonna del
Suffragio in Torino,
Estratto da « Ingegneria civile e le arti
industriali », III, 1876, n. 1-4).
(
9
) La scelta del Ferrante da parte della Marchesa Giulia di
Barolo viene fatta in base alla religiosità il che fa osservare ad
ANDREINA GRISERI e ROBERTO GABETTI,
L'Architettura dell'e-
clettismo: un saggio su Giovanni Schetlino,
Einaudi, Torino,
1973): la scelta dei progettisti si faceva sempre più ristretta:
non interessava ormai l'architetto uscito da una grande scuola o
di sperimentata cultura al pari di Antonelli e di Canina, né era
richiesto il competente diocesano esperto in imprese laiche
come Schellino, occorreva un architetto religioso tipo il Ferran-
te per conseguire risultati tristi ed opachi ». Anche se, per quan-
to riguarda le scelte sia del Mella che del Ferrante il motivo
della religiosità diviene primario, mi sembra un giudizio troppo
severo per G.B. Ferrante cui si deve anche tutta una serie di
pregevoli architetture civili dalla perduta palazzina Tornielli alla
casa di Piazza Solferino 3.
(IO) Il piano di ingrandimento di Vanchiglia di Alessandro
Antonelli era stato approvato nel 1846, ma gli abitanti del pove-
ro Borgo continuarono a gravitare sulla parrocchia della SS.
Annunziata; solo dopo il colera del 1854 che attirò su questo
territorio l'attenzione della Municipalità determinando l'apertu-
ra di nuove vie e l'interramento del canalone detto Fogna dei
Canonici e la chiusura del Cimitero Israelitico, venne ventilato
il desiderio di fondare una nuova parrocchia. L'Antonelli pro-
gettò un edificio monumentale a tre navate di sessanta metri per
trenta destinato ad emergere grandiosamente, ma rivelatasi fa
spesa eccessiva e rifiutando il Municipio di concorrervi, né d'al-
tro canto accettando l'architetto di ridimensionare per esigenze
più modeste l'edificio sacro, si arrivò agli anni Sessanta senza
nulla di fatto (cfr. GIACOMO TRUCCHI,
Retazione storica dell'e-
rezione delta chiesa di Santa Giulia in Vanchiglia,
Torino,
1869).
A proposito della grande fioritura di chiese in questo perio-
do di trasformazione industriale (cfr. ENNIO INNAURATO
op.
cit.).
Sarebbe da verificare la corrispondenza tra i fenomeni spi-
rituale e quello industriale anche nelle tradizioni cattoliche come
Max Weber ha fatto per quelle protestanti.
(11) Per quanto concerne l'assetto della città in questi anni
si veda:
VERA CoMOLI MANDRACCI,
Torino,
Laterza, Roma-Bari
1983.
GIOVANNI MARIA LUPO e PAOLA PASCHETTO,
La città tra
Otto e Novecento: la trasformazione urbana,
in
AA.VV.,
Tori-
no città viva,
1980.
(12) Cfr. MILA LEVA
PlsTol,
Torino. Mezzo secolo di ar-
chitettura,
1969 e dello stesso autore
L'architettura dell'ectetti-
smo a Torino,
Piazza editore, Torino (in corso di stampa).
(
13
) Impossibile comunque esaminare tutte le costruzioni
religiose sorte in questi anni, ma per dare un'idea dell'impor-
tanza del fenomeno ne diamo un elenco pur non completo delle
più importanti; di un certo numero di esse si tratta nell'opera più
completa sull'edilizia religiosa del secolo scorso di G.I. AR-
NEUDO,
Torino sacra,
Torino, 1898.
Beata Vergine delle Grazie (Crocetta) (G. Ferrari d'Orsara,
1889).
Gesù Nazareno, Via Duchessa Iolanda (Giuseppe Gallo, 1913).
Immacolata Concezione, Via Nizza (Enrico Mottura, 1909).
Madonna degli Angeli, Via Carlo Alberto (ristrutturata da Carlo
Ceppi).
Basilica-Santuario di Maria Ausiliatrice, Via Cottolengo (Spe-
zia, 1868).
Nostra Signora del Buon Consiglio, Via Curtatone (Giovanni
Salvadori di Wisenhof, 1911).
Nostra Signora della Pace, Via Malone (don Mossotto, 1892).
Nostra Signora della Salute, Via Vibò 27 (Angelo Reycend,
1913).
Nostra Signora del Suffragio, Corso Casale (Giovanni Battista
Ferrante, 1874).
Nostra Signora del Suffragio e S. Zita (Edoardo Arborio Mella e
Francesco Faà di Bruno, 1876).
Patrocinio di S. Giuseppe, Via Biglieri (1920).
S. Alfonso, Corso Tassoni (Giuseppe Gallo, 1895).
SS. Angeli Custodi, Via Amedeo Avogadro (Giuseppe Tonta,
1884).
S. Antonio da Padova, Via S. Quintino (Porta, 1883).
S. Barbara, Via Assarotti (Pietro Carrera, 1869).
S. Be
rn
ardino, Via S. Paolo (Giuseppe Gallo, 1893).
Sacro Cuore di Gesù, Via Nizza (Edoardo Arborio Mella,
1877).
Sacro Cuore di Gesù, Via Villa della Regina (1892).
Sacro Cuore di Maria, Via Morgari (Carlo Ceppi, 1889).
S. Gaetano di Thiene (Regio Parco) (Lorenzo Rivetti, 1882).
S. Giovanni Evangelista, Corso Vittorio Emanuele II, (Edoardo
Arborio Mella, 1882).
S. Giulia (Giovanni Battista Ferrante, 1866).
SS. Redentore, Via Cocchi (Giuseppe Gallo, 1894).
Santuario della Vergine Addolorata, Corso Moncalieri, (Giu-
seppe Gallo, 1892).
Vergine SS. Carità, Corso Unione Sovietica (Crescentino Casel-
li, 1884).
825


















