
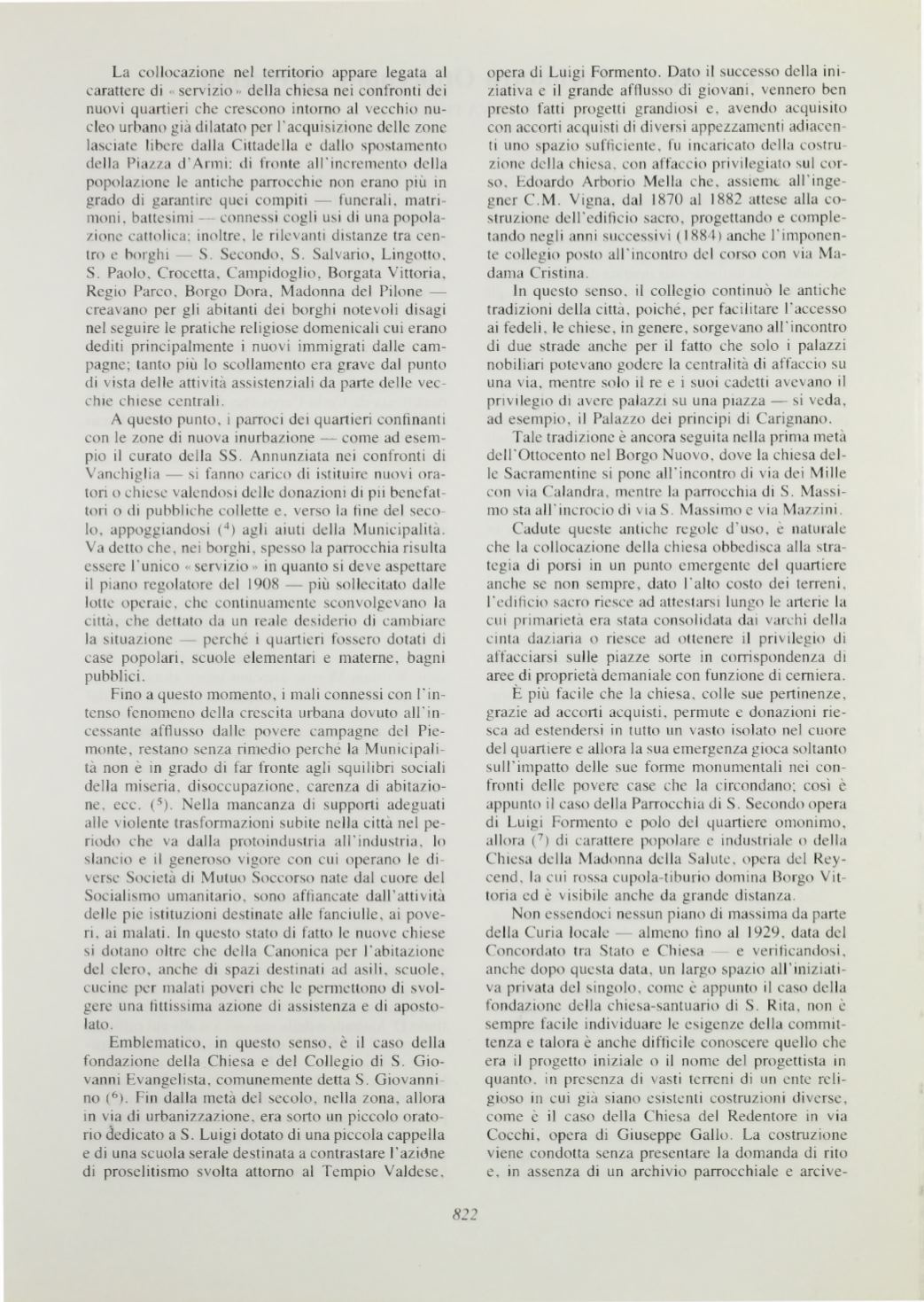
La collocazione nel territorio appare legata al
carattere di « servizio » della chiesa nei confronti dei
nuovi quartieri che crescono intorno al vecchio nu-
cleo urbano già dilatato per l'acquisizione delle zone
lasciate libere dalla Cittadella e dallo spostamento
della Piazza d'Armi: di fronte all'incremento della
popolazione le antiche parrocchie non erano più in
grado di garantire quei compiti funerali, matri-
moni, battesimi — connessi cogli usi di una popola-
zione cattolica; inoltre, le rilevanti distanze tra cen-
tro e borghi — S. Secondo, S. Salvano, Lingotto,
S. Paolo, Crocetta, Campidoglio, Borgata Vittoria,
Regio Parco, Borgo Dora, Madonna del Pilone
creavano per gli abitanti dei borghi notevoli disagi
nel seguire le pratiche religiose domenicali cui erano
dediti principalmente i nuovi immigrati dalle cam-
pagne; tanto più lo scollamento era grave dal punto
di vista delle attività assistenziali da parte delle vec-
chie chiese centrali.
A questo punto,
i
parroci dei quartieri confinanti
con le zone di nuova inurbazione — come ad esem-
pio il curato della SS. Annunziata nei confronti di
Vanchiglia si fanno carico di istituire nuovi ora-
tori o chiese valendosi delle donazioni di pii benefat-
tori o di pubbliche collette e, verso la fine del seco-
lo, appoggiandosi (
4
) agli aiuti della Municipalità.
Va detto che, nei borghi, spesso la parrocchia risulta
essere l'unico « servizio » in quanto si deve aspettare
il piano regolatore del 1908 più sollecitato dalle
lotte operaie, che continuamente sconvolgevano la
città, che dettato da un reale desiderio di cambiare
la situazione perché i quartieri fossero dotati di
case popolari, scuole elementari e materne, bagni
pubblici.
Fino a questo momento, i mali connessi con l'in-
tenso fenomeno della crescita urbana dovuto all'in-
cessante afflusso dalle povere campagne del Pie-
monte, restano senza rimedio perché la Municipali-
tà non
è
in grado di far fronte agli squilibri sociali
della miseria, disoccupazione, carenza di abitazio-
ne, ecc. (
5
). Nella mancanza di supporti adeguati
alle violente trasformazioni subite nella città nel pe-
riodo che va dalla protoindustria all'industria, lo
slancio e il generoso vigore con cui operano le di-
verse Società di Mutuo Soccorso nate dal cuore del
Socialismo umanitario, sono affiancate dall'attività
delle pie istituzioni destinate alle fanciulle, ai pove-
ri, ai malati. In questo stato di fatto le nuove chiese
si dotano oltre che della Canonica per l'abitazione
del clero, anche di spazi destinati ad asili, scuole,
cucine per malati poveri che le permettono di svol-
gere una fittissima azione di assistenza e di aposto-
lato.
Emblematico, in questo senso, è il caso della
fondazione della Chiesa e del Collegio di S. Gio-
vanni Evangelista, comunemente detta S. Giovanni-
no (
6
). Fin dalla metà del secolo, nella zona, allora
in via di urbanizzazione, era sorto un piccolo orato-
rio dedicato a S. Luigi dotato di una piccola cappella
e di una scuola serale destinata a contrastare l'azidne
di proselitismo svolta attorno al Tempio Valdese,
opera di Luigi Formento. Dato il successo della ini-
ziativa e il grande afflusso di giovani, vennero ben
presto fatti progetti grandiosi e, avendo acquisito
con accorti acquisti di diversi appezzamenti adiacen-
ti uno spazio sufficiente, fu incaricato della costru-
zione della chiesa, con affaccio privilegiato sul cor-
so, Edoardo Arborio Mella che, assieme all'inge-
gner C.M. Vigna, dal I870 al 1882 attese alla co-
struzione dell'edificio sacro, progettando e comple-
tando negli anni successivi (1884) anche l'imponen-
te collegio posto all'incontro del corso con via Ma-
dama Cristina.
In questo senso, il collegio continuò le antiche
tradizioni della città, poiché, per facilitare l'accesso
ai fedeli, le chiese, in genere, sorgevano all'incontro
di due strade anche per il fatto che solo i palazzi
nobiliari potevano godere la centralità di affaccio su
una via, mentre solo il re e i suoi cadetti avevano il
privilegio di avere palazzi su una piazza — si veda,
ad esempio, il Palazzo dei principi di Carignano.
Tale tradizione è ancora seguita nella prima metà
dell'Ottocento nel Borgo Nuovo, dove la chiesa del-
le Sacramentine si pone all'incontro di via dei Mille
con via Calandra, mentre la parrocchia di S. Massi-
mo sta all'incrocio di via S. Massimo e via Mazzini.
Cadute queste antiche regole d'uso, è naturale
che la collocazione della chiesa obbedisca alla stra-
tegia di porsi in un punto emergente del quartiere
anche se non sempre, dato l'alto costo dei terreni,
l'edificio sacro riesce ad attestarsi lungo le arterie la
cui primarietà era stata consolidata dai varchi della
cinta daziaria o riesce ad ottenere il privilegio di
affacciarsi sulle piazze sorte in corrispondenza di
aree di proprietà demaniale con funzione di cerniera.
È più facile che la chiesa, colle sue pertinenze,
grazie ad accorti acquisti, permute e donazioni rie-
sca ad estendersi
in
tutto un vasto isolato nel cuore
del quartiere e allora la sua emergenza gioca soltanto
sull'impatto delle sue forme monumentali nei con-
fronti delle povere case che la circondano; così è
appunto il caso della Parrocchia di S. Secondo opera
di Luigi Formento e polo del quartiere omonimo,
allora (
7
) di carattere popolare e industriale o della
Chiesa della Madonna della Salute, opera del Rey-
cend, la cui rossa cupola-tiburio domina Borgo Vit-
toria ed è visibile anche da grande distanza.
Non essendoci nessun piano di massima da parte
della Curia locale almeno fino al 1929, data del
Concordato tra Stato e Chiesa e verificandosi,
anche dopo questa data, un largo spazio all'iniziati-
va privata del singolo, come è appunto il caso della
fondazione della chiesa-santuario di S. Rita, non è
sempre facile individuare le esigenze della commit-
tenza e talora è anche difficile conoscere quello che
era il progetto iniziale o il nome del progettista in
quanto, in presenza di vasti terreni di un ente reli-
gioso in cui già siano esistenti costruzioni diverse,
come è il caso della Chiesa del Redentore in via
Cocchi, opera di Giuseppe Gallo. La costruzione
viene condotta senza presentare la domanda di rito
e, in assenza di un archivio parrocchiale e arcive-
822


















