
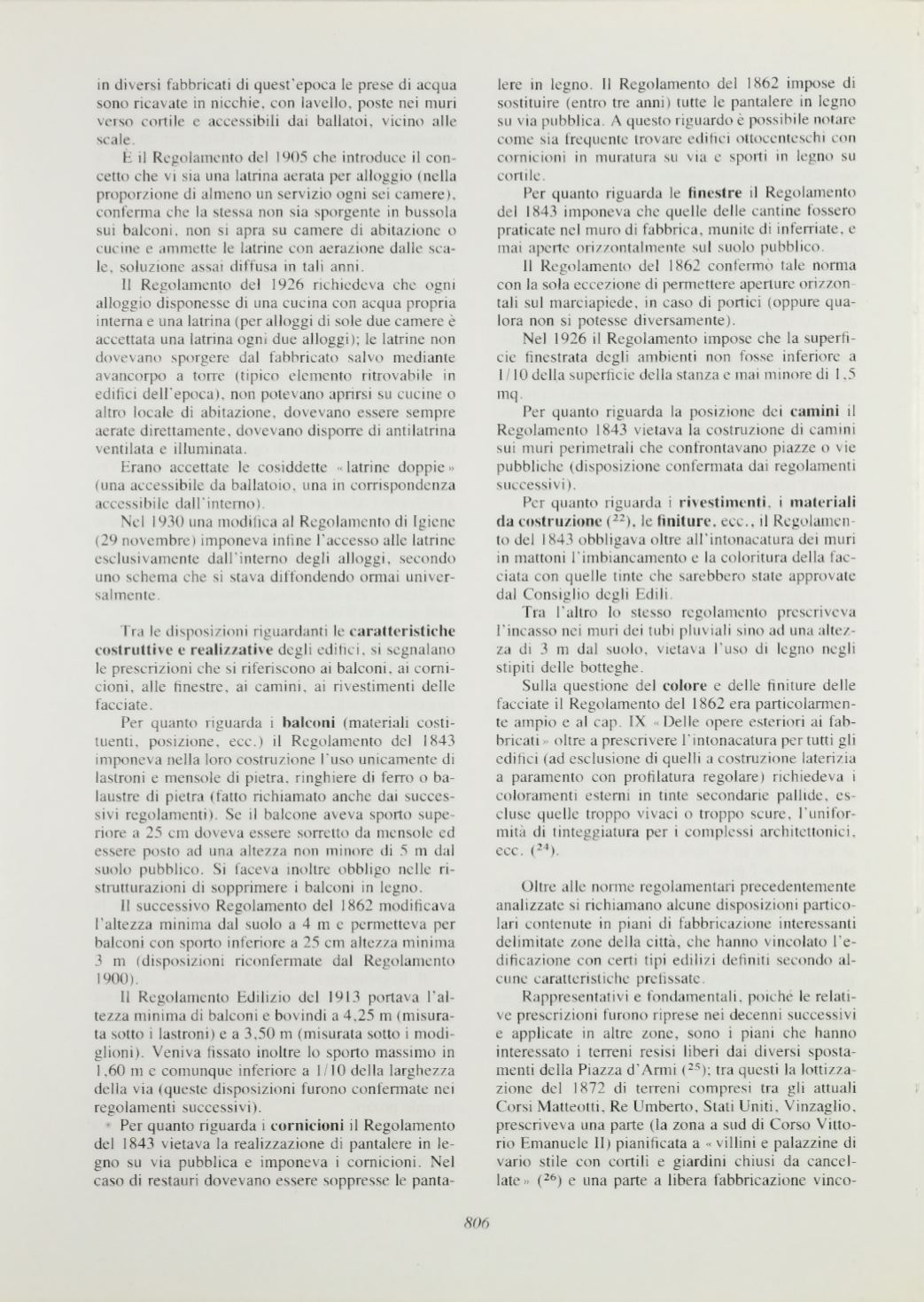
in diversi fabbricati di quest'epoca le prese di acqua
sono ricavate in nicchie, con lavello, poste nei muri
verso cortile e accessibili dai ballatoi, vicino alle
scale.
È il Regolamento del 1905 che introduce il con-
cetto che vi sia una latrina aerata per alloggio (nella
proporzione di almeno un servizio ogni sei camere),
conferma che la stessa non sia sporgente in bussola
sui balconi, non si apra su camere di abitazione o
cucine e ammette le latrine con aerazione dalle sca-
le, soluzione assai diffusa in tali anni.
Il Regolamento del 1926 richiedeva che ogni
alloggio disponesse di una cucina con acqua propria
interna e una latrina (per alloggi di sole due camere è
accettata una latrina ogni due alloggi); le latrine non
dovevano sporgere dal fabbricato salvo mediante
avancorpo a torre (tipico elemento ritrovabile in
edifici dell'epoca), non potevano aprirsi su cucine o
altro locale di abitazione, dovevano essere sempre
aerate direttamente, dovevano disporre di antilatrina
ventilata e illuminata.
Erano accettate le cosiddette « latrine doppie
(una accessibile da ballatoio, una in corrispondenza
accessibile dall'interno).
Nel 1930 una modifica al Regolamento di Igiene
(29 novembre) imponeva infine l'accesso alle latrine
esclusivamente dall'interno degli alloggi, secondo
uno schema che si stava diffondendo ormai univer-
salmente.
Tra le disposizioni riguardanti le
caratteristiche
costruttive e realizzative
degli edifici, si segnalano
le prescrizioni che si riferiscono ai balconi, ai corni-
cioni, alle finestre, ai camini, ai rivestimenti delle
facciate.
Per quanto riguarda
i
balconi
(materiali costi-
tuenti, posizione, ecc.) il Regolamento del 1843
imponeva nella loro costruzione l'uso unicamente di
lastroni e mensole di pietra, ringhiere di ferro o ba-
laustre di pietra (fatto richiamato anche dai succes-
sivi regolamenti). Se il balcone aveva sporto supe-
riore a 25 cm doveva essere sorretto da mensole ed
essere posto ad una altezza non minore di 5 m dal
suolo pubblico. Si faceva inoltre obbligo nelle ri-
strutturazioni di sopprimere i balconi in legno.
Il successivo Regolamento del 1862 modificava
l'altezza minima dal suolo a 4 m e permetteva per
balconi con sporto inferiore a 25 cm altezza minima
3 m (disposizioni riconfermate dal Regolamento
1900) .
Il Regolamento Edilizio del 1913 portava l'al-
tezza minima di balconi e bovindi a 4,25 m (misura-
ta sotto i lastroni) e a 3,50 m (misurata sotto i modi-
glioni). Veniva fissato inoltre lo sporto massimo in
1,60 m e comunque inferiore a 1/10 della larghezza
della via (queste disposizioni furono confermate nei
regolamenti successivi).
• Per quanto riguarda i
cornicioni
il Regolamento
del 1843 vietava la realizzazione di pantalere in le-
gno su via pubblica e imponeva i cornicioni. Nel
caso di restauri dovevano essere soppresse le panta-
lere in legno. Il Regolamento del 1862 impose di
sostituire (entro tre anni) tutte le pantalere in legno
su via pubblica. A questo riguardo è possibile notare
come sia frequente trovare edifici ottocenteschi con
cornicioni in muratura su via e sporti in legno su
cortile.
Per quanto riguarda le
finestre
il Regolamento
del 1843 imponeva che quelle delle cantine fossero
praticate nel muro di fabbrica, munite di inferriate, e
mai aperte orizzontalmente sul suolo pubblico.
Il Regolamento del 1862 confermò tale norma
con la sola eccezione di permettere aperture orizzon-
tali sul marciapiede, in caso di portici (oppure qua-
lora non si potesse diversamente).
Nel 1926 il Regolamento impose che la superfi-
cie finestrata degli ambienti non fosse inferiore a
1/10 della superficie della stanza e mai minore di 1,5
mq.
Per quanto riguarda la posizione dei
camini
il
Regolamento 1843 vietava la costruzione di camini
sui muri perimetrali che confrontavano piazze o vie
pubbliche (disposizione confermata dai regolamenti
successivi).
Per quanto riguarda i
rivestimenti,
i
materiali
da costruzione (
22
), le finiture,
ecc., il Regolamen-
to del 1843 obbligava oltre all'intonacatura dei muri
in mattoni l' imbiancamento e la coloritura della fac-
ciata con quelle tinte che sarebbero state approvate
dal Consiglio degli Edili.
Tra l'altro lo stesso regolamento prescriveva
l'incasso nei muri dei tubi pluviali sino ad una altez-
za di 3 m dal suolo, vietava l'uso di legno negli
stipiti delle botteghe.
Sulla questione del
colore
e
delle finiture delle
facciate il Regolamento del 1862 era particolarmen-
te ampio e al cap.
IX «
Delle opere esteriori ai fab-
bricati oltre a prescrivere l'intonacatura per tutti gli
edifici (ad esclusione di quelli a costruzione laterizia
a paramento con profilatura regolare) richiedeva i
coloramenti esterni in tinte secondarie pallide, es-
cluse quelle troppo vivaci o troppo scure, l'unifor-
mità di tinteggiatura per i complessi architettonici,
ecc. (
24
).
Oltre alle norme regolamentari precedentemente
analizzate si richiamano alcune disposizioni partico-
lari contenute in piani di fabbricazione interessanti
delimitate zone della città, che hanno vincolato l'e-
dificazione con certi tipi edilizi definiti secondo al-
cune caratteristiche prefissate.
Rappresentativi e fondamentali, poiché le relati-
ve prescrizioni furono riprese nei decenni successivi
e applicate in altre zone, sono i piani che hanno
interessato i terreni resisi liberi dai diversi sposta-
menti della Piazza d'Armi (
25
); tra questi la lottizza-
zione del
1872
di terreni compresi tra gli attuali
Corsi Matteotti, Re Umbe
rt
o, Stati Uniti, Vinzaglio,
prescriveva una parte (la zona a sud di Corso Vitto-
rio Emanuele II) pianificata a « villini e palazzine di
vario stile con cortili e giardini chiusi da cancel-
late « (
26
) e una parte a libera fabbricazione vinco-
806


















