
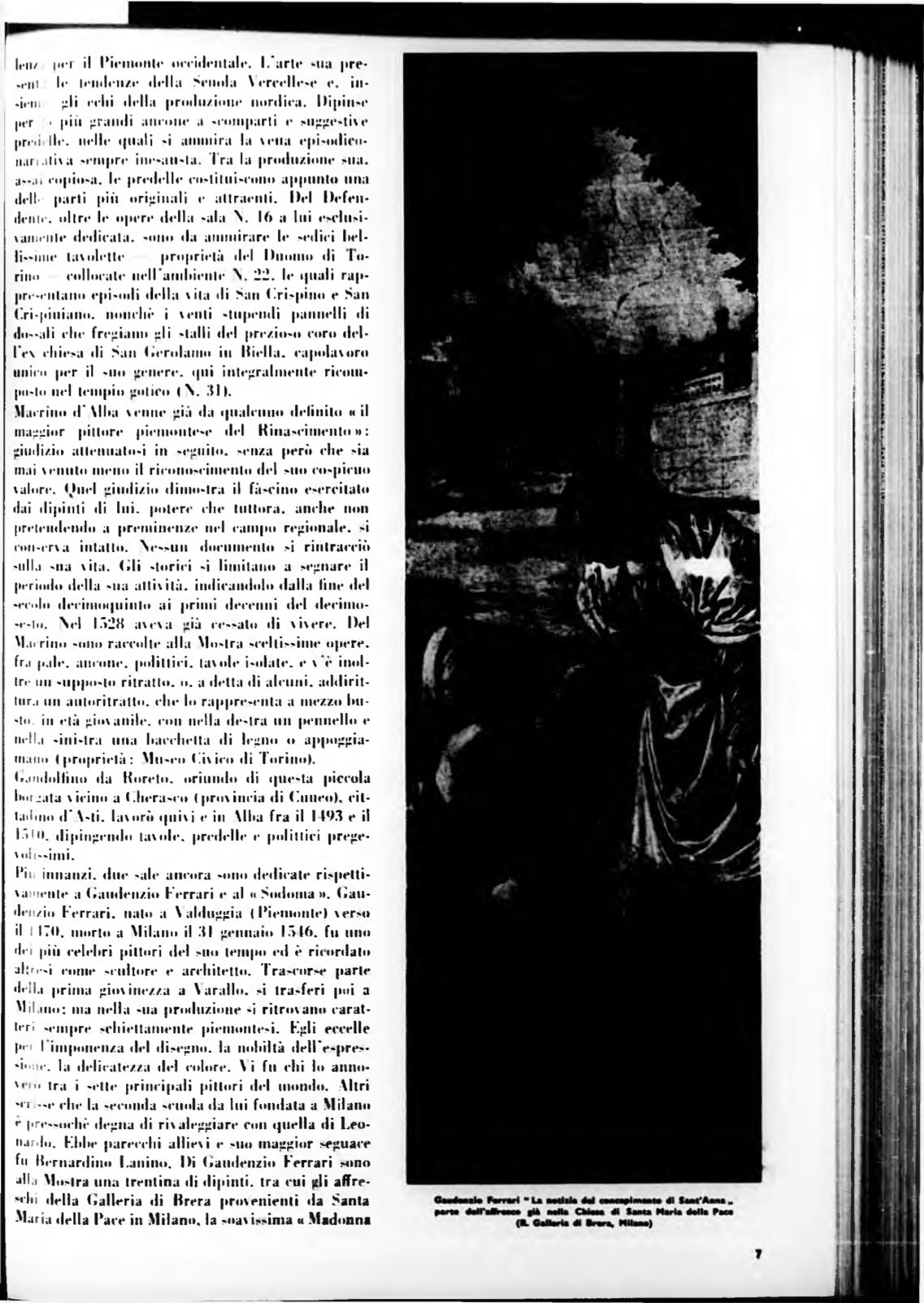
leu/ |
mt
il Piemonte occidentale. L'arte sua pre-
M-iii It* temleiize «Iella Sentila Vercellese e. in-
•imi jdi cclii tirila proilii/ionc nordica. Dipinse
|trr • più grandi ancone a scomparii e su^cstive
prril llr. n rllr «piali si ammira la \riia episoilico-
nuriativa sempre inesau»ta. Ira la produzione sua.
a««ai mpiosu. le predelle costituiscono appunto una
delle parti più originali r attraenti. Del Defen-
(lenir, «dire le opere della sala Y 16 a lui esclusi-
\ainriitc dedicata, som* «la ammirare le sedici bel
lissime ta\ol«*ttr
proprietà «lei Duomo di lo*
riim
collocati* n«‘lI ambiente
22. le «piali rap-
prc-eutaim epis«idi «Iella \ila «li San (iri-pino e San
Cri-piuiaiio. nonché i venti stupeiiili pannelli di
«Io-sili rlir fregiami ^1i stalli del prezioso curii del
l'ex chiesa «li San (remiamo in Biella, capolavoro
unico per il -u«» «jenere. «pii integralmente ricoui-
p«ist«» nel tempio •lotico (N . 51).
Marnilo «I* \lha venne "ia «la ipialriiuo deliuito « il
ma^ior pittore piemontese drl Binascimento m:
•'imli/io attenuatosi in -«••mito, senza però che sia
mai venuto memi il riconoscimento del suo cospicuo
valore. Huel •'indizio dimostra il fàscino esercitai»»
«lai «Iipinti «li lui. potere che tuttora, anche non
preleinlendo a preminenze nel campo regionale, si
«•on-erva intatto. Nessun documento si rintracciò
-lillà -ua vita. (>li storici si limitano a segnare il
periodo «Iella stia attività, indicandolo «laila line «lei
secolo dcrimoipiinto ai primi decenni del decimo-
-e-lo. Nel I32K aveva "ià cessato «li vivere. Del
Marriiio stimi raccolte alla Mostra sceltissime «ipere.
fra pale, ancone, polittici, tavole isolate. e v e inol
tre mi supposto ritratto, o. a detta «li alcuni. a«l«lirit-
tura
i m i
autoritratto, che hi rappresenta a mezzo lui -
-tu. in età giovanile, etili nella destra un pennello e
nella sinistra una bacchetta «li lejimi o appo^ia-
mano (proprietà: Museo (Civico «li Torino).
(»amini li itti tla Boreto. oriundo di tpie-ta piccola
bordata vicino a (lhera»co (prov inria di (luiieo), cit-
tailino «I*Asti, lavorò quivi e in Alba fra il 1493 e il
l.»!U. dipingendo tavole, predelle e polittici pre^e-
'o li"im i.
l’ir innanzi, due sale ancora sono «leilicate rispetti-
vamente a (raudenzio Terrari e al tt Sodoma >i. (>au-
tlen/io Ferrari, nato a V a llin o la ( Piemonte) verso
il I 17)1. morto a M ilano il 31 “ etmani 1316. fu uno
dei più celebri pittori del siiti tempo ed è m ordalo
altre*i etmie scultore e architetto. Trascorse parte
della prima giovinezza a \arallo . si trasferì poi a
Mil imi: ma mdla -uà protluzitiue si ritrtivano carat
teri -empre schiettamente pienitintesi. Kjjli eccelle
pei I imponenza «lei disegno, la nobiltà deU*e«pres-
-itiiir. la delicatezza del colore. \ i fu chi lo anno-
' 1• tra i '«‘Ite principali pilt«iri «lei umililo. Altri
-ri -.e che la scrunila «cuoia da lui f«uuiata a Milano
e |ire'soi-|iè defila «li riv a le n a re con quella di Leo-
n ar do.
Klibe parecchi allievi e
s u o
m a^ io r seguace
fu Bernardiuti Lanino. Di (raudenzio Ferrari sono
alla Mostra una trentina di «lipinti. tra cui »li affre-
•'ehi «iella (ralleria di Brera provenienti da Santa
-Maria «Iella Pace in M ilano, la soavissima « Madonna


















