
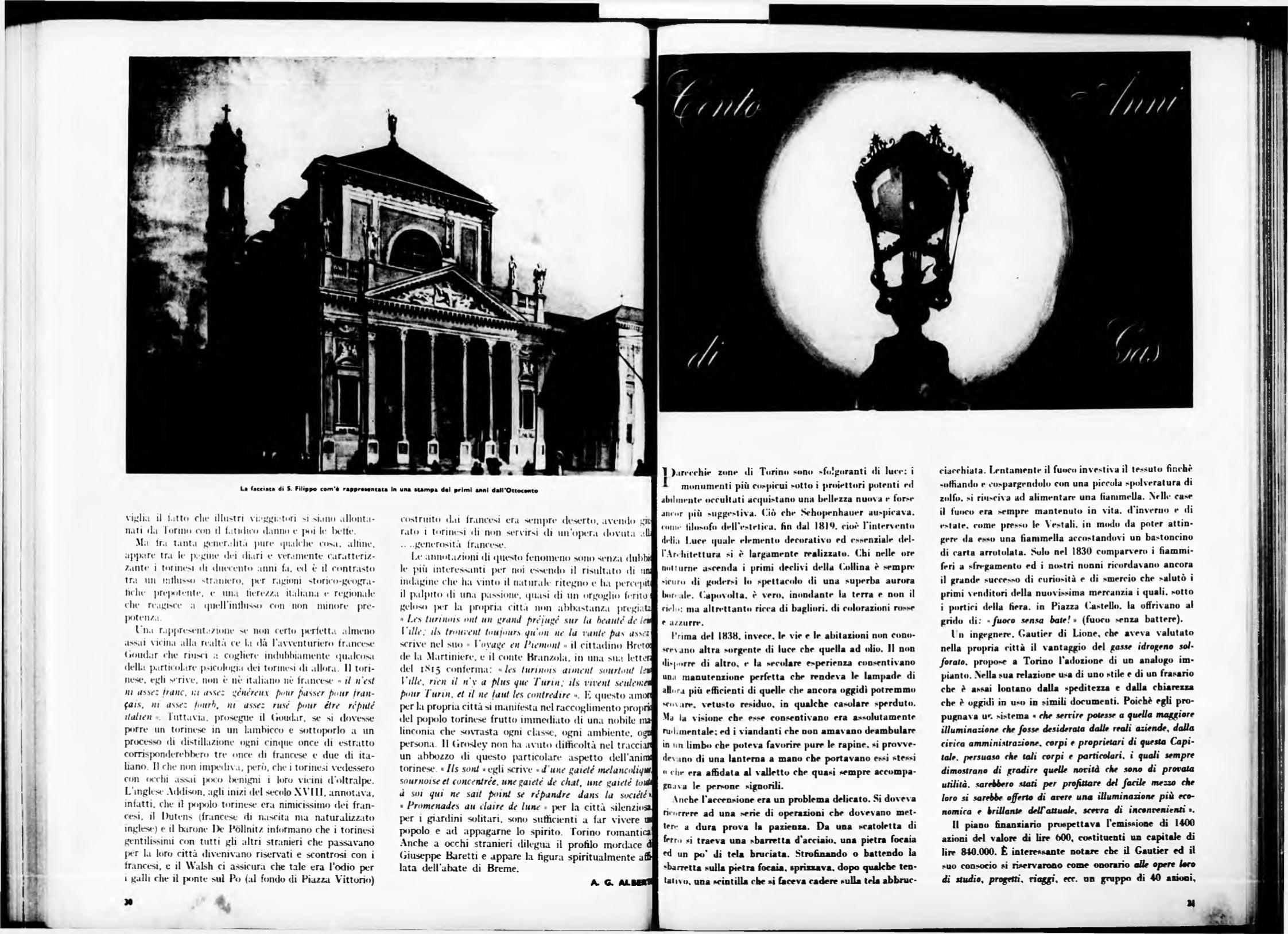
riacrhiata. Lentamente il fuoco investiva il tessuto finché
soffiando e cospargendolo con una pircola spolveratura di
zolfo, si riusciva ad alimentare una iianunella. Nelle case
il fuoco era sempre mantenuto in vita, d'inverno e di
estate, come presso le Vestali, in modo da poter attin*
fiere da esso una fiammella accostandovi un bastoncino
di carta arrotolata. Solo nel 1830 comparvero i fiammi
feri a sfregamento ed i nostri nonni ricordavano ancora
il grande successo di curiosità e di smercio che salutò i
primi venditori della nuovissima mercanzia i quali, sotto
i portici della fiera, in Piazza ('.astello, la offrivano al
grido di: «fuoco senso baie! » (fuoco senza battere).
I n ingegnere. Gautier di Lione, che aveva valutato
nella propria città il vantaggio del gasse idrogeno sol•
forato. propose a Torino l'adozione di un analogo im
pianto. Nella sua relazione usa di uno stile e di un frasario
che è assai lontano dalla speditezza e dalla chiarezza
che è oggidì in uso in simili documenti. Poiché egli pro
pugnava ur. sistema « che servire potesse a quella maggiore
illuminazione chefosse desiderata dalle reali aziende, dalla
civica amministrazione, corpi e proprietari di questa Capi
tale. persuaso che tali corpi e particolari, i quali sempre
dimostrano di gradire quelle novità che sono di provata
utilità, sarebbero stati per profittare del facile mezzo che
loro si sarebbe offerto di avere una illuminazione più eco
nomica e brillante delTattuale, scevra di inconvenienti ».
U piano finanziario prospettava l'emissione di 1400
azioni del valore di lirr 600, costituenti un capitale di
lire 840.000. È interessante notare che il Gautier ed il
suo consocio si riservarono come onorario alle open laro
di studio, progetti, viaggi, ecc. un gruppo di 40 aiioni,
U
*
La facciata di S. Filippa com’è rappr*t«ntat* in una itampa dai primi anni dall‘Ottocento
viglia il fatto clic illu-tri viaggiatori «i siano allonta
nati da Torino con il fatidico danno e poi le lx‘tie.
Ma fra tanta generalità pure qualche cosa, aitine,
appare tra le pagine dei diari e veramente caratteriz
zante i torinesi di duecento anni fa, ed è il contrasto
tra un influsso straniero, per ragioni storico-geogra
fiche prepotente, e una fierezza italiana e regionale
che reagisce a quell'influsso con non minore pre
potenza.
I na rappresentazione ->e non certo perfetta almeno
assai vicina alla realtà ce la dà l’avventuriero francese
Gondar che riuscì a cogliere indubbiamente qualcosa
della particolare psicologia dei torinesi di allora. Il tori
nese, egli scrive, non è nè italiano nè francese « il it esi
ni asse: frane, ni asse: généreux putir passer pmtr jrait-
fais, ni asse: fmirb, ni asse: rusé putir étre réputé
italien . Tuttavia, prosegue il Goudar, se si dovesse
porre un torinese in un lambicco e sottoporlo a un
processo di distillazione o^ni cinque once di estratto
corrisponderebbero tre once di francese e due di ita
liano. Il che non impediva, però, che i torinesi vedessero
con occhi assai poco benigni i loro vicini d’oltralpe.
L’inglese Addison, agli inizi del secolo XVIII, annotava,
infatti, che il popolo torinese era nimicissimo dei fran
cesi, il Dutens (francese di nascita ma naturalizzato
inglese) e il barone I)e Pollnitz informano che i torinesi
gentilissimi con tutti gli altri stranieri che passavano
{H-r la loro città divenivano riservati e scontrosi con i
francesi, e il Walsh ci assicura che tale era l’odio per
i galli che il ponte sul Po (al fondo di Piazza Vittorio)
costruito dai francesi era sempre deserto, avendo gio
rato i torinesi di non servirsi di un’opera dovuta all
.. ..generosità francese.
Le annotazioni di (piesto fenomeno sono senza dubbi
le più interessanti per noi essendo il risultato di ua
indagine che ha vinto il naturale ritegno e ha percepiti
il palpito tli lina passione, (piasi di un orgoglio ferito i
geloso
j x t
la propria città non abbastanza pregiata
«
l.esturinois ont mi grand préiugé sur la beante de le*
Ville; ils trouvenl toujours qu’on ne la vanU pas assa
scrive nel suo « Voyage en Piemont « il cittadino Brera
de la Martiniere, e il conte Branzola. in una sua. letteti
del iS
15
conferma: « les turinois aiment sourtout le*
Ville, nen il n'y a plus que Turin; ils viverti sententea
ponr Turin. et il ne laut les contredire •>. E questo amor
per la propria città si manifesta nel raccoglimento propri
del popolo torinese frutto immediato di una nobile ma
linconia che sovrasta ogni classe, ogni ambiente, ogp
persona. Il Grosley non ha avuto difficoltà nel tracciar
un abbozzo di questo particolare aspetto (lell'anin#
torinese. «Ils sont «egli scrive «d une gaieté tnelancoliqm
sournoiseet concenlrée, imegaieté de
ch.it, ime gaieté touU
à soi qui ite sait point se répandre dans la société»
« Promenades au daire de lune -per la città silenziosa,
per ì giardini solitari, sono sufficienti a far vivere
ux
popolo e ad appagarne lo spirito. Torino romantica
Anche a occhi stranieri dilegua il profilo mordace d
Giuseppe Baretti e appare la figura spiritualmente att
lata dell'abate di Breme.
a
. c .
a l ic r t
T )arecchie zone ili Turino sono «folgoranti di luce: i
' monumenti più cospicui sotto i proiettori potenti ed
abilmente occultati acquistano una bellezza nuova e forse
ancor più suggestiva. dio che Schopenhauer auspicava,
come filosofo dell'estetica, fin dal 181*). cioè l'intervento
della Luce (piale elemento decorativo ed essenziale del-
l'Ar. Iiitettura si è largamente realizzato. Chi nelle ore
notturne ascenda i primi declivi della ('.oliina è sempre
sicuro di godersi lo spettacolo di una superba aurora
bop ale. Capovolta, è vero, inondante la terra e non il
nel.: ma altrettanto ricca di bagliori, di colorazioni rosse
e azzurre.
l'rima del 1838. invece, le vie e le abitazioni non cono-
>ce\ano altra sorgente di luce che quella ad olio. II non
(liq, •rre di altro, e la secolare esperienza consentivano
una manutenzione perfetta che rendeva le lampade di
allora più efficienti di quelle che ancora oggidì potremmo
scovare, vetusto residuo, in qualche casolare sperduto.
Ma la visione che esse consentivano era assolutamente
ni<i.mentale: ed i viandanti che non amavano deambulare
in nn limbo che poteva favorire pure le rapine, si prowe-
drv ino di una lanterna a mano che portavano essi stessi
<•che era affidata al valletto che quasi sempre accompa
gnava le persone signorili.
\nche l'accensione era un problema delicato. Si doveva
ricorrere ad una serie di operazioni che dovevano met
tere a dura prova la pazienza. Da una scatoletta di
ferr.i si traeva una sbarretta d'acciaio, una pietra focaia
ed un po' di tela bruciata. Strofinando o battendo la
'barretta sulla pietra focaia, sprizzava, dopo qualche ten
tativo, una scintilla che si faceva cadere sulla tela abbruc-


















