
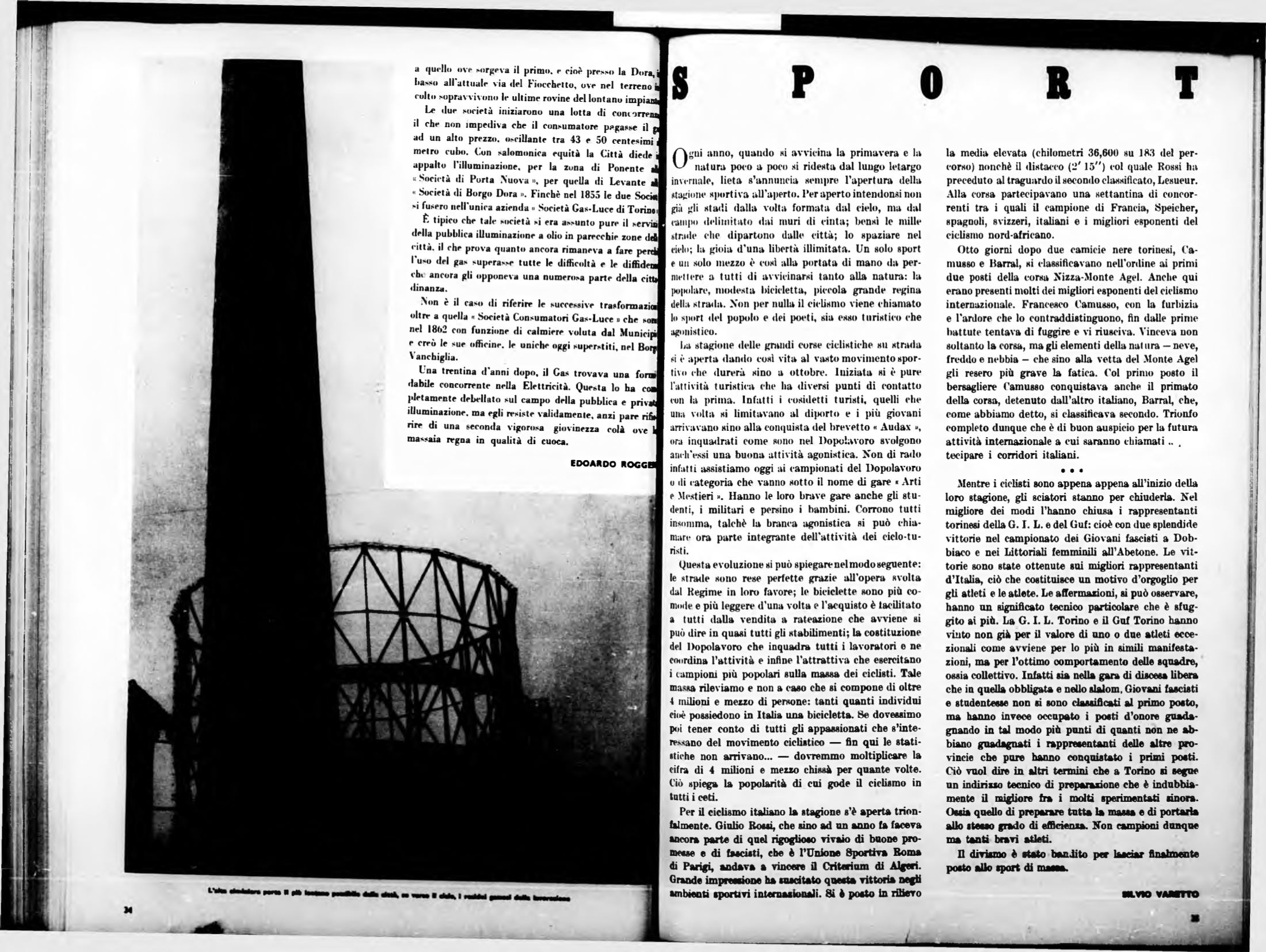
parta■«A
EDO ARDO ROGGBM
O
gni anno, quando si avvicina la primavera e la
natura poco a poco si ridesta dal lungo letargo
invernale, lieta s’annuncia sempre l’apertura della
stagione sportiva all’aperto. Per aperto intendonsi non
già gli stadi dalla volta formata dal cielo, ma dal
campo delimitato dai muri di cinta; bensì le mille
strade che dipartono dalle città; lo spaziare nel
cielo; la gioia d’una libertà illimitata. Un solo sport
e un solo mezzo è così alla portata di mano da per
mettere a tutti di avvicinarsi tanto alla natura: la
pollare, modesta bicicletta, piccola grande regina
della strada. Non per nulla il ciclismo viene chiamato
hi sport del popolo e dei poeti, sia esso turistico che
agonistico.
La stagione «Ielle grandi corse ciclistiche su strada
si è aperta «landò così vita al vasto movimento spor
tivo che «lurerà sino a ottobre. Iniziata si è pure
l'attività turistica che ha «liversi punti di contatto
con la prima. Infatti i cosi«letti turisti, quelli che
una volta si limitavano al diporto e i più giovani
arrivavano sino alla conquista del brevetto « Audax »,
ora inquadrati come sono nel Dopolavoro svolgono
anclfessi una buona attività agonistica. Non di ra«lo
infatti assistiamo oggi ai campionati del Dopolavoro
0 di «-ategoria che vanno sotto il nome «li gare «Arti
e M«>stieri ». Hanno le loro brave gare anche gli stu-
«lenti, i militari e persino i bambini. Corrono tutti
insomma, talché la branca agonistica si può chia
mare ora parte integrante dell'attività «lei eiclo-tu-
risti.
Questa evoluzione si può spiegarenelmodoseguente:
le stracle sono rese perfette grazie all’opera svolta
«lai Regime in loro favore; le biciclette sono più co
mode e più leggere d'una volta e l’acquisto è facilitato
a tutti dalla vendita a rateazione che avviene si
può dire in quasi tutti gli stabilimenti; la costituzione
del Dopolavoro che inquadra tutti i lavoratori e ne
coordina l’attività e infine l’attrattiva che esercitano
1campioni più popolari sulla massa dei ciclisti. Tale
massa
rileviamo e non a caso che si compone di oltre
4 milioni e mezzo di persone: tanti quanti individui
cioè possiedono in Italia una bicicletta. Se dovessimo
poi tener conto di tutti gli appassionati che s’inte
ssano del movimento ciclistico — fin qui le stati
stiche non arrivano... — dovremmo moltiplicare la
cifra di 4 milioni e mezzo chissà per quante volte.
Ciò spiega la popolarità di cui gode il ciclismo in
tutti i ceti.
Per il ciclismo italiano la stagione s’è aperta trion
falmente. Giulio Bossi, che sino ad un anno fa faceva
ancora parte di quel rigoglioso vivaio di buone pro
messe e di fascisti, che è l’Unione Sportiva Roma
di Parigi, andava a vincere fl Criterium di Algeri.
Grande impressione ha suscitato questa vittoria negli
ambienti sportivi internaitonali. Si è posto in rilievo
la media elevata (chilometri 36,600 su 183 «lei per
corso) nonché il «listacco (2' 15") col quale Rossi ha
preceduto al traguardo il secondo classificato, Lesueur.
Alla corsa partecipavano una settantina di concor
renti tra i quali il campione di Francia, Speicher,
spagnoli, svizzeri, italiani e i migliori esponenti del
ciclismo nord-africano.
Otto giorni dopo due camicie nere torinesi, Ca-
musso e Barrai, si classificavano nell'ordine ai primi
due posti della corsa Nizza-Monte Agel. Anche qui
erano presenti molti dei migliori esponenti del ciclismo
internazionale. Francesco Camusso, con la furbizia
e l'ardore che lo contraddistinguono, fin dalle prime
battute tentava di fuggire e vi riusciva. Vinceva non
soltanto la corsa, ma gli elementi della natura —neve,
freddo e nebbia - che sino alla vetta del Monte Agel
gli resero più grave la fatica. Col primo posto il
bersagliere Camusso conquistava anche il primato
della corsa, detenuto dall’altro italiano, Barrai, che,
come abbiamo detto, si classificava secondo. Trionfo
completo dunque che è di buon auspicio per la futura
attività internazionale a cui saranno chiamati.. .
teeipare i corridori italiani.
* * t
Mentre i ciclisti sono appena appena all’inizio della
loro stagione, gli sciatori stanno per chiuderla. Nel
migliore dei modi l’hanno chiusa i rappresentanti
torinesi dellaG. I. L. edel Guf: cioè con due splendide
vittorie nel campionato dei Giovani fascisti a Dob-
biaco e nei Ldttoriali femminili all’Abetone. Le vit
torie sono state ottenute sui migliori rappresentanti
d’Italia, ciò che costituisce un motivo d’orgoglio per
gli atleti e leatlete. Le affermazioni, si può osservare,
hanno un significato tecnico particolare che è sfug
gito ai più. La G. I. L. Torino e il Guf Torino hanno
vinto non già per il valore di uno o due atleti ecce
zionali come avviene per lo più in simili manifesta
zioni, ma per l’ottimo comportamento delle squadre,
ossia collettivo. Infatti sia nella gara di discesa libera
che in quella obbligata enelloslalom, Giovani fascisti
e studentesse non si sono classificati al primo posto,
ma hanno invece occupato i posti d’onore guada
gnando in tal modo più punti di quanti non ne ab
biano guadagnati i rappresentanti delle altre pro
vincie che pure hanno conquistato i primi posti.
Ciò vuol dire in altri termini che a Torino si segue
un indirizzo tecnico di preparazione che è indubbia
mente il migliore fra i molti sperimentati sinora.
Ossia quello di preparare tutta la massa e di portarla
allo stesso grado di efficienza. Non campioni dunque
ma tanti bravi atleti.
Il divismo è stato bandito per lasciar finalmente
posto allo sport di massa.
SILVIO VAMTTO
a quello ove sorgeva il primo, e cioè presso la Dora, i
basso aH'attuale via del Fiocchetto, ove nel terreno■
colti» sopravvivono le ultime rovine del lontano impianti
Le «lue società iniziarono una lotta di concorreim
il che non impediva che il consumatore pagasse il p
ad un alto prezzo, oscillante tra 43 e 50 centesimi i
metro cuho. Con salomonica equità la Città diede i
appalto l'illuminazione, per la zona di Ponente al
«Società di Porta Nuova », per quella di Levante al
« Società «li Borgo Dora ». Finché nel 1855 le due Socki
si fusero nell'unica azienda » Società Gas-Luce di Torinoi
fi tipico che tale società si era assunto pure il servi*
della pubblica illuminazione a olio in parecchie zone dd
città, il che prova quanto ancora rimaneva a fare perdi
l'uso del gas superasse tutte le difficoltà e le diffideu
chi ancora gli opponeva una numerosa parte della cittì
(finanza.
Non è il cast» di riferire le successive trasformazioa
oltre a quella «Società Consumatori Gas-Luce » che son
nel 18(>2 con funzione di calmiere voluta dal Municipi
e creò le sue officine, le uniche oggi superstiti, nel Boi|i
Vanchiglia.
Una trentina d'anni dopo, il Gas trovava una fona
(labile concorrente nella Elettricità. Questa lo ha eoa
pletamente debellato sul campo della pubblica e privati
illuminazione, ma egli resiste validamente, anzi pare rifili
rire di una seconda vigorosa giovinezza colà ove li
massaia regna in qualità di cuoca.
|


















