
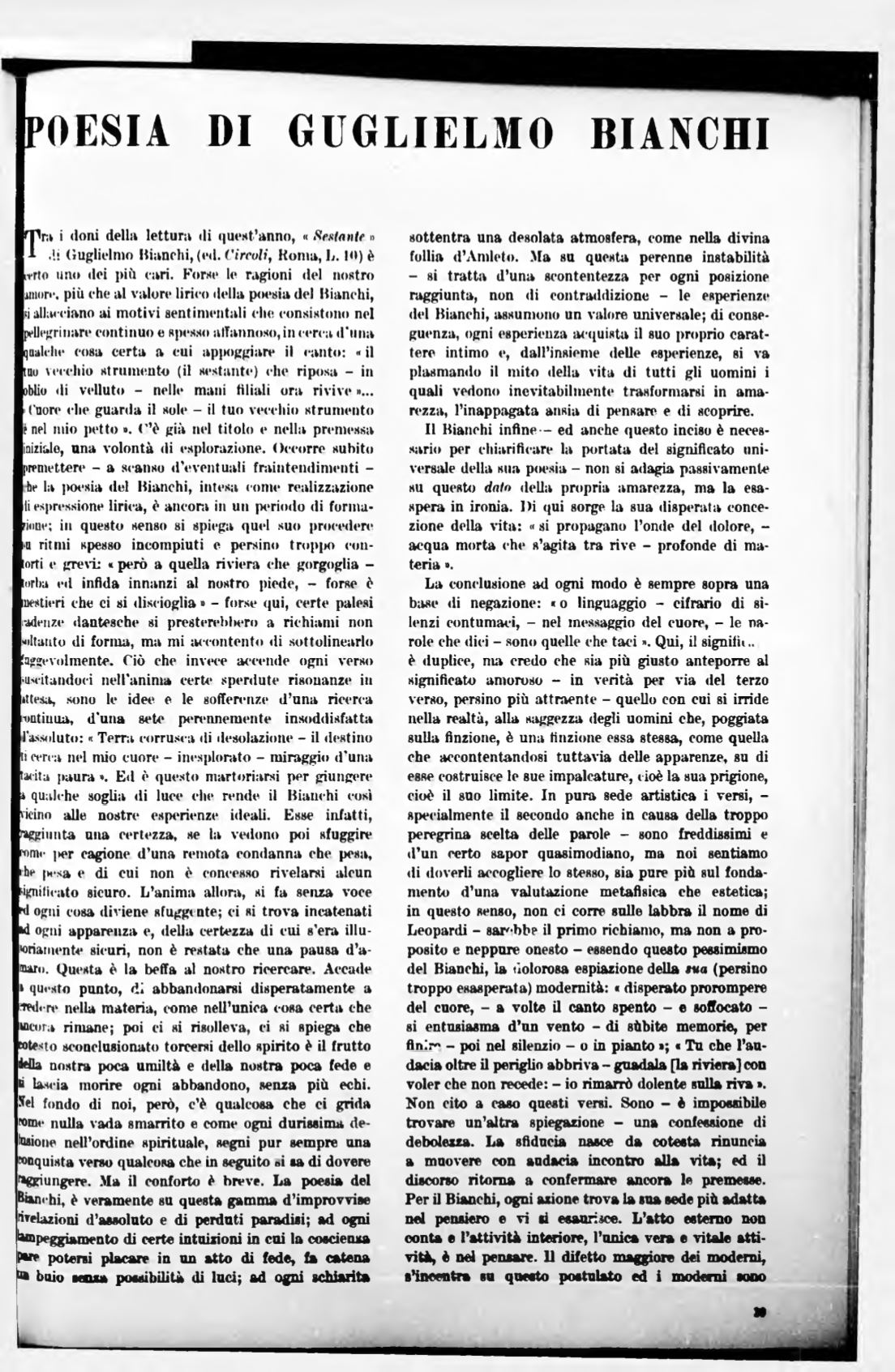
POESIA DI GUGLIELMO BIANCHI
T
r.i i doni della lettura ili quest’anno, « Sestante »
di Guglielmo Bianchi, (ed. Circuii, Roma, L. IO) è
ivrto uno dei più cari. Forse le ragioni del nostro
unore, più che al valore lirico della poesia del Bianchi,
liallacciano ai motivi sentimentali che consistono nel
pellegrinare continuo e spesso affannoso, in cerca d'ima
qualche
cosa certa a cui appoggiare il canto: « il
tuo vecchio strumento (il sestante) che riposa - in
oblio di velluto - nell»* mani filiali ora rivive »...
Cuore che guarda il sole - il tuo vecchio strumento
enei mio petto ». C’è già nel titolo e nella premessa
iniziale, una volontà di esplorazione. Occorre subito
premettere - a scanso d’eventuali fraintendimenti -
he la poesia del Bianchi, intesa come realizzazione
li espressione lirica, è ancora in un periodo di forma-
rione; in questo senso si spiega quel suo procedere
•u ritmi spesso incompiuti e persino troppo con
torti e grevi: « però a quella riviera che gorgoglia -
torba ed infida innanzi al nostro piede, - forse è
Mestieri che ci si (liscioglia » - forse qui, certe palesi
cadenze dantesche si presterebbero a richiami non
soltanto di forma, ma mi accontento di sottolinearlo
[agevolmente. Ciò che invece accende ogni verso
suscitandoci neU'anima certe sperdute risonanze in
»ttesa, sono le idee e le sofferenze d’una ricerca
rontinua, d'una sete perennemente insoddisfatta
l'assoluto: «Terra corrusca di desolazione - il destino
ti cerca nel mio cuore - inesplorato - miraggio d'una
tacita paura ». Ed è questo martoriarsi per giungere
» qualche soglia di luce che rende il Bianchi così
ricino alle nostre esperienze ideali. Esse infatti,
raggiunta una certezza, se la vedono poi sfuggire
pome per cagione d’una remota condanna che pesa,
che |M*sa e di cui non è concesso rivelarsi alcun
lignificato sicuro. L’anima allora, si fa senza voce
«1
ogni cosa diviene sfuggente; ci si trova incatenati
Mi ogni apparenza e, della certezza di cui s’era illu
foriamente sicuri, non è restata che una pausa d’a
maro. Questa è la beffa al nostro ricercare. Accade
» questo punto, di abbandonarsi disperatamente a
credere nella materia, come nell’unica cosa certa che
incora rimane; poi ci si risolleva, ci si spiega che
cotesto sconclusionato torcersi dello spirito è il frutto
della nostra poca umiltà e della nostra poca fede e
à lascia morire ogni abbandono, senza più echi.
Sei fondo di noi, però, c’è qualcosa che ci grida
come nulla vada smarrito e come ogni durissima de
lusione nell’ordine spirituale, segni pur sempre una
conquista verso qualcosa che in seguito ai sa di dovere
raggiungere. Ma il conforto è breve. La poesia del
Bianchi, è veramente su questa
gamma
d’improvvise
rivelazioni d’assoluto e di perduti paradisi; ad
ogni
lampeggiamento di certe intuizioni
in cui la coscienza
Pu* potersi
placare in un atto di fede,
fa
catena
■ut buio sema
possibilità di luci; ad ogni
schiarita
sottentra una desolata atmosfera, come nella divina
follia d’Amleto. Ma su questa perenne instabilità
- si tratta d’una scontentezza per ogni posizione
raggiunta, non di contraddizione - le esperienze
del Bianchi, assumono un valore universale; di conse
guenza, ogni esperienza acquista il suo proprio carat
tere intimo e, dall’insieme delle esperienze, si va
plasmando il mito della vita di tutti gli uomini i
quali vedono inevitabilmente trasformarsi in ama
rezza, l’inappagata ansia di pensare e di scoprire.
Il Bianchi infine— ed anche questo inciso è neces
sario per chiarificare la portata del significato uni
versale della sua poesia - non si adagia passivamente
su questo dato della propria amarezza, ma la esa
spera in ironia. Di qui sorge la sua disperata conce
zione della vita: « si propagano l’onde del dolore, -
acqua morta che s’agita tra rive - profonde di ma
teria ».
La conclusione ad ogni modo è sempre sopra una
base di negazione: «o linguaggio - cifrario di si
lenzi contumaci, - nel messaggio del cuore, - le na-
role che dici - sono quelle che taci ». Qui, il signifìi..
è duplice, ma credo che sia più giusto anteporre al
significato amoroso - in verità per via del terzo
verso, persino più attraente - quello con cui si irride
nella realtà, alla saggezza degli uomini che, poggiata
sulla finzione, è una finzione essa stessa, come quella
che accontentandosi tuttavia delle apparenze, su di
esse costruisce le sue impalcature, cioè la sua prigione,
cioè il suo limite. In pura sede artistica i versi, -
specialmente il secondo anche in causa della troppo
peregrina scelta delle parole - sono freddissimi e
d’un certo sapor quasimodiano, ma noi sentiamo
di doverli accogliere lo stesso, sia pure più sul fonda
mento d’una valutazione metafìsica che estetica;
in questo senso, non ci corre sulle labbra il nome di
Leopardi - sarebbe il primo richiamo, ma non a pro
posito e neppure onesto - essendo questo pessimismo
del Bianchi, la dolorosa espiazione della sua (persino
troppo esasperata) modernità: « disperato prorompere
del cuore, - a volte il canto spento - e soffocato -
si entusiasma d’un vento - di sùbite memorie, per
finir» - poi nel silenzio - o in pianto »; «
Tu che
l’au
dacia oltre il periglio abbriva - guadala
[la riviera]
con
voler che non recede: - io rimarrò dolente
sulla riva
•.
Non cito a caso questi versi. Sono - è impossibile
trovare un’altra spiegazione - una confessione di
debolezza.
La
sfiducia nasce da cotesta rinuncia
a muovere
con audacia incontro alla vita; ed il
discorso ritorna
a
confermare ancora le premesse.
Per il Bianchi, ogni azione
trova
la sua sedepiù adatta
nel pensiero e vi si esaurisce. L’atto esterno non
conta e l’attività interiore, l’unica vera e vitale atti
vità, è nel pensare. 11 difetto maggiore dei moderni,
s’incentra sa qnerto postulato ed i moderni sono
»


















