
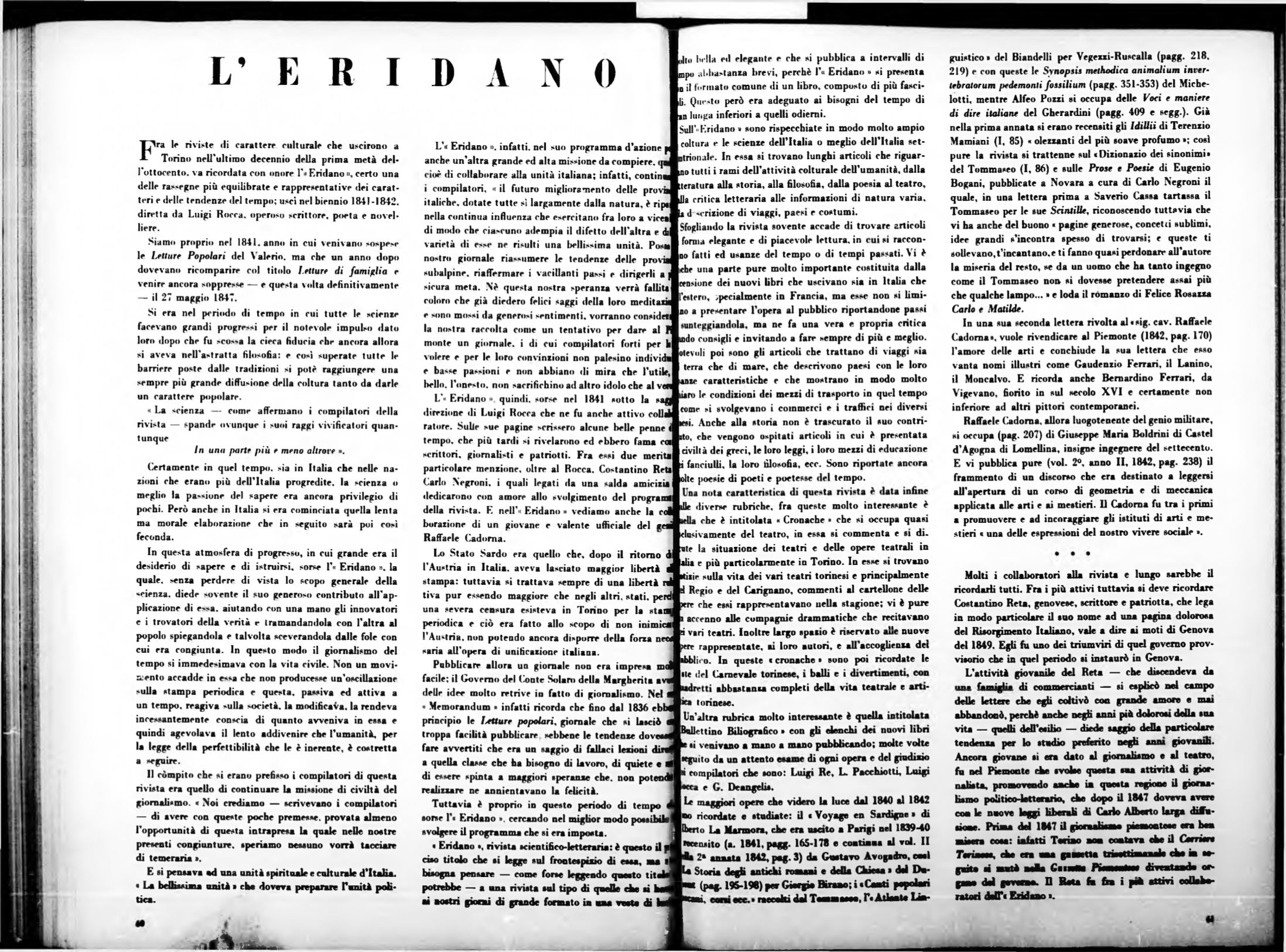
L ’ E R I D A N
0
F
ra le riviste di carattere culturale che uscirono a
Torino nell'ultimo decennio della prima metà del
l'ottocento. va ricordata con onore l’ <Elidano », certo una
delle rassegne più equilibrate e rappresentative «lei carat
teri e «Ielle tendenze «lei tempo; uscì nel biennio 1841-1842.
diretta da Luigi Rocca, operoso scrittore, poeta e novel
liere.
Siamo proprio nel 1841. anno in cui venivano sospese
le Letture Popolari del \alerio. ma che un anno dopo
dovevano ricomparire col titolo Letture di famiglia e
venire ancora soppresse — e questa volta definitivamente
— il 27 maggio 1847.
Si era nel perìodo di tempo in cui tutte le scienze
facevano grandi progressi per il notevole impulso dato
loro «lopo che fu scos««a la cieca fiducia che ancora allora
si aveva nell'astratta filosofia: e così superate tutte le
barriere poste dalle tradizioni si potè raggiungere una
sempre più grande diffusione della coltura tanto da darle
un carattere popolare.
« La scienza — come affermano i compilatori della
rivista — spande ovun«|ue i suoi raggi vivificatori quan
tunque
In una parte più e meno altrove ».
Certamente in quel tempo, sia in Italia che nelle na
zioni che erano più dell'Italia progredite, la scienza o
meglio la passione del sapere era ancora privilegio di
pochi. Però anche in Italia si era cominciata quella lenta
ma morale elaborazione che in seguito sarà poi così
feconda.
In questa atmosfera di progresso, in cui grande era il
desiderio di sapere e di istruirsi, sorse l’« Elidano ». la
quale, senza perdere di vista lo scopo generale della
•scienza, diede sovente il suo generoso contributo all'ap
plicazione di essa, aiutando con una mano gli innovatori
e i trovatori della verità e tramandandola con l'altra al
popolo spiegandola e talvolta sceverandola dalle fole con
cui era congiunta. In questo modo il giornalismo del
tempo si immedesimava con la vita civile. Non un movi
mento accadde in essa che non producesse un'oscillazione
sulla stampa periodica e questa, passiva ed attiva a
un tempo, reagiva sulla società, la modificava. la rendeva
incessantemente conscia di quanto avveniva in essa e
quindi agevolava il lento addivenire che l'umanità, per
la legge della perfettibilità che le è inerente, è costretta
a seguire.
Il compito che si erano prefisso i compilatori di questa
rivista era quello di continuare la missione di civiltà del
giornalismo. « Noi crediamo — scrìvevano i compilatori
— di avere con queste poche premesse, provata almeno
l'opportunità di questa intrapresa U quale nelle nostre
presenti congiunture, speriamo nessuno vorrà tacciare
di temeraria i.
E si pensava ad una unità spirituale eculturale d’Italia.
« La bellissima unità » che doveva preparare l’unità poli*
tica.
L'tt Elidano ». infatti, nel suo programma d’azione
pi
anche un'altra grande ed alta missione da compiere.
tiva pur essendo maggiore che negli altri, stati, perd
bisogna pensare — come forse leggendo questo
potrebbe — a una rivista sul tipo di quelle che ai
ai nostri giorni di grande formato in una
veste
di
ulto bella *«1 elegante e che si pubblica a intervalli di
mpo abbastanza brevi, perchè l’« Elidano » si presenta
n il formato comune di un libro, composto di più fasci
li. Questo però era adeguato ai bisogni del tempo di
an lunga inferiori a quelli odierni.
Sull'"Kridano » sono rispecchiate in modo molto ampio
coltura e le scienze dell’Italia o meglio dell’Italia set-
trioiiale. In essa si trovano lunghi articoli che riguar-
è «li coUaborare alla unità italiana; in fau i,'"contini”0tutti i rami deU’at,ività co,turale A ll’umanità, dalla
compilatori, «il futuro miglioramento delle provi, tteratura alla storia, aUa filosofia, dalla poesia al teatro,
italiche, dotate tutte sì largamente dalla natura, è ripo ^ cri,ica lettcraria a,le informazioni d. natura vana,
nella continua influenza che esercitano fra loro a vicea U* '™ zione di via^ ' ’ Pam e COf*tum«-
di modo che ciascun.» adempia il difetto dell'altra e di Sfogliando la rivista sovente accade di trovare articoli
varietà di esse ne risulti una bellissima unità. PosM fom,a ele8antc e di PiacevoIe Iettura’ in
si raccon-
nostro giornale riassumere le tendenze delle provi. n0 fa,ti ed usanze del temP° ° di ‘“ "P* Pa*satl-Vl è
subalpine, riaffermare i vacillanti passi e dirigerli a , * * una Parte PUFe m°h ° imPortante «P itu ita dalla
sicura meta. Nè questa nostra speranza verrà falbu " n*ione dei nUOVÌ Ubri che U8CÌVaD° ,ia 1B ltaha che
coloro che già diedero felici saggi della loro meditali. re8tero’ * eciaimente in Francia’
T " ^
e sono mossi da generosi sentimenti, vorranno considei » a P ™ ntare
al Pubbhco "portandone pass.
la nostra raccolta come un tentativo per dare al PI
ma ne fa una v«*ra e ProPna cntlca
monte un giornale, i di cui compilatori forti per k u,do oon,‘^ ,i e inv,tando a fan* “ “ P " dl PIU e me*ho-
* .
„ . . .
, . .
., otcvoli poi sono gfi articoli che trattano di viaggi sia
\olere e per le loro convinzioni non palesino ìndivida
*
B
e basse passioni e non abbiano «li mira che l'utile,
bell*», l’onesto, non sacrifichino ad altro idolo che alven
1811
L'« Elidano » quindi, sorse nel 1841 sotto la safl “ ro ,e cond« ioni dei mezzi di trasporto in quel tempo
direzione «li Luigi Rocca che ne fu anche attivo colisi COine 8Ì 8VO,Kevan° 1 c°*n“ « * i e . traffici ne, diversi
ratore. Sulle sue pagine scrissero alcune belle penne i **'' Anche aUa 8tona " ° n è trascurato d 8UO contn*
tempo, che più tardi si rivelarono ed ebbero fama co. lto’ che ven«on° 0!iP,tat‘ art,C°U ,D CU‘ * Presentata
scrittori, giornalisti e patriotti. Fra essi due merita civiltà dei greci, le loro leggi, i loro mezzi di educazione
particolare menzione, oltre al Rocca. Costantino ReU i fanciuUi' la lor° filosofia’ eCC-5000
Carlo Negroni. i quali legati .la una salda amicizia ol,e P™ '* di P0*11e V0*1****
temp°-
«ledicarono con amore allo svolgimento del program
della rivista. E nell’.*Eridan.» » vediamo anche la col ^ diven* ™briche' fra 1ueste mo,to intere8sante è
borazione di un giovane e valente ufficiale del ted
fhe è intitolata « Cronache » che s, occupa quasi
elusivamente del teatro, in essa si commenta e si di.
lite la situazione dei teatri e delle opere teatrali in
terra che di mare, che descrivono paesi con le loro
re caratteristiche e che mostrano in modo molto
i
l t ffi i l <
Raffaele Cadorna.
Lo Stato Sardo era quello che, dopo il ritorno è
,
. _ . ,
l'Austria in Itali*, aveva lasciato maggior libertà i «fa e pii, particolarmente ..Tonno. lo <*■* ..
trov.nostampa: tuttavia si trattava sempre di una libertà ral
otizie sulla vita dei vari teatri torinesi e principalmente
d Regio e del Carignano, commenti al cartellone delle
„„„ .
-,
.
,
pere che essi rappresentavano nella stagione; vi è pure
una severa censura esisteva in Tonno per la stani
r r
. , ,
.
i-
»
.•
. . .
» accenno alle compagnie drammatiche che recitavano
periodica e ciò era fatto allo scopo di non inimica
v 8
„
l'Austria. non potendo ancora di,porre della fo„a neo,
*
v,ri *“ “ *• inol,r' l*r*° ‘I " " 0 » n“ " * 10
”U°1V'
.aria .U'oper, di uniscanone italiana.
I * ™PP"~»«**«. “ «•"> ■“*«'*• * •“ * f ^ “ d“
Pubblicare .llora un giornale non era impre..
m j ^
0' In 1u“ to ■ «.Mcbe . »ono pò. mordale le
facile; il Governo del Conte
Sol.rodell. M.rgherit. .ve.
,,e del €*ra" * 1'
* b*“‘ e ■
deUe idee molto retrive in f.tto di giornali™». Nel ■
*bb" t*"“ comPle,i d' “* " U “ *t” 1' e
« Memorandum » infatti ricorda che fino dal 1836 ebbi
** tor*neae.
principio le Iatture popolari, giornale che si lasciò 0
lValtra rubric* mo,to intere**“ te è <*ueU*
troppa faciUtà pubblicare sebbene le tendenze dovessi O t t i n o Biliografico . con gli elenchi dei nuovi libn
fare avvertiti che era un saggio di fallaci lezioni d i r i # 681ve««vano a mano a mano pubblicando; molte volte
a quella classe che ha bisogno di lavoro, di quiete e * **u,,° d* un *ttento
^ °«ni °Pe n e del Pudixio
di essere spinta a maggiori speranze che, non poten* * c«rapilatori che sono: Luigi Re, L. Pacchetti, Luigi
realizzare ne annientavano la felicità.
e
Deangelis.
Tuttavia è proprio in queste perìodo di tempo 4 ** ““ W® " °?a t c*1®vid«,° U luce ^ 1840 J 1842
sorse l’« Elidano », cercando nel miglior modo possibile *° ricordate e studiate: il « Voyage en Sardigne » di
svolgere il programma che si era imposta.
- ^ erto La Marmora, che era osato a Parigi nel 1839-40
« Elidano », rivista scientifico-letteraria: è questo il p ncea*ito (a. 1841, pagg. 165-178 e continua al voi. II
riso titolo che si legge sul frontespizio di essa, ma l
2* annata 1842, pag. 3) da Gustavo Avogadro, cosi
titg|f U Storia degli antichi roasaai e della Chiesa >del Dn-
l llÉ ^ìlìlfcfcÉÉ I
'ZZI'
(pag.
19
S-
198
) per Giorgio Birano;
i
«Canti popolari
raccolti dal Tommaseo, I\ Atlante Lin
guistico» del Biandelli per Vegezzi-Ruscalla (pagg. 218.
219) e con queste le Synopsis methodica animalium inver-
tebratorum pedemonti fossilium (pagg. 351-353) del Miche-
lotti, mentre Alfeo Pozzi si occupa delle Voci e maniere
di dire italiane del Gherardini (pagg. 409 e segg.). Già
nella prima annata si erano recensiti gU Idillii di Terenzio
Mamiani (I, 85) « olezzanti del più soave profumo »; così
pure la rivista si trattenne sul «Dizionazio dei sinonimi»
del Tommaseo (I, 86) e sulle Prose e Poesie di Eugenio
Bogani, pubblicate a Novara a cura di Carlo Negroni il
quale, in una lettera prima a Saverio Cassa tartassa il
Tommaseo per le sue Scintille, riconoscendo tuttavia che
vi ha anche del buono « pagine generose, concetii sublimi,
idee grandi s’incontra spesso di trovarsi; e queste ti
sollevano,t’incantano.e ti fanno quasi perdonare all’autore
la miseria del resto, se da un uomo che ha tanto ingegno
come il Tommaseo non si dovesse pretendere assai più
che qualche lampo... » e loda il romanzo di Felice Rosazza
Carlo e Matilde.
In una sua seconda lettera rivolta alosig. cav. Raffaele
Cadorna», vuole rivendicare al Piemonte (1842, pag. 170)
l'amore delle arti e conchiude la sua lettera che esso
vanta nomi illustri come Gaudenzio Ferrari, il Lanino,
il Moncalvo. E ricorda anche Bernardino Ferrari, da
Vigevano, fiorito in sul secolo XV I e certamente non
inferiore ad altri pittori contemporanei.
Raffaele Cadorna, allora luogotenente del genio militare,
si occupa (pag. 207) di Giuseppe Maria Boldrini di Castel
d’Agogna di Lomellina, insigne ingegnere del settecento.
E vi pubblica pure (voi. 2°, anno II, 1842, pag. 238) il
frammento di un discorso che era destinato a leggersi
all’apertura di un corso di geometria e di meccanica
appUcata alle arti e ai mestieri. Il Cadorna fu tra i primi
a promuovere e ad incoraggiare gli istituti di arti e me
stieri « una delle espressioni del nostro vivere sociale ».
Molti i collaboratori alla rivista e lungo sarebbe il
ricordarli tutti. Fra i più attivi tuttavia si deve ricordare
Costantino Reta, genovese, scrittore e patriotta, che lega
in modo particolare il suo nome ad una pagina dolorosa
del Risorgimento Italiano, vale a dire ai moti di Genova
del 1849. Egli fu uno dei triumviri di quel governo prov
visorio che in quel periodo si instaurò in Genova.
L’attività giovanile del Reta — che discendeva da
ima famigli» di commercianti — si esplicò nel campo
delle lettere che egli coltivò con grande amore e mai
abbandonò, perchè anche
negh
anni più dolorosi della sua
vita — quelli dell’esilio — diede saggio della particolare
tendenza per lo stadio preferito negh anni giovanili.
Ancora giovane si era dato al giornalismo e al teatro,
fu nel Piemonte che svolse questa sua attività di gior
nalista, promovendo anche in questa regione il giorna
lismo politico-letterario, che dopo il 1847 doveva avere
con le nuove leggi liberali di Cario Alberto larga diffu
sione. Prima del 1847 il giornalismo piemontese era ben
misera
cosa:
infatti
Torino non contava
dm il
Csrrisrs
Torinese, che
era una
gaietta trisettimanale che
in
se
guito si mutò nella
C o lite PimmmÈm»
diventando or*
gano del goveno. D
Reta
Ih fra i psà attiri ooflabo-
ratori delT* Fridann ».


















