
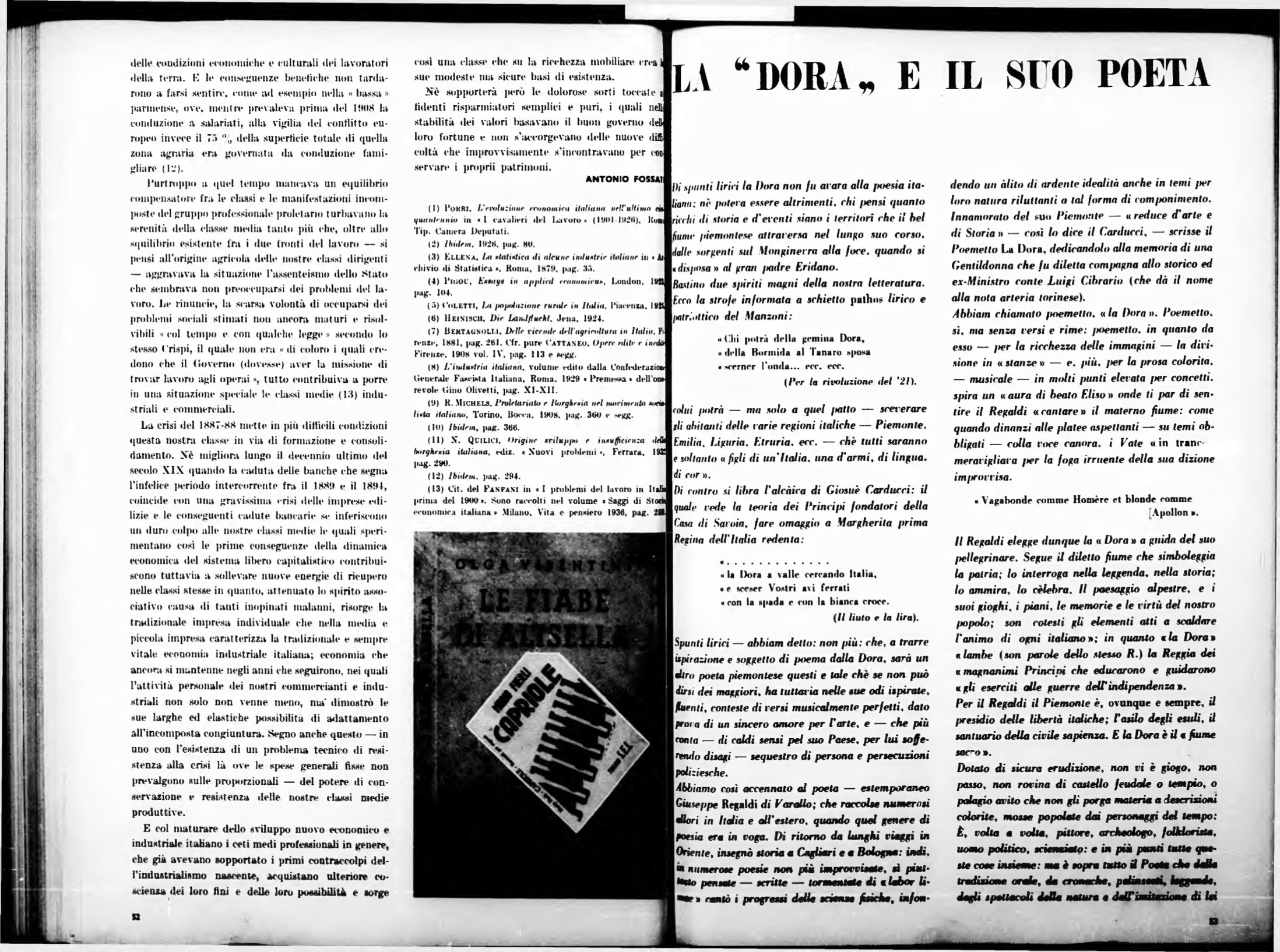
delle coudizioni economiche e culturali «lei lavoratori
•Iella terra. E le conseguenze benetìche non tarda
rono a farsi sentire, come ad esempio nella « bassa »
parmense, ove, mentre prevaleva prima del 11*08 la
conduzione a salariati, alla vigilia del conflitto eu
ropeo invece il 7"» °0 della superficie totale di quella
zona agraria era governata da conduzione fami
gliare (1U).
Purtroppo a quel tempo mancava un equilibrio
compensatore fra le classi e le manifestazioni incom
poste del gruppo professionale proletario turbavano la
serenità della classe media tanto più che, oltre allo
squilibrio esistente fra i due fronti «lei lavoro — si
pensi all’origine agricola delle nostre classi dirigenti
— aggravava la situazione l'assenteismo dello Stato
che sembrava non preoccuparsi dei problemi del la
voro. Le rinuncie, la scarsa volontà «li occuparsi dei
problemi sociali stimati non ancora maturi e ristd-
vibili «col tempo e con qualche legge » secondo lo
stesso <'rispi, il «(uale non era « «li coloro i quali cre-
«lono che il Governo (dov«*sse) aver la missione di
trovar lavoro agli operai », tutto contribuiva a porre
in una situazione speciale le classi medie (13) indu-
striali e commerciali.
La crisi «lei 1887-88 mette in più difficili condizioni
«luesta nostra classe in via di formazione e consoli
damento. Xe migliora lungo il decennio ultimo «l«‘l
secolo XIX quando la caduta delle banche che segna
l’infelice periodo intercorrente fra il 1880 e il 1801,
coincide con una gravissima
«Tisi
«Ielle imprese edi
lizie e le conseguenti cadute bancarie se inferiscono
un «luro colpo alle nostre classi medie le «juali speri
mentano così le prime conseguenze della dinamica
economica del sistema libero capitalistico contribui
scono tuttavia a sollevare nuove energie «li ricupero
nelle classi stesse in quanto, attenuato Io spirito asso
ciativo causa di tanti inopinati malanni, risorge la
tradizionale impresa individuale che nella media e
piccola impresa caratterizza la tradizionale e sempre
vitale economia industriale italiana; economia «-he
ancora si mantenne negli anni ehe seguirom», nei quali
l’attività personale «lei nostri commercianti e in«lu-
striali non solo non venne meno, ma' dimostrò le
sue larghe ed elastiche possibilità «li a«lattamento
all’incomposta congiuntura. Segno anche questo — in
uno con l’esistenza «li un problema tecnico «li resi
stenza alla crisi là ove le spese generab fisse non
prevalgono sulle pro|H>rzionali — del potere di con
servazione e resistenza «Ielle nostre classi medie
produttive.
E col maturare dello sviluppo nuovo economico e
industriale itabano i ceti medi professionali in genere,
che già avevano sopportato i primi contraccolpi del-
l’imiustrialismo nascente, acquistano ulteriore co
scienza dei loro fini e delle loro possibilità e sorge
a
così una «‘lasse «-I
h
*
su
la ricchezza mobiliare crea I
sue modeste ma sicure basi di esistenza.
JSe sopporterà però le tlolorose sorti toccate i
fidenti risparmiatori semplici e puri, i quali nell
stabilità «lei valori basavano il buon governo deli-
loro f«>rtune e non s’accorgevano «Ielle nuove di®
colta che improvvisamente s’incontravano per
«oh
servar»* i proprii patrimoni.
A N TO N IO FOSSA1
(1)
P
o rri
,
L'evoluzione economica italiana uri!'ultimo ai
guant^nnio in >1 cavalieri ilei Lavoro» (190|-I92<>), Kob
Tip. Cameru Deputati.
(2) Ibidem. 1926, pag. 80.
(3)
K
llesa
,
La *tati*tica ili alcune imluxtrie italiane in
•Al
«•liivio ili Statistica », Roma,
pag. 35.
(4) l’uior, Kntays in a/i/died econoinicu», London, 1921
pag. 104.
(5) C
oletti
,
La popolazione rurale in Itaiin. Piacenza, 1925
(ti) Heimscìi,
Die LanJflueht.
Jena,
1824.
(7)
1ÌEKTAUNOLI.1,
Delle vicende dell'agricoltura in Italia.
Fi
renze, 1881, pag. 2til. Cfr. pure
C
attaneo
,
Opere edite e inedè
Firenze, 1908 voi. IV. pag. 113 e segg.
(
8
) L'iiuluxtria italiana, volume edito dalla Confederazioot
Generale Fascista Italiana, Roma. 1929 « Premessa » dello»
revole liino Olivetti, pag. X I-X II.
(9) R. MiCHELS. Proletariato e Itorghenia nel movimento noci»
lixta italiano, Torino, Bocca, 1908. pag. 3ti0 e *egg.
(
10
) Ibidem, pag. 3titi.
(11) X. Qt’lLlCI, Origine Hrilup/H) e inHuflicienza deh
borghesia italiana,
ediz.
*
Nuovi problemi
»,
Ferrara,
19£
pag. 290.
(12) Ibidem, pag. 294.
(13) L’it. del
F
an fasi
in • I problemi del lavoro in Itabi
prima del 1900>. Sono raccolti nel volume «Saggi di Stoni
economica italiana > Milano, V'ita e pensiero 1936, pag. 2H.
LA “ DORA* E
Di spunti lirici la Dora non fu avara alla
/toesia ita
liana: nò /loteva essere altrimenti, chi
/tensi quanto
ricchi ili storia e d'eventi siano i territori che il bel
fiume iliemontese attraversa nel lutino suo corso,
ilalle sorgenti sul Monginevra alla foce, quando si
*disitosa» al gran /mire Eridano.
Bastino due spiriti magni della nostra letteratura.
Ecco la strofe informata a schietto
pathos
lirico e
jntriottico del Manzoni:
« (.Ili potrà della g«*miiia Dora,
«della B«irinida al Tanaro sposa
«M'erner l*on«la... ecc. ecc.
(Per la rivoluziono del '21).
colui potrà
—
ma solo a quel
/tatto
—
sceverare
gli altitanti delle varie regioni italiche
—
Piemonte.
Emilia. Liguria, Etruria. ecc.
—
che tutti saranno
esoltanto
«
figli di un'Italia, una d'armi, di lingua.
di cor
».
Di contro si libra l'alcàica di Giosuè Carducci: il
quale vede la te*tria dei Principi fondatori della
Casa di Savoia, fare omaggio a Margherita prima
Regina dell'Italia re<lenta:
U.............................
« la Dora a valle cercando Italia,
m
e soeser Vostri avi ferrati
« con la spada e ron la bianca croce.
(//
liuto e la lira).
Spunti lirici
—
abbiam detto: non più: che, a trarre
ispirazione e soggetto di poema dalla Dora, sarà un
altro imeta piemontese questi e tale che se non può
dirsi dei maggiori
,
ha tuttavia nelle sue odi ispirate,
fluenti, conteste di versi musicalmente perfetti, dato
prora di un sincero amore /ter l'arte, e
—
che più
fonia
—
di caldi sensi pel suo Paese
,
per lui soffe-
renilo disagi
—
sequestro di persona e persecuzioni
poliziesche.
Abbiamo così accennato al poeta
—
estemporaneo
Giuseppe
Regaldi
di Varallo; che raccolse numerosi
allori in Italia e all'estero, quando quel genere di
poesia era in voga. Di ritorno dm lunghi viaggi in
Oriente, insegnò storim
a
Cagliari e mBologna: indi,
numerose poesie non
più
improvvisate, si piut-
N o pensale —
scritte
—
tormentate di
c
Imbor li-
■»*
cantò i progressi delle
scienze fisiche, infon
-
IL ST O POETA
dendo un àlito di ardente idealità anche in temi /ter
loro natura riluttanti a tal forma di componimento.
Innamorato del
suo
Piemonte
— «
reduce d arte e
di Storia
» —
così lo dice il Carducci,
— scrisse
il
Poemetto
La Dora,
dedicandolo alla memoria di una
Gentildonna che fu diletta coni{taglia allo storico ed
ex-Ministro conte Luigi Cibrario
(che dà il nome
alla nota arteria torinese).
Abbiam chiamato poemetto.
«
la Dora
».
Poemetto.
sì,
ma senza versi e rime: jtoemelto. in quanto da
esso
—
jter la ricchezza delle immagini
—
la divi
sione in
«
stanze
» —
e, più. {ter la prosa colorita.
—
musicale
—
in molti punti elevata
/ter concetti,
spira un
«
aura di beato Eliso
»
onde ti ftar di sen
tire il Regaldi
«
cantare
»
il materno fiume: come
quando dinanzi alle platee aspettanti
—
su
temi ob
bligati
—
colla voce canora, i Vate
«
in tranc
meravigliava
/ter la foga irruente della sua dizione
imftravvisa.
« Vagabonde romme Honière et blonde comme
Apollon ».
Il Regaldi elegge dunque la
«
Dora
»
a guida del suo
jtellegrincure. Segue il diletto fiume che simboleggia
la patria; lo interroga nella leggenda
,
nella storia;
lo ammira, lo celebra. Il paesaggio alpestre, e i
suoi gioghi
,
i piani, le memorie e le virtù del nostro
Itopolo; son cotesti gli elementi atti a scaldare
l'animo di ogni italiano
»;
in quanto ala Dora
»
aiambe
(son
parole dello stesso R.) la Reggia dei
«
magnanimi Principi che educarono e guidarono
agli eserciti alle guerre delTindi/tendenza
».
Per il Regaldi il Piemonte è,
ovunque
e sempre,
il
presidio delle libertà italiche; Posilo degli esidi, il
santuario della civile sapienza
.
E la Dora è il a fiume
sac~o
».
Dotato di sicura erudizione
,
non
vi è giogo, non
passo
,
non rovina di castello feudale o tempio, o
palagio avito che non gli porga materia a descrizioni
colorite, mosse popolate dai personaggi del tempo:
È, voltn m voltm
,
pittore, archeologo, foUclorista,
uomo politico, scienziato: e in più punti tutte que
ste cose insieme: mmè soprm tutto il Poeta che dmUa
tradizione
orale,
dmcronache, palinsesti, leggende,
dagli spettacoli dattm nmturma dall'imitazione di lei
U


















