
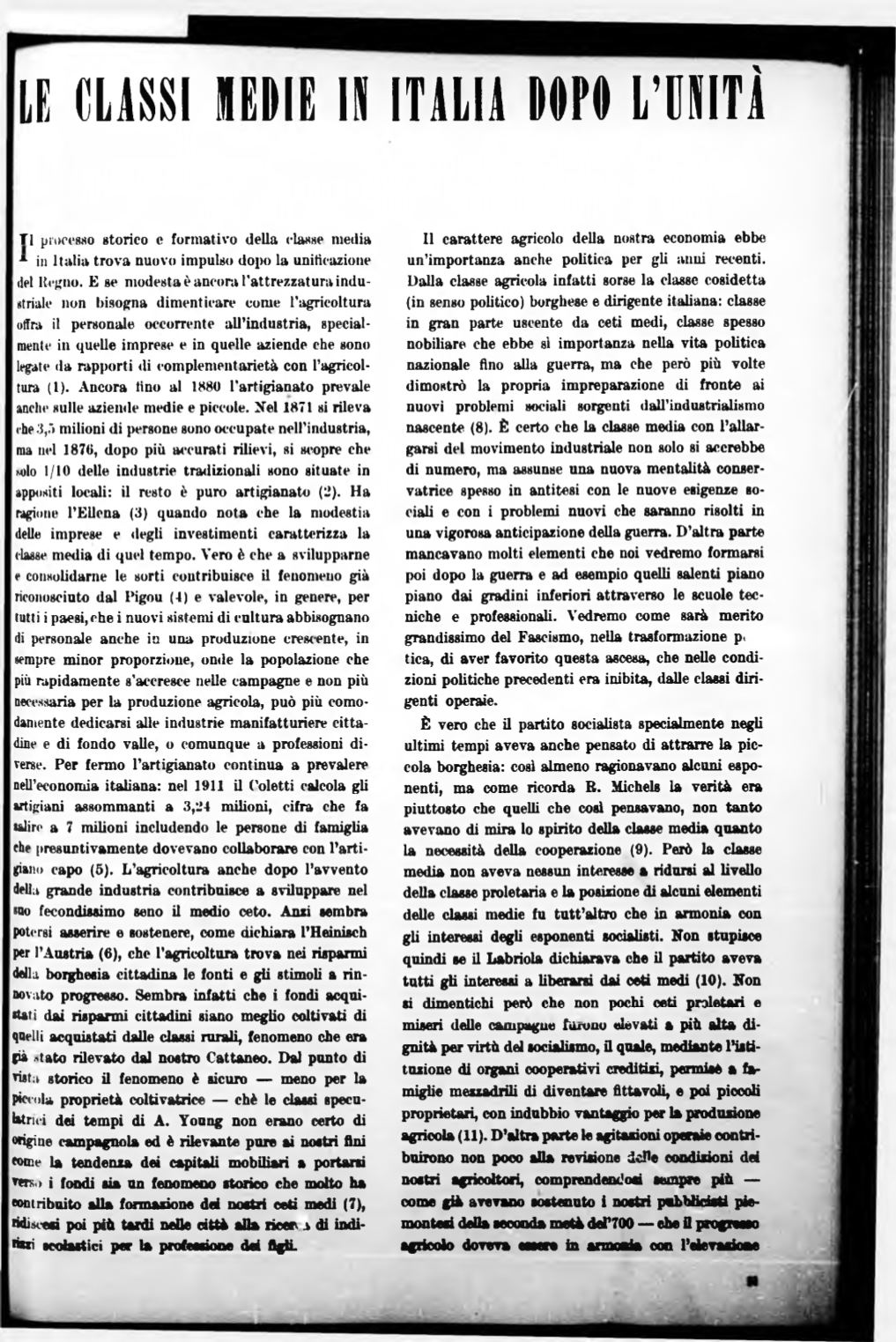
LI! CLASSI MEDIE IH ITALIA DOPO L’UNITÀ
TI
processo
storico e formativo della classe media
-*• in Italia trova nuovo impulso dopo la unificazione
del Regno. E se modesta èancora l'attrezzatura indu
striale non bisogna dimenticare come l’agricoltura
offra il personale occorrente all’industria, special-
mente in quelle imprese e in quelle aziende che sono
legate da rapporti «li complementarietà con l'agricol
tura (1). Ancora fino al 1880 l'artigianato prevale
anche sulle aziemle medie e piccole. Nel 1871 si rileva
che
3f.ì
milioni di persone sono occupate neU’industria,
ma nel 1876, dopo più accurati rilievi, si scopre che
m)
1
o
1/10
delle industrie tradizionali sono situate in
appositi locali: il resto è puro artigianato (lì). Ha
ragione l’Ellena (3) quando nota che la modestia
delle imprese e degli investimenti caratterizza la
classe media di quel tempo. Vero è che a svilupparne
e consolidarne le sorti contribuisce il fenomeno già
riconosciuto dal Pigou (4) e valevole, in genere, per
tutti i paesi,che i nuovi sistemi di cultura abbisognano
di personale anche in una produzione crescente, in
sempre minor proporzi«me, on«le la popolazione che
più rapidamente s’accresce nelle campagne e non più
necessaria per la produzione agricola, può più como
damente dedicarsi alle industrie manifatturiere citta
dine e di fondo valle, o comunque a professioni di
verse. Per fermo l’artigianato continua a prevalere
nell’economia italiana: nel 1911 il (’oletti calcola gli
artigiani assommanti a 3,24 milioni, cifra che fa
salire a 7 milioni includendo le persone di famiglia
che presuntivamente dovevano collaborare con Parti
giano capo (5). L’agricoltura anche dopo l’avvento
della grande industria contribuisce a sviluppare nel
suo
fecondissimo
seno
il medio
ceto.
Anzi sembra
pot<*rsi
asserire e
sostenere,
come dichiara l’Heinisch
per
l’Austria
(6), che
l’agricoltura trova nei risparmi
della
borghesia cittadina le fonti e gli stimoli a rin
novato
progresso. Sembra infatti che i fondi acqui
stati
dai rispanni cittadini siano meglio coltivati di
quelli
acquistati dalle classi rurali, fenomeno che era
già
.'tato rilevato dal nostro Cattaneo. Dal punto di
rista
storico il fenomeno è sicuro — meno per la
piccola
proprietà coltivatrice — chè le classi specu-
latriei
dei tempi di A. Young non erano certo di
origine
campagnola ed è rilevante poro ai nostri fini
tome la tendenza dei capitali mobiliari
a
portarsi
Ters’>i fondi aia un fenomeno
storico
che molto
ha
contribuito alla formazione
dei nostri ceti medi
(7),
ridiscesi
poi più tardi nelle città alla ricer i di indi-
ritti
scolastici per la professione dei figli.
Il carattere agricolo della nostra economia ebbe
un’importanza anche politica per gli anni recenti.
Dalla classe agricola infatti sorse la classe cosidetta
(in senso politico) borghese e dirigente italiana: classe
in gran parte uscente da ceti medi, classe spesso
nobiliare che ebbe sì importanza nella vita politica
nazionale fino alla guerra, ma che però più volte
dimostrò la propria impreparazione di fronte ai
nuovi problemi sociali sorgenti dall’industrialismo
nascente (8). È certo che la classe media con l’allar
garsi del movimento industriale non solo si accrebbe
di numero, ma assunse una nuova mentalità conser
vatrice spesso in antitesi con le nuove esigenze so
ciali e con i problemi nuovi che saranno risolti in
una vigorosa anticipazione della guerra. D’altra parte
mancavano molti elementi che noi vedremo formarsi
poi dopo la guerra e ad esempio quelli salenti piano
piano dai gradini inferiori attraverso le scuole tec
niche e professionali. Vedremo come sarà merito
grandissimo del Fascismo, nella trasformazione p<
tica, di aver favorito questa ascesa, che nelle condi
zioni politiche precedenti era inibita, dalle classi diri
genti operaie.
È vero che il partito socialista specialmente negli
ultimi tempi aveva anche pensato di attrarre la pic
cola borghesia: così almeno ragionavano alcuni espo
nenti, ma come ricorda R. Michels la verità era
piuttosto che quelli che cori pensavano, non tanto
avevano di mira lo spirito della classe media quanto
la necessità della cooperazione (9). Però la classe
media non aveva nessun interesse
a
ridursi al livello
della classe proletaria e la posizione di alcuni elementi
delle classi medie fu tutt’altro che in armonia con
gli interessi degli esponenti socialisti. Non stupisce
quindi se il Labriola dichiarava che il partito
aveva
tutti gli interessi a liberarsi dai ceti medi (10). Non
si dimentichi però che non pochi ceti proletari e
miseri delle campagne furono elevati a più alta di
gnità
per
virtù del socialismo, il quale, mediante l’isti
tuzione di organi cooperativi creditizi,
permisè a fa
miglie mezzadrili di diventare
fittavoli, e poi piccoli
proprietari, con indubbio
vantaggio per la produzione
agricola (11).D’altraparte
le
agitazionioperaiecontri
buirono non poco alla revisione dcDe condizioni dò
nostri agricoltori, comprendendosi sempre più —
come
già
avevano sostenuto
i nostri
pubblicisti pie
montesi della seconda
metà
del’700—cheil
profr—o
agricolo dover» essere in armonia con l’eievaakme


















