
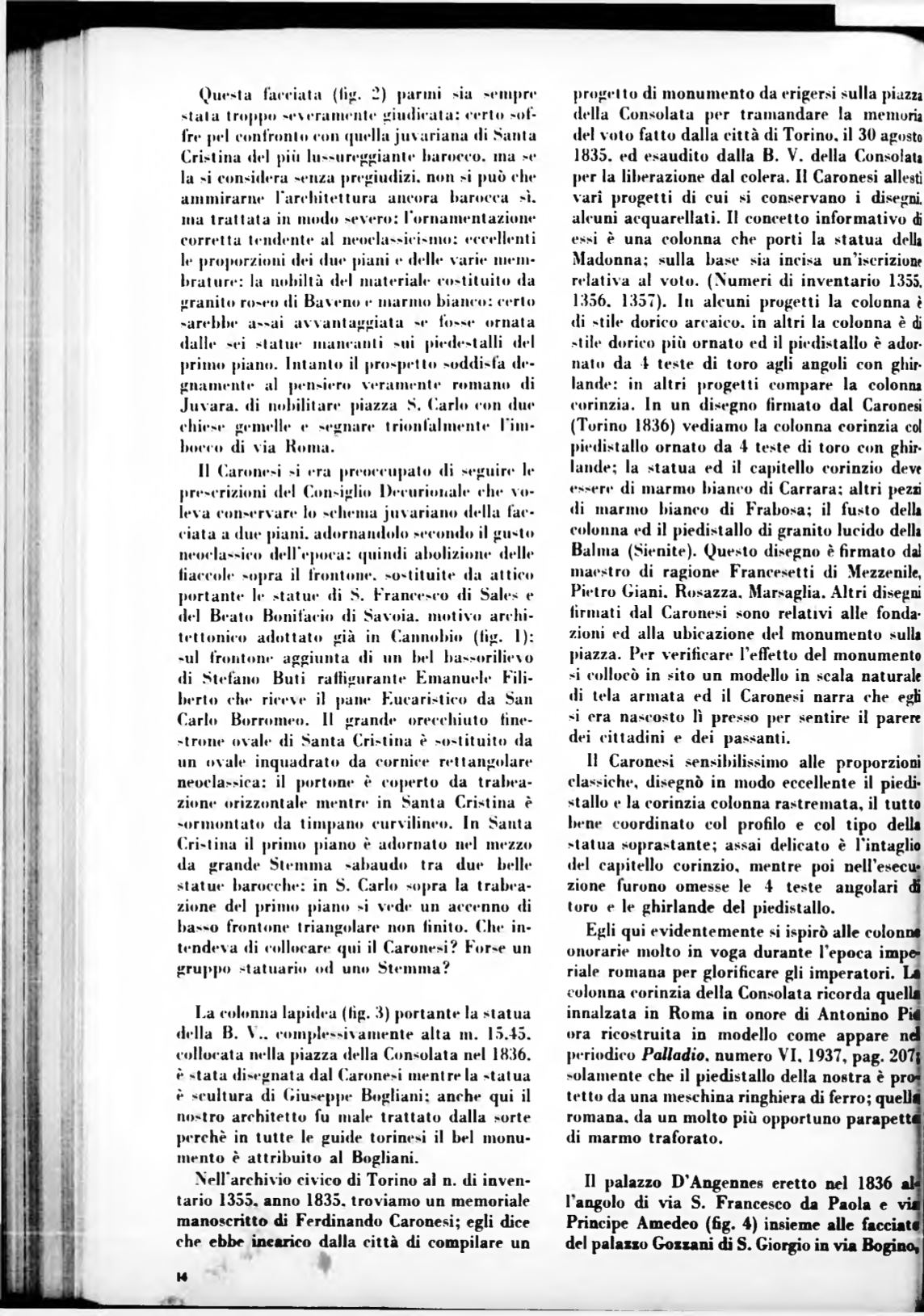
Questa facciata (fi*:. 2) panni sia sempre
stata troppo severamente giudicata: certo sof-
fre pel confronto con quella juvariana di Santa
Cristina «lei più lussureggiante barocco, ina se
la si considera senza pregiudizi, non si può che
a
ili
mirarne l'architettura ancora barocca sì.
ma trattata in modo severo: l'ornamentazione
corretta tendente al neoclassicismo: eccellenti
le proporzioni dei due piani e delle varie mem
brature: la nobiltà del materiale costituito da
granito
roseo
di Baveno
e
marmo bianco: certo
sarebbe
assai
avvan taggiata
se
fosse ornata
dalle "ei statue mancanti sui piedestalli del
primo piano. Intanto il prospetto soddisfa de
gnamente al pensiero veramente romano di
Juvara. di nobilitare piazza S. Carlo con due
chiese gemelle e segnare trionfalm ente l ini-
r
”
boero di via Roma.
Il
Caronesi si era preoccupato «li seguire le
prescrizioni del Consiglio Decurionale che v o
leva conservare lo schema juvariano della fac
ciata a due piani, adornandolo secondo il gusto
neoclassico dell’epoca : (piindi abolizione delle
fiaccole sopra il frontone, sostituite da attico
portante le statue di S. Francesco di Sales e
del Beato Bonifacio di Savoia, m o tivo archi
tettonico adottato già in Cannobio (fìg. 1);
'ili frontone aggiunta di un bel bassorilievo
r r
di Stefano Buti raffigurante Emanuele F ili
berto che riceve il pane Eucaristico da San
Carlo Borromeo. Il grande orecchiuto fine-
strone ovale di Santa Cristina è sostituito da
un ovale inquadrato da cornice rettangolare
neoclassica: il portone è coperto da trabea
zione orizzontale mentre in Santa Cristina è
sormontato da timpano curvilineo. In Santa
Cristina il primo piano è adornato nel mezzo
da grande Stemma sabaudo tra due belle
statue barocche: in S. Carlo sopra la trabea
zione del primo piano si vede un accenno di
basso frontone triangolare non finito. Che in
tendeva di collocare qui il Caronesi? Forse un
gruppo statuario od uno Stemma?
La colonna lapidea ( fìg. 3) portante la statua
della B. \ .. complessivamente alta m. 15.45.
collocata nella piazza della Consolata nel 1836.
è stata disegnata dal Caronesi mentre la statua
è scultura di Giuseppe Bogliani: anche qui il
nostro architetto fu male tratta to dalla sorte
perchè in tutte le guide torinesi il bel monu
mento è attribu ito al Bogliani.
N ell’ archivio civico di Torino al n. di inven
tario 1355. anno 1835. troviam o un memoriale
manoscritto di Ferdinando Caronesi; egli dice
che ebbe incarico dalla città di compilare un
M
progetto di monumento da erigersi sulla piazza
della Consolata per tramandare la memoria
del voto fatto dalla città di Torino, il 30 agosto
1835. ed esaudito dalla B. V. della Consolat
per la liberazione dal colera. Il Caronesi allestì
vari p rogetti di cui si conservano i disegni,
alcuni acquarellati. Il concetto in form ativo di
essi è una colonna che porti la statua della
Madonna: sulla base sia incisa un’iscrizionf
relativa al voto . (Num eri di inventario 1355.
1356. 1357). In alcuni progetti la colonna è
di stile dorico arcaico, in altri la colonna è di
stih* dorico più ornato ed il piedistallo è ador
nato da 4 teste di toro agli angoli con ghir
lande: in altri p rogetti compare la colonna
corinzia. In un disegno firmato dal Caronesi
(Torino 1836) ved iam o la colonna corinzia col
piedistallo ornato da 4 teste di toro con ghir
lande; la statua ed il capitello corinzio deve
essere di marmo bianco di Carrara; altri pezzi
di marmo bianco di Frabosa; il fusto della
colonna ed il piedistallo di granito lucido della
Ballila (Sienite). Questo disegno è firmato dal
maestro di ragione Francesetti di Mezzenile,
Pietro Giani. Rosazza, Marsaglia. A ltri disegni
firmati dal Caronesi sono relativi alle fonda
zioni ed alla ubicazione del monumento sulla
piazza. Per verificare 1’efFetto del monumento
si collocò in sito un modello in scala naturale
di tela armata ed il Caronesi narra che egli
si era nascosto lì presso per sentire il parere
dei cittadin i e dei passanti.
Il
Caronesi sensibilissimo alle proporzio
classiche, disegnò in modo eccellente il piedi*
stallo e la corinzia colonna rastremata, il tutto
bene coordinato col profilo e col tipo della
statua soprastante; assai delicato è l'intaglio
del capitello corinzio, mentre poi nell’esecu»
zione furono omesse le 4 teste angolari (fi
toro e le ghirlande del piedistallo.
Egli qui evidentem ente si ispirò alle colonnt
onorarie molto in vo g a durante Pepoca impe
riale romana per glorificare gli imperatori.
La
colonna corinzia della Consolata ricorda quella
innalzata in Rom a in onore di Antonino Pi#
ora ricostruita in modello come appare nel
periodico
Palladio,
numero V I, 1937, pag. 207;
solamente che il piedistallo della nostra è pro«
tetto da una meschina ringhiera di ferro; quell#
romana, da un m olto più opportuno p a ra p e tti
di marmo traforato.
Il palazzo D'Angennes eretto nel 1836 al*
1angolo di via S. Francesco da Paola e via
Principe Amedeo (fig. 4) insieme alle facciata
del palazzo Gozzani di S. Giorgio in via Bogino,


















