
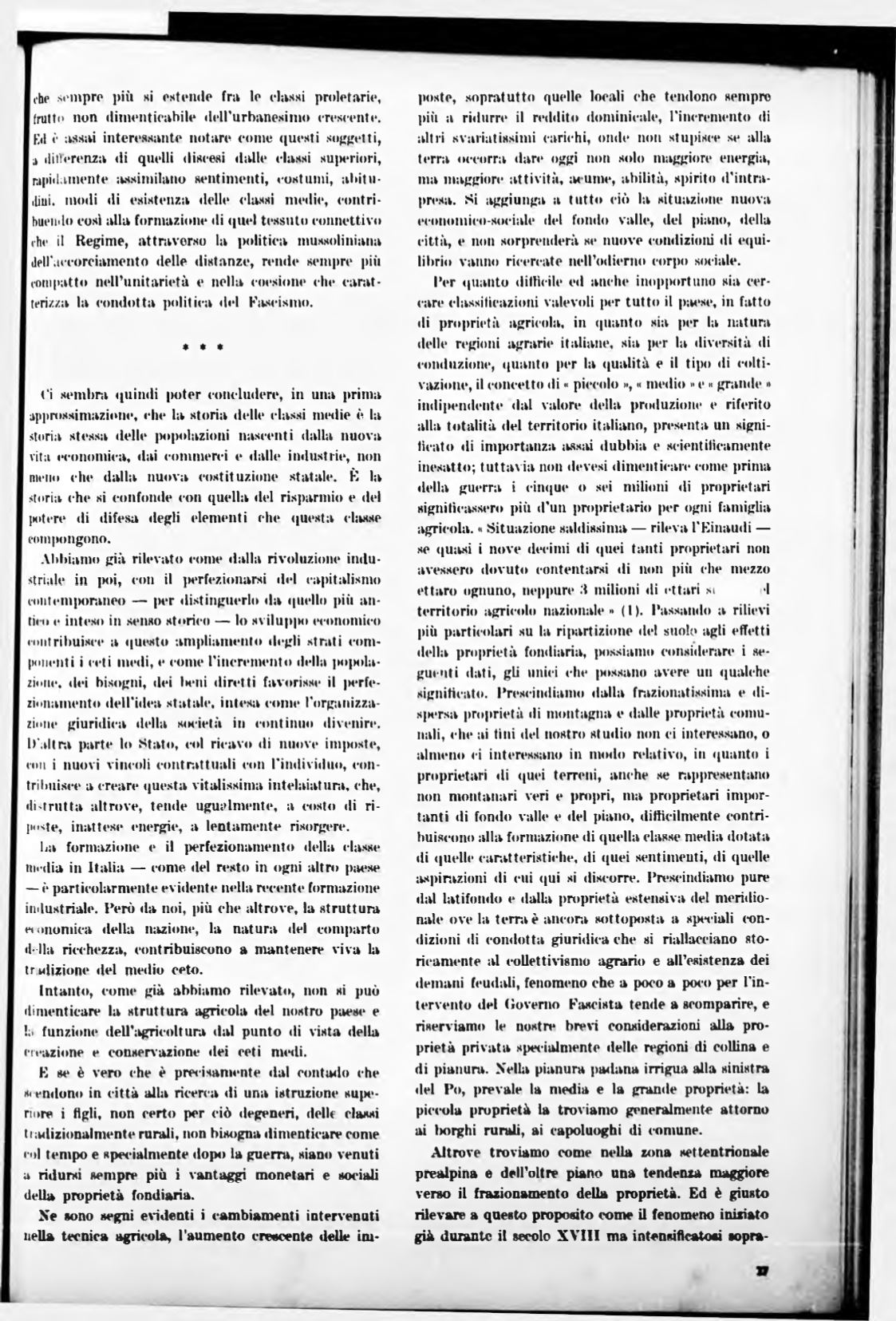
che sempre più si estende fra le classi proletarie,
frutti» non dimenticatale dell'urbanesimo crescente.
Ed è assai interessante notare come questi soggetti,
■
a
ditìerenza di quelli discesi dalle classi superiori,
ripidamente assimilano sentimenti, costumi, abitu
dini. modi di esistenza «Ielle classi medie, contri
buendo così alla formazione di quel tessuto connettivo
che il Regime, attraverso la politica mussoliniana
dell’accorciamento «Ielle distanze, rende sempre più
compatto nell’unitarietà e nella coesione che carat
terizza la condotta politica del Fascismo.
* * *
Ci sembra quindi poter concludere, in una prima
approssimazione, che la storia delle classi medie è la
storia stessa delle popolazioni nascenti dalla nuova
vit;i economica, dai commerci e dalle industrie, non
meno che dalla nuova costituzione statale. È la
storia che si confonde con quella del risparmio e del
potere di difesa degli elementi che questa classe
compongono.
Abbiamo già rilevato come dalla rivoluzione indu
striale in poi, con il perfezionarsi del capitalismo
contemporaneo — per distinguerlo ila quello più ali
tilo e inteso in senso storico — lo sviluppo economico
contribuisce a questo ampliamento titoli strati com
ponenti i ceti medi, e come l'incremento della popola
zione, dei bisogni, dei tieni diretti favorisse il perfe
zionamento dell'idea statale, intesa come ('organizza
zione giuridica della società in continuo divenire.
D'altra parte lo Stato, col ricavo di nuove imposte,
con i nuovi vincoli contrattuali con l'individuo, con
tribuisce a creare questa vitalissima intelaiatura, che,
distrutta altrove, tende ugualmente, a costo di ri-
poste, inattese energie, a lentamente risorgere.
L i formazione e il perfezionamento della classe
media in Italia — come del resto in ogni altro paese
— è particolarmente evidente nella recente formazione
industriale. Però da noi, più che altrove, la struttura
economica della nazione, la natura del comparto
della ricchezza, contribuiscono a mantenere viva la
tr idizione del medio ceto.
Intanto, come già abbiamo rilevato, non si può
dimenticare la struttura agricola del nostro paese e
la funzione dell'agricoltura dal punto di vista della
creazione e conservazione dei ceti medi.
E se è vero che è precisamente dal contado che
*»elidono in città alla ricerca di una istruzione supe
riore i figli, non certo per ciò degeneri, delle classi
tradizionalmente rurali, non bisogna dimenticare come
col tempo e specialmente dopo la guerra, siano venuti
a ridursi sempre più i vantaggi monetari e sociali
della proprietà fondiaria.
Ne sono segni evidenti i cambiamenti intervenuti
nella tecnica agricola, l'aumento crescente delle im
poste, sopratutto quelle locali che tendono sempre
più a ridurre il reddito dominicale, l’incremento di
altri svariatissim i carichi, onde non stupisce se alla
terra occorra dare oggi non solo maggiore energia,
ma maggiore attività, acume, abilità, spirito d’intra-
presa. Si aggiunga a tutto ciò la situazione nuova
eeonomieo-sociale del fondo valle, del piano, della
città, e non sorprenderà se nuove condizioni di equi
librio vanno ricercate nell’odierno corpo sociale.
Per quanto diffìcile ed anche inopportuno sia cer
care classificazioni valevoli per tutto il paese, in fatto
di proprietà agricola, in (pianto sia per la natura
delle regioni agrarie italiane, sia per la diversità di
conduzione, quanto per la qualità e il tipo di colti
vazione, il concetto di «<piccolo », « medio »e « grande »
indipendente dal valore della produzione e riferito
alla totalità del territorio italiano, presenta un signi
ficato di importanza assai dubbia e scientificamente
inesatto; tuttavia non devesi dimenticare come prima
della guerra i cinque o sei milioni di proprietari
significassero più d’un proprietario per ogni famiglia
agricola. « Situazione saldissima — rileva l’ Einaudi —
se quasi i nove decimi di quei tanti proprietari non
avessero dovuto contentarsi di non più che mezzo
ettaro ognuno, neppure
3
milioni di ettari
si
>1
territorio agricolo nazionale » (
1
). Passando a rilievi
più particolari su la ripartizione del suolo agli effetti
della proprietà fondiaria, possiamo considerare i se
guenti dati, gli unici che possano avere un qualche
significato. Prescindiamo dalla frazionatissima e di
sperila proprietà di montagna e dalle proprietà comu
nali, che ai fini ilei nostro studio non ci interessano, o
almeno ci interessano in modo relativo, iu quanto i
proprietari di quei terreni, anche se rappresentano
non montanari veri e propri, ma proprietari impor
tanti di fondo valle e del piano, difficilmente contri
buiscono alla formazione di quella classe media dotata
di quelle caratteristiche, di quei sentimenti, di quelle
aspirazioni di cui qui si discorre. Prescindiamo pure
«lai latifondo e dalla proprietà estensiva del meridio
n a l ove la terra è ancora sottoposta a speciali con
dizioni di condotta giuridica che si riallacciano sto-
ricamente al collettivismo agrario e all’esistenza dei
demani fcu«lali, fenomeno che a poco a poco per l'in
tervento del (ìoverno Fascista ten«le a scomparire, e
riserviamo le nostre brevi considerazioni alla pro
prietà privata specialmente «Ielle regioni di collina e
di pianura. Nella pianura padana irrigua alla sinistra
«lei Po, prevale la media e la grande proprietà: la
piccola proprietà la troviamo generalmente attorno
ai liorghi rurali, ai capoluoghi di comune.
Altrove troviamo come nella zona settentrionale
prealpina e dell’oltre piano una tendenza maggiore
verso il frazionamento della proprietà. Ed è giusto
rilevare a questo proposito come il fenomeno iniziato
già durante il secolo X V III ma intensificatosi sopra


















