
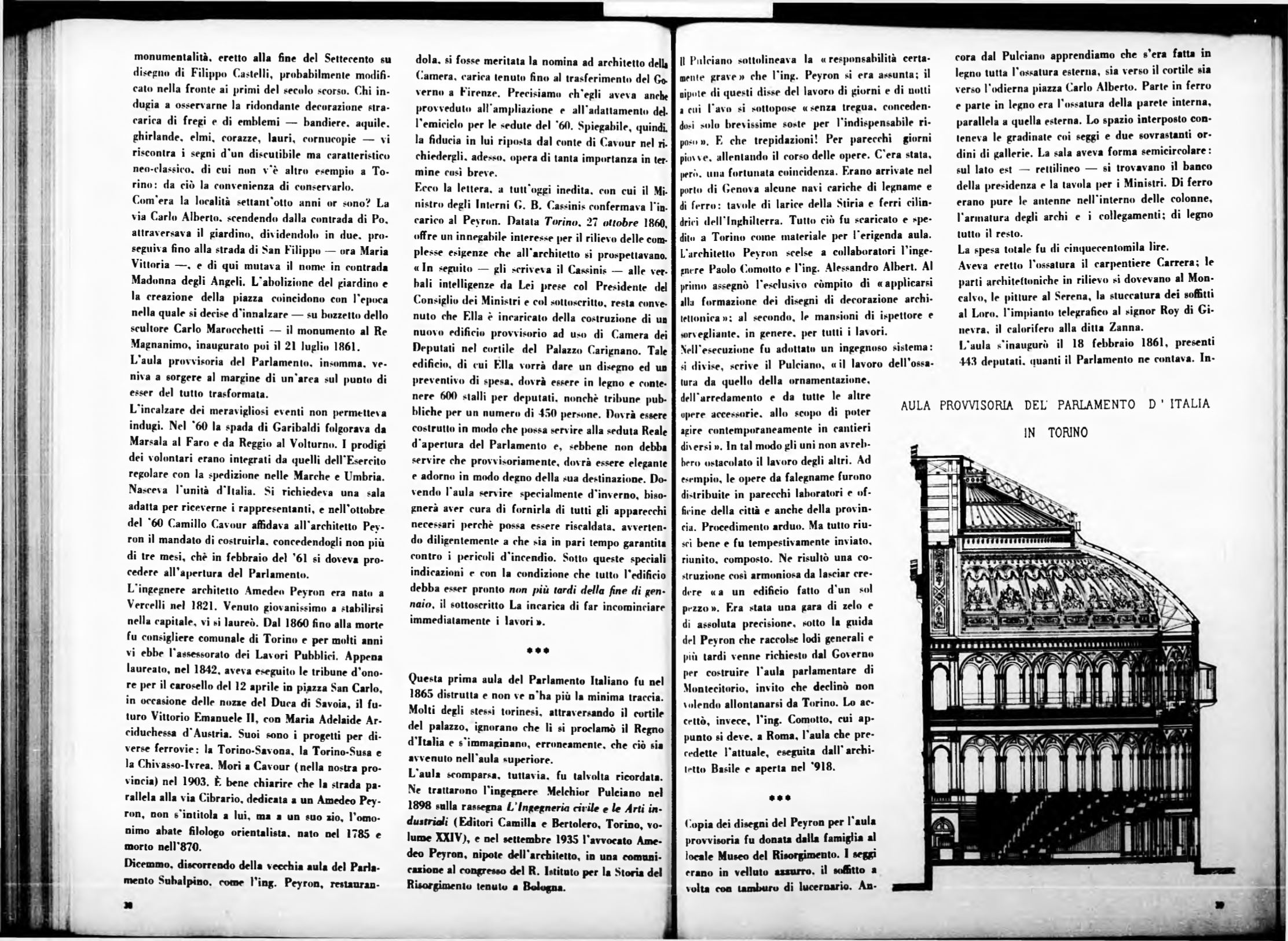
monumentalità, eretto alla fine del Settecento su
disegno di Filippo Castelli, probabilmente modifi
cato nella fronte ai primi del secolo scorso. Chi in
dugia a osservarne la ridondante decorazione stra
carica di fregi e di emblemi — bandiere, aquile,
ghirlande, elmi, corazze, lauri, cornucopie — vi
riscontra i segni d'un discutibile ma caratteristico
neo-classico, di cui non v*è altro esempio a T o
rino: da ciò la convenienza di conservarlo.
ConTera la località settant'otto anni or sono? La
via Carlo Alberto, scendendo dalla contrada di Po.
attraversava il giardino, dividendolo in due, pro
seguiva fino alla strada di San Filippo — ora Maria
Vittoria — , e di qui mutava il nome in contrada
Madonna degli Angeli. L'abolizione del giardino e
la creazione della piazza coincidono con l'epoca
nella quale si decise d'innalzare — su bozzetto dello
scultore Carlo Marocchetti — il monumento al Re
Magnanimo, inaugurato poi il
21
luglio
1861.
L'aula provvisoria del Parlamento, insomma, ve
niva a sorgere al margine di un'area sul punto di
esser del tutto trasformata.
L'incalzare dei meravigliosi eventi non permetteva
indugi. Nel
'60
la spada di Garibaldi folgorava da
Marsala al Faro e da Reggio al Volturno. I prodigi
dei volontari erano integrati da quelli dell'Esercito
regolare con la spedizione nelle Marche e Umbria.
Nasceva l'unità d'Italia. Si richiedeva una sala
adatta per riceverne i rappresentanti, e ncH'ottobre
del
'60
Camillo Cavour affidava all'architetto Pey-
ron il mandato di costruirla, concedendogli non più
di tre mesi, che in febbraio del
'61
si doveva pro
cedere all'apertura del Parlamento.
L'ingegnere architetto Amedeo Peyron era nato a
Vercelli nel
1821.
Venuto giovanissimo a stabilirsi
nella capitale, vi si laureò. Dal
1860
fino alla morte
fu consigliere comunale di Torino e per molti anni
vi ebbe l'assessorato dei Lavori Pubblici. Appena
laureato, nel
1842,
aveva eseguito le tribune d’ ono
re per il carosello del 12 aprile in piazza San Carlo,
in occasione delle nozze del Duca di Savoia, il fu
turo Vittorio Emanuele II, con Maria Adelaide Ar
ciduchessa d'Austria. Suoi sono i progetti per di
verse ferrovie: la Torino-Savona. la Torino-Susa e
la Chivasso-Ivrea. Morì a Cavour (nella nostra pro
vincia) nel
1903.
fc bene chiarire che la strada pa
rallela alla via Cibrario, dedicata a un Amedeo Pey
ron, non s'intitola a lui, ma a un suo zio, l'omo
nimo abate Biologo orientalista, nato nel 1785 e
morto nell'870.
Dicemmo, discorrendo della vecchia aula del Parla
mento Subalpino, come Fing. Peyron, restauran
dola. si fosse meritata la nomina ad architetto della
Camera, carica tenuto fino al trasferimento del Go
verno a Firenze. Precisiamo ch'egli aveva anche
provveduto all'ampliazione e all'adattamento del
l'emiciclo per le sedute del
'60.
Spiegabile, quindi
la fiducia in lui riposta dal conte di Cavour nel ri
chiedergli. adesso, opera di tanta importanza in ter
mine cosi breve.
Ecco la lettera, a tutt'oggi inedita, con cui il Mi*
nistro degli Interni G. B. Cassinis confermava l'in
carico al Peyron. Datata
Torino
.
27
ottobre
1860,
ofTre un innegabile interesse per il rilievo delle com
plesse esigenze che all'architetto si prospettavano.
« In seguito — gli scriveva il Cassinis — alle ver
bali intelligenze da Lei prese col Presidente del
Consiglio dei Ministri e col sottoscritto, resta conve
nuto che Ella è incaricato della costruzione di un
nuovo edificio provvisorio ad uso di Camera dei
Deputati nel cortile del Palazzo Carignano. Tale
edificio, di cui Ella vorrà dare un disegno ed un
preventivo di spesa, dovrà essere in legno e conte
nere
600
stalli per deputati, nonché tribune pub
bliche per un numero di
450
persone. Dovrà esgere
costrutto in modo che possa servire alla seduta Reale
d'apertura del Parlamento e, sebbene non debba
servire che provvisoriamente, dovrà essere elegante
e adorno in modo degno della sua destinazione. Do
vendo l'aula servire specialmente d'inverno, biso
gnerà aver cura di fornirla di tutti gli apparecchi
necessari perchè possa essere riscaldata, avverten
do diligentemente a che sia in pari tempo garantita
contro i pericoli d'incendio. Sotto queste speciali
indicazioni e con la condizione che tutto l'edificio
debba esser pronto
non più tardi della fine di pen-
naia
. il sottoscritto La incarica di far incominciare
immediatamente i lav ori ».
* 0 0
Questa prima aula del Parlamento Italiano fu nel
1865
distrutta e non ve n'ha più la minima traccia.
Molti degli stessi torinesi, attraversando il cortile
del palazzo, ignorano che lì si proclamò il Regno
d'Italia e s'immaginano, erroneamente, che ciò sia
avvenuto nell'aula superiore.
L'aula scomparsa, tuttavia, fu talvolta ricordata.
Ne trattarono l'ingegnere Melchior Pulciano nel
1898 sulla rassegna
L'Ingegneria civile e le Arti
in-
dustriali
(Editori Camilla e Bertolero, Torino, vo
lume XXIV), e nel settembre 1935 l'avvocato Ame
deo Peyron, nipote deH'arcbitetto, in una comuni
cazione al congresso del R. Istituto per la Storia del
Risorgimento tenuto a Bologna.
Il Pulciano sottolineava la « responsabilità certa
mente grave» che l'ing. Peyron si era assunta; il
nipote di questi disse del lavoro di giorni e di notti
acni l'avo si sottopose «senza tregua, conceden
do.»! solo brevissime soste per l'indispensabile ri
poso». E che trepidazioni! Per parecchi giorni
piowe, allentando il corso delle opere. C'era stata,
però, una fortunata coincidenza. Erano arrivate nel
porlo di Genova alcune navi cariche di legname e
di ferro: tavole di larice della Stiria e ferri cilin
drici «lell'Inghilterra. Tutto ciò fu scaricato e spe
dilo a Torino coinè materiale per l'erigenda aula.
L'architetto Peyron scelse a collaboratori l'inge
gnere Paolo Comotto e l'ing. Alessandro Albert. Al
primo assegnò l'esclusivo compito di «applicarsi
alla formazione dei disegni di decorazione archi
tettonica >»: al secondo, le mansioni di ispettore e
«orveglia
ii
te. in genere, per tutti i lavori.
Nell’ esecuzione fu adottato un ingegnoso sistema:
si divise, scrive il Pulciano, « il lavoro dell'ossa
tura da quello della ornamentazione,
dell'arredamento e da tutte le altre
opere accessorie, allo scopo di poter
apire contemporaneamente in cantieri
diversi ». In tal modo gli uni non avreb
bero ostacolato il lavoro degli altri. Ad
esempio, le opere da falegname furono
distribuite in parecchi laboratori e o f
ficine della città e anche della provin
cia. Procedimento arduo. Ma tutto riu
scì bene e fu tempestivamente inviato,
riunito, composto. Ne risultò una co
struzione così armoniosa da lasciar cre
dere « a un edifìcio fatto d'un sol
pezzo». Era stata una gara di zelo e
di assoluta precisione, sotto la guida
del Peyron che raccolse lodi generali e
più tardi venne richiesto dal Governo
per costruire l'aula parlamentare di
Montecitorio, invito che declinò non
\olendo allontanarsi da Torino. Lo ac
cettò, invece, l'ing. Comotto, cui ap
punto si deve, a Roma, l'aula che pre
cedette l'attuale, eseguita dall* archi
tetto Basile e aperta nel
*918.
* * •
Copia dei disegni del Peyron per l'aula
provvisoria fu donata dalla famiglia al
locale Museo del Risorgimento. I seggi
erano in velluto azzurro, il Miffitto a
| volta con tamburo di lucernario. An
cora dal Pulciano apprendiamo che s’era fatta in
legno tutta l'ossatura esterna, sia verso il cortile sia
verso l'odierna piazza Carlo Alberto. Parte in ferro
e parte in legno era l'ossatura della parete interna,
parallela a quella esterna. Lo spazio interposto con
teneva le gradinate coi seggi e due sovrastanti or
dini di gallerie. La sala aveva forma semicircolare :
sul lato est — rettilineo — si trovavano il banco
della presidenza e la tavola per i Ministri. Di ferro
erano pure le antenne nell'interno delle colonne,
l'armatura degli archi e i collegamenti; di legno
tutto il resto.
La spesa totale fu di cinquecentomila lire.
Aveva eretto l'ossatura il carpentiere Carrera; le
parli architettoniche in rilievo si dovevano al Mon-
calvo, le pitture al Serena, la stuccatura dei soffitti
al Loro, l'impianto telegrafico al signor Roy di G i
nevra, il calorifero alla ditta Zanna.
I/aula s'inaugurò il
18
febbraio
1861,
presenti
443 deputati, quanti il Parlamento ne contava. In-
AU L A PROVV I SOR I A D E L P A R L AM E N T O
D ’ I T A L I A
IN
TORINO


















