
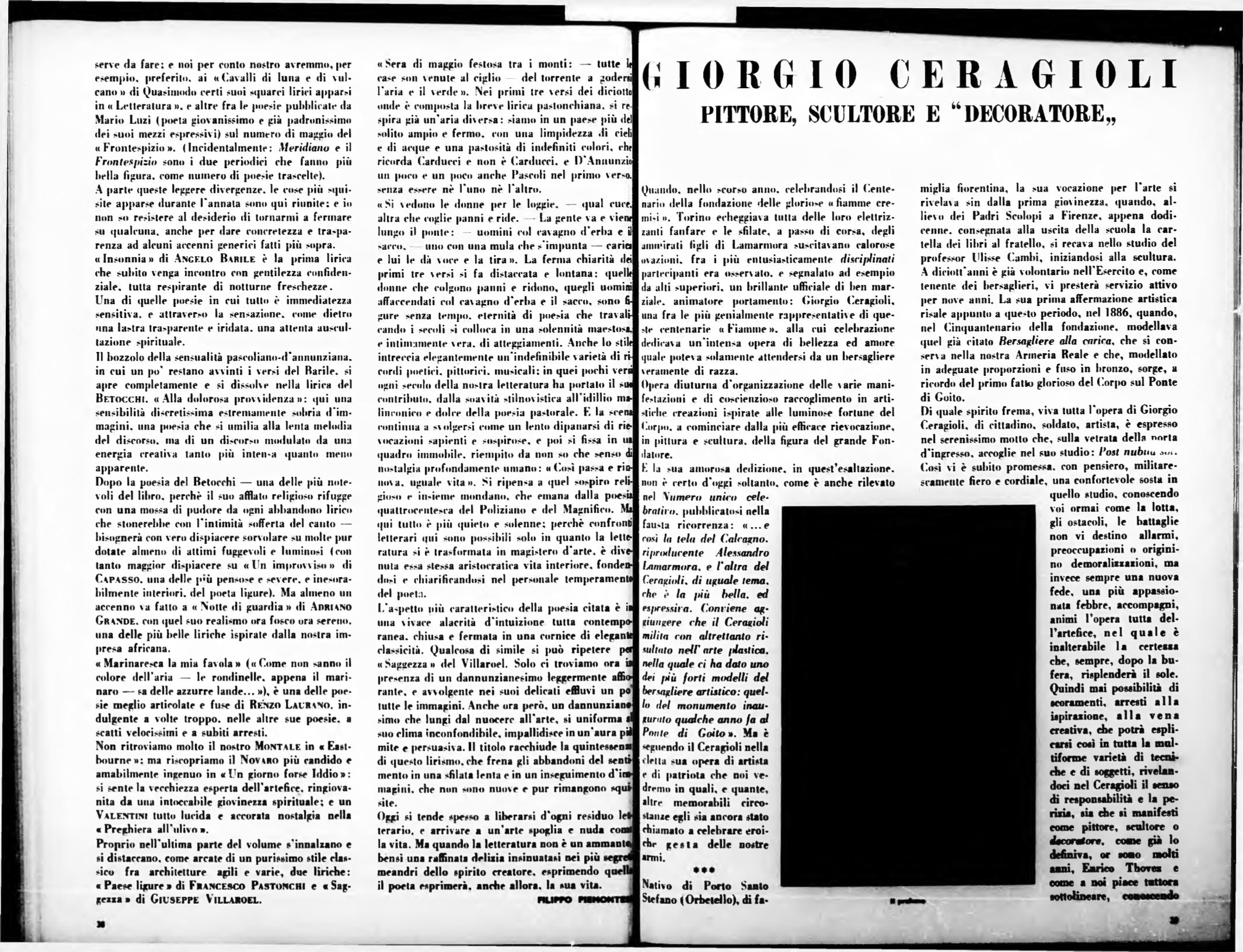
serve da fare; e noi per conto nostro avremmo, per
esempio, preferito, ai «Cavalli di luna e di vul
cano » di Quasimodo certi suoi squarci lirici apparsi
in « Letteratura ». e altre fra le poesie pubblicate da
Mario Luzi (poeta giovanissimo e già padronissimo
dei suoi mezzi espressivi) sul numero di maggio del
«Frontespizio». (Incidentalmente:
Meridiano
e il
Frontespizio
sono i due periodici che fanno più
bella figura, come numero di poesie trascelte).
A parte queste leggere divergenze, le cose più squi
site apparse durante l'annata sono qui riunite: e io
non so resistere al desiderio di tornarmi a fermare
su qualcuna, anche per dare concretezza e traspa
renza ad alcuni accenni generici fatti più sopra.
«(Insonnia» di A
ngelo
B
arile
è la prima lirica
che subito venga incontro con gentilezza eonfiden-
ziale. tutta respirante di notturne freschezze.
Una di quelle poesie in cui tutto è immediatezza
sensitiva, e attraverso la sensazione, come dietro
una lastra trasparente e iridata, una attenta auscul
tazione spirituale.
Il bozzolo della sensualità pascoliano-d'aniiunziana.
in cui un po’ restano avvinti i versi del Barile, si
apre completamente e si dissolve nella lirica del
B
etocchi
. «Alla dolorosa provvidenza»: qui una
sensibilità discretissima estremamente sobria d'im
magini. una poesia che si umilia alla lenta melodia
del discorso, ma di un discorso modulato da una
energia creativa tanto più inten-a (pianto meno
apparente.
Dopo la poesia del Betocchi — una delle più note
voli del libro, perchè il suo afflato religioso rifugge
con una mossa di pudore da ogni abbandono lirico
che stonerebbe con l'intimità sofferta del canto —
bisognerà con vero dispiacere sorvolare su molte pur
dotate almeno di attimi fuggevoli e luminosi (con
tanto maggior dispiacere su «Un improvviso» di
C a p a s s o ,
una delle p»ù pensose e severe, e inesora
bilmente interiori, del poeta ligure). Ma almeno un
accenno va fatto a « Notte di guardia» di
A d r ia n o
G r a n d e ,
con quel suo realismo ora fosco ora sereno,
una delle più belle liriche ispirate dalla nostra im
presa africana.
« Marinaresca la mia favola » (« Come non sanno il
colore dell'aria — le rondinelle, appena il mari
naro — sa delle azzurre lande... »), è una delle poe
sie meglio articolate e fuse di
R e n z o L a u r a n o .
in
dulgente a volte troppo, nelle altre sue poesie, a
scatti velocissimi e a subiti arresti.
Non ritroviamo molto il nostro
M o n t a l e
in « East-
hourne»: ma riscopriamo il
N o v e r o
più candido e
amabilmente ingenuo in «Un giorno forse Iddio»:
si sente la vecchiezza esperta dell'artefice, ringiova
nita da una intoccabile giovinezza spirituale; e un
V a l e n t i n i
tutto lucida e accorata nostalgia nella
« Preghiera all'ulivo ».
Proprio nell'ultima parte del volume s'innalzano e
si distaccano, come arcate di un purissimo stile clas
sico fra architetture agili e varie, due liriche:
«Paese ligure* di
F r a n c e s c o P a s t o n c h i
e «Sag
gezza» di
G iu s e p p e V i l l a r o e l .
« Sera di maggio festosa tra i monti : — tutte le
case son venute al ciglio — del torrente a godersi
l'aria e il verde». Nei primi tre versi dei diciotto
onde è composta la breve lirica pastonchiana, si
re
spira già un'aria diversa: siamo in un paese più del
solito ampio e fermo, con una limpidezza di cieli
e di acque e una pastosità di indefiniti colori, che
ricorda Carducci e non è Carducci, e D'Annunzio
un poco e un poco anche Pascoli nel primo verso,
senza essere nè l'uno nè l'altro.
«Si vedono le donne per le loggie, — (piai cuce,
altra che coglie panni e ride. — La gente va e viene
lungo il ponte: — uomini col cavagno d'erba e il
sacco, — uno con una mula che s'impunta — cario
e lui le dà voce e la tira ». La ferma chiarità dei
primi tre versi si fa distaccata e lontana: quelle
donne che colgono panni e ridono, quegli uomini
affaccendati col cavagno d'erba e il sacco, sono fi
gure senza tempo, eternità di poesia che travali
cando i secoli si colloca in una solennità maestosa,
e intiinumente vera, di atteggiamenti. Anche lo stile
intreccia elegantemente un'indefinibile varietà di ri
cordi poetici, pittorici, musicali; in quei pochi versi
ogni secolo della nostra letteratura ha portato il suo
contributo, dalla soavità stilnovistica all idillio ma
linconico e dolce della poesia pastorale. E la sceni
continua a svolgersi come un lento dipanarsi di rie
vocazioni sapienti e sospirose, e poi si fissa in ua
quadro immobile, riempito da non so che senso di
nostalgia profondamente umano: «Cosi passa e rin
nova. uguale vita». Si ripensa a quel sospiro reli
gioso e insieme mondano, che emana dalla poesii
quattrocentesca del Poliziano e del Magnifico. Mi
((ui tutto è più quieto e solenne; perchè confronti
letterari qui sono possibili solo in quanto la lette
ratura si è trasformata in magistero d'arte, è dive
nula essa stessa aristocratica vita interiore, fonden
dosi e chiarificandosi nel personale temperamene
del poeta.
L'aspetto più caratteristico della poesia citata è il
una vivace alacrità d'intuizione tutta contempo*
ranea. chiusa e fermata in una cornice di elegante
classicità. Qualcosa di simile si può ripetere p<f
« Saggezza » del Villaroel. Solo ri troviamo ora il
presenza di un dannunzianesimo leggermente affio*
rante, e avvolgente nei suoi delicati effluvi un po
tutte le immagini. Anche ora però, un dannunziane
simo che lungi dal nuocere all'arte, si uniforma a
suo clima inconfondihile, impallidisce in un'aura pii
mite e persuasiva.
Il
titolo racchiude la quintessena
di questo lirismo, che frena gli abbandoni del senti1
mento in una sfilata lenta e in un inseguimento d'ir*
magini. che non sono nuove e pur rimangono squ»
site.
Oggi si tende spesso a liberarsi d'ogni residuo lem
terario. e arrivare a un'arte spoglia e nuda comi
la vita. Ma quando la letteratura non è un ammanta»
bensì una raffinata delizia insinuatasi nei più
meandri dello spirito creatore, esprimendo qu
il poeta esprimerà, anche allora, la sua vita.
G I O R G I O C E R A G I O L I
PITTORE, SCULTORE E “ DECORATORE,,
Quando, nello scorso anno, celebrandosi il Cente
nario della fondazione «Ielle gloriose « fiamme cre
ili
i-i ». Torino echeggiava tutta delle loro elettriz
zanti fanfare e le sfilate, a passo di corsa, degli
ammirati figli di Lamarniora suscitavano calorose
ovazioni, fra i più entusiasticamente
disciplinati
partecipanti era osservato, e segnalato ad esempio
da alti superiori, un brillante ufficiale di ben mar
ziale. animatore portamento : Giorgio Ceragioii,
una fra le più genialmente rappresentative di que
ste centenarie « Fiamme ». alla cui celebrazione
dedicava un'intensa opera di bellezza ed amore
quale poteva solamente attendersi da un bersagliere
veramente di razza.
Opera diuturna d'organizzazione delle varie mani
festazioni e di coscienzioso raccoglimento in arti
stiche creazioni ispirate alle luminose fortune del
Corpo, a cominciare dalla più efficace rievocazione,
in pittura e scultura, della figura del grande Fon
datore.
K la sua amorosa dedizione, in quest'esaltazione,
non è certo d'oggi soltanto, come è anche rilevato
nel
Numero unico cele
brativo
. pubblicatosi nella
fausta ricorrenza: « ...e
rosi
la tela del Calcagno,
ripnulucente Alessandro
lAtnarmora. e
l'altra del
Cerasoli, di uguale tema.
che è
la più bella, ed
espressiva. Conviene ag
niunvere che
il Ceranioli
milita
con altrettanto ri
-
sultaio
nell'arte /plastica,
nella
quale ci ha dato uno
dei più forti modelli del
bersagliere artistico: quel
lo
del
monumento inau
gurato
qualche anmt fa al
Ponte di Goito
». Ma è
seguendo il Ceragioii nella
eletta sua opera di artista
e di patriota che noi ve*
(Iremo in quali, e quante,
altre memorabili circo*
stanze egli sia ancora stato
chiamato a celebrare eroi*
che g e s ta delle nostre
armi.
Nativo di Porto Santo
Stefano (Orbetello), di
fa*
miglia fiorentina, la sua vocazione per l'arte si
rivelava sin dalla prima giovinezza, quando, al
lievo dei Padri Scolopi a Firenze, appena dodi
cenne. consegnata alla uscita della scuola la car
tella dei libri al fratello, si recava nello studio del
professor Ulisse Cambi, iniziandosi alla scultura.
A diciott'auni è già volontario neH'Esercito e, come
tenente dei bersaglieri, vi presterà servizio attivo
per nove anni. La sua prima affermazione artistica
risale appunto a questo periodo, nel 1886, quando,
nel Cinquantenario della fondazione, modellava
quel già citato
Bersagliere alla carica,
che si con
serva nella nostra Armeria Reale e che, modellato
in adeguate proporzioni e fuso in bronzo, sorge, a
ricordo del primo fatto glorioso del Corpo sul Ponte
di Goito.
Di quale spirito frema, viva tutta l'opera di Giorgio
Ceragioii, di cittadino, soldato, artista, è espresso
nel serenissimo motto che, sulla vetrata della norta
d'ingresso, accoglie nel suo studio:
Post nubim
•>««.
Così vi è subito promessa, con pensiero, militare
scamente fiero e cordiale, una confortevole sosta in
quello studio, conoscendo
voi ormai come la lotta,
gli ostacoli, le battaglie
non vi destino allarmi,
preoccupazioni o origini
no demoralizzazioni, ma
invece sempre una nuova
fede, una più appassio
nata febbre, accompagni,
animi l'opera tutta del*
l'artefice, n e l q u a le è
inalterabile 1a certezza
che, sempre, dopo la bu*
fera, risplenderà il sole.
Quindi mai possibilità di
scoramenti, arresti a l l a
ispirazione, a l l a v e n a
creativa, die potrà espli
carsi così in tutta la mul
tiforme varietà di tecni
che e di soggetti, rivelan
doci nel Ceragioii il senso
di responsabilità e la pe
rizia, sia die si manifesti
come pittore, scultore o
decoratore,
come
già lo
definiva, or sono molti
anni, Enrico Thovez e
come a noi piace tuttora
sottolineare,


















