
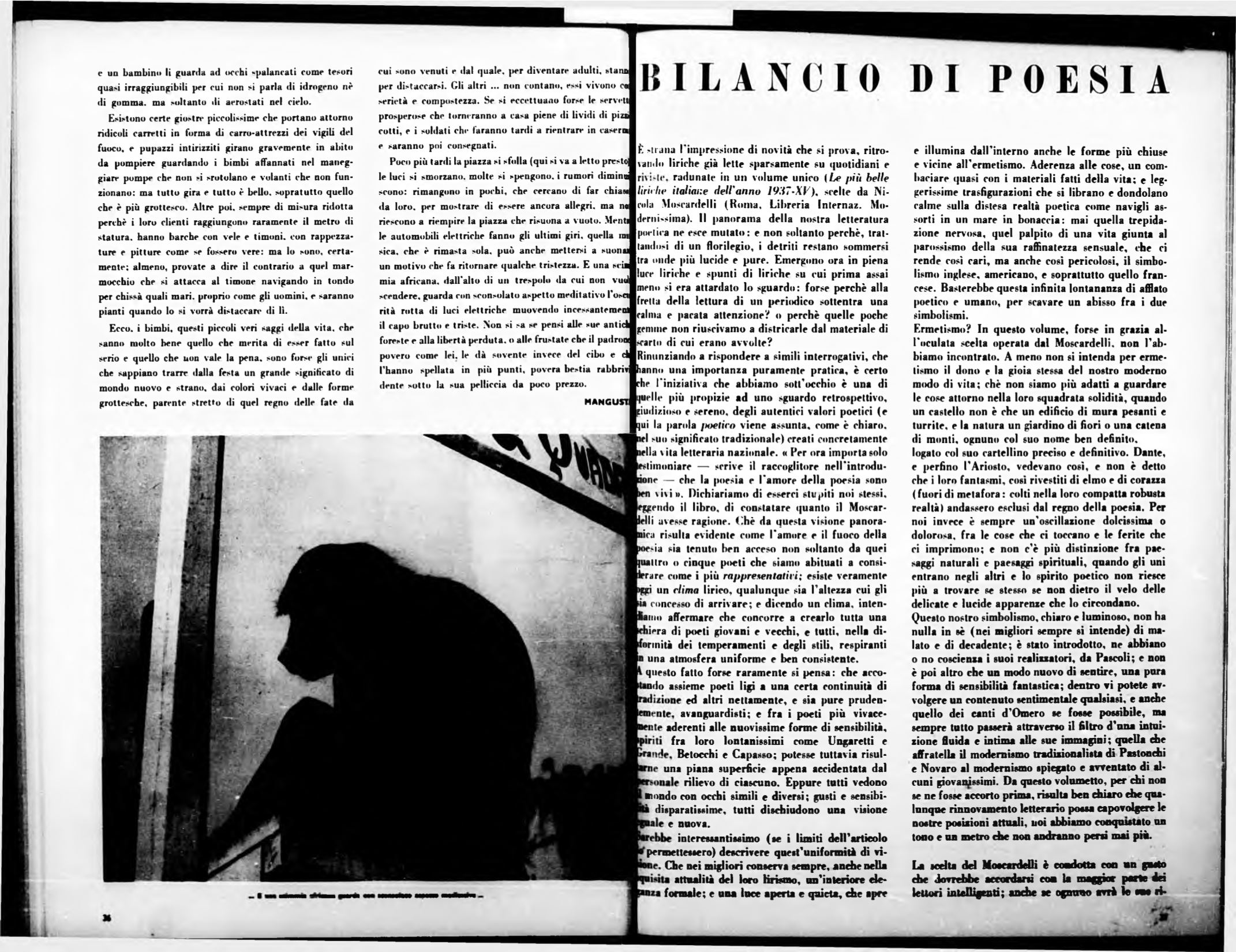
e uii bambino li guarda ad occhi «palancati come tesori
quasi irraggiungibili per cui non si parla di idrogeno nè
di gomma, ma soltanto di aerostati nel cielo.
Esistono certe giostre piccolissime che portano attorno
ridicoli carretti in forma di carro-attrezzi dei vigili del
fuoco, e pupazzi intirizziti girano gravemente in abito
da pompiere guardando i bimbi affannati nel maneg-
giare pompe che non si srotolano e volanti che non fun
zionano: ma tutto gira e tutto è bello, sopratutto quello
che è più grottesco. Altre poi, sempre di misura ridotta
perchè i loro clienti raggiungono raramente il metro di
statura, hanno barche con vele e timoni, con rappezza
ture e pitture come se fossero vere: ma lo sono, certa
mente; almeno, provate a dire il contrario a quel mar
mocchio che si attacca al timone navigando in tondo
per chissà quali mari, proprio come gli uomini, e saranno
pianti quando lo si vorrà distaccare di lì.
Ecco, i bimbi, questi piccoli veri saggi della vita, che
sanno molto bene quello che merita di esser fatto sul
serio e quello che uon vale la pena, sono forse gli unici
che sappiano trarre dalla festa un grande significato di
mondo nuovo e strano, dai colori vivaci e dalle forme
grottesche, parente stretto di quel regno delle fate da
r '
Lv:
,
J-
cui sono venuti e dal quale, per diventare adulti, stana
per distaccarsi. Gli altri ... non contano, essi vivono ca
serietà e compostezza. Se si eccettuano forse le servett
prosperose che torneranno a casa piene di lividi di pizzi
cotti, e i soldati che faranno tardi a rientrare in casernt
e saranno poi consegnati.
Poco più tardi la piazza si sfolla (qui si va a letto presto|
le luci si smorzane», molte si spengono, i rumori diminui
scono: rimangono in pochi, che cercano di far chiasi
da loro, per mostrare di essere ancora allegri, ma no
riescono a riempire la piazza che risuona a vuoto. Menti
le automobili elettriche fanno gli ultimi giri, quella ini
sica, che è rimasta sola, può anche mettersi a suonai
un m otivo che fa ritornare qualche tristezza. E una scia
mia africana, dall'alto di un trespolo «la cui non vuol
scendere, guarda con >consolato aspetto meditativo l'osci
rità rotta di luci elettriche muovendo incessanteraenl
il capo brutto e triste. Non si sa se pensi alle sue anticà
foreste e alla libertà perduta, o alle frustate che il padroni
povero come lei. le dà sovente invece del cibo e
eh
dente sotto la sua pelliccia da poco prezzo.
MANGUST
fi traila 1 impressione di novità che si prova, ritro
vando liriche già lette sparsamente su quotidiani e
radunate in un volume unico
(Le più belle
liriche italiane dell'anno 19H7-XV),
scelte da Ni
cola Moscardelli (Roma, Libreria Interna/.. Mo
dernissima). Il panorama della nostra letteratura
poetica ne esce mutato: e non soltanto perchè, trat
tandoci di un florilegio, i detriti restano sommersi
tra onde più lucide e pure. Emergono ora in piena
Iure liriche e spunti di liriche su cui prima assai
meno si era attardato lo sguardo: forse perchè alla
fretta della lettura di un periodico sottentra una
calma e pacata attenzione? o perchè quelle poche
gemme non riuscivamo a districarle dal materiale di
scarto di cui erano avvolte?
Rinunziando a rispondere a simili interrogativi, che
l'hanno spellata in più punti, povera bestia rabbriv hanno
una importanza puramente pratica, è certo
che l'iniziativa che abbiamo sottocchio è una di
uelle più propizie ad uno sguardo retrospettivo,
giudizioso e sereno, degli autentici valori poetici (e
qui la parola
poetico
viene assunta, come è chiaro,
el suo significato tradizionale) creati concretamente
ella vita letteraria nazionale. « Per ora importa solo
estimoniare — scrive il raccoglitore nell'introdu-
ione — che la poesia e l'amore della poesia sono
n vivi». Dichiariamo di esserci stupiti noi stessi,
leggendo il libro, di constatare quanto il Moscar
di avesse ragione. (Ihè da questa visione panora
ma risulta evidente come l'amore e il fuoco della
ia sia tenuto ben acceso non soltanto da quei
altro o cinque poeti che siamo abituati a consi-
lerare come i più
rappresentativi
; esiste veramente
i un
clima
lirico, qualunque sia l'altezza cui gli
u concesso di arrivare; e dicendo un clima, inten-
liaino affermare che concorre a crearlo tutta una
iera di poeti giovani e vecchi, e tutti, nella di*
onnità dei temperamenti e degli stili, respiranti
una atmosfera uniforme e ben consistente,
questo fatto forse raramente si pensa : che seco
ndo assieme poeti ligi a una certa continuità di
ed altri nettamente, e sia pure pruden-
avanguardisti; e fra i poeti più vivace*
aderenti alle nuovissime forme di sensibilità,
fra loro lontanissimi come Ungaretti e
Betocchi e Capasso; potesse tuttavia risul-
una piana superficie appena accidentata dal
rilievo di ciascuno. Eppure tutti vedono
mondo con occhi simili e diversi ; gusti e sensibi-
disparatissime, tutti dischiudono una visione
e nuova.
interessantissimo (se i limiti deirartìcolo
permettessero) descrivere quest'uniformità di vi*
Che nei migliori conserva sempre, anche nella
attualità del loro lirismo, un'interiore d e
formale; e una luce aperta e quieta, die apre
e illumina dall'interno anche le forme più chiuse
e vicine airermetismo. Aderenza alle cose, un com
baciare quasi con i materiali fatti della vita; e leg
gerissime trasfigurazioni che si librano e dondolano
caline sulla distesa realtà poetica come navigli as
sorti in un mare in bonaccia: mai quella trepida
zione nervosa, quel palpito di una vita giunta al
parossismo della sua raffinatezza sensuale, che ci
rende così cari, ma anche così pericolosi, il simbo
lismo inglese, americano, e soprattutto quello fran
cese. Basterebbe questa infinita lontananza di afflato
poetico e umano, per scavare un abisso fra i due
simbolismi.
Ermetismo? In questo volume, forse in grazia al
l'oculata scelta operata dal Moscardelli, non l'ab
biamo incontrato. A meno non si intenda per erme
tismo il dono e la gioia stessa del nostro moderno
modo di vita; chè non siamo più adatti a guardare
le cose attorno nella loro squadrata solidità, quando
un castello non è che un edificio di mura pesanti e
turrite, e la natura un giardino di fiori o una catena
di monti, ognuno col suo nome ben definito,
logato col suo cartellino preciso e definitivo. Dante,
e perfino l'Ariosto, vedevano così, e non è detto
che i loro fantasmi, così rivestiti di elmo e di corazza
( fuori di metafora : colti nella loro compatta robusta
realtà) andassero esclusi dal regno della poesia. Per
noi invece è sempre un'oscillazione dolcissima o
dolorosa, fra le cose che ci toccano e le ferite che
ci imprimono; e non c'è più distinzione fra pae
saggi naturali e paesaggi spirituali, quando gli uni
entrano negli altri e lo spirito poetico non riesce
più a trovare se stesso se non dietro il velo delle
delicate e lucide apparenze che lo circondano.
Questo nostro simbolismo, chiaro e luminoso, non ha
nulla in sè (nei migliori sempre si intende) di ma*
lato e di decadente; è stato introdotto, ne abbiano
o no coscienza i suoi realizzatori, da Pascoli; e non
è poi altro che un modo nuovo di sentire, una pura
forma di sensibilità fantastica; dentro vi potete av
volgere un contenuto sentimentale qualsiasi, e anche
quello dei canti d'Omero se fosse possibile, ma
sempre tutto passerà attraverso il filtro d'una intuì*
zione fluida e
intima
alle sue
immagini
; quella
die
affratella
il
modernismo
tradizionalista di Pastonchi
e Novaro al modernismo
spiegato e avventato di
al*
cuni giovanissimi. Da questo volumetto,
per dii non
se
ne
fosse
accorto prima, risulta ben chiaro che qua
lunque rinnovamento letterario possa capovolgere le
nostre
posizioni
attuali, noi
abbiamo conquistato un
tono e un metro che non andranno persi mai più.
La scelta del Moscardelli è condotta con un gusto
die dovrebbe accordarsi eoa la maggior parte dei
lettori intelligenti; anche se ognuno arri le «
m
ri»


















