
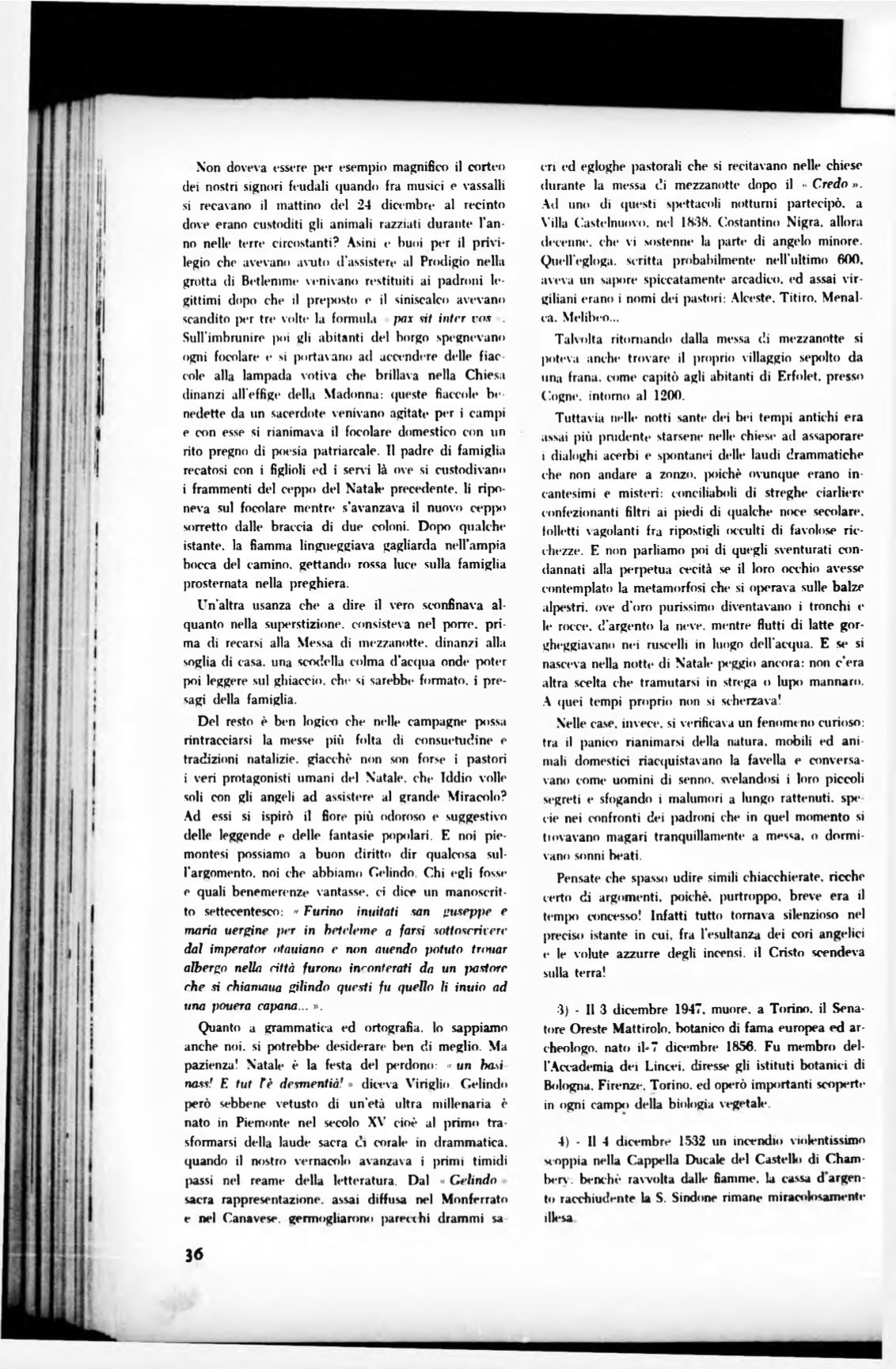
Non doveva essere per esempio magnifico il corteo
dei nostri signori feudali quando fra musici e vassalli
si recavano il mattino del 24 dicembre al recinto
dove erano custoditi gli animali razziati durante l’a n
no nelle terre circostanti? Asini e buoi per il privi
legio che avevano avuto d ’assistere al Prodigio nella
grotta di Betlemme venivano restituiti ai padroni le
gittimi dopo che il preposto e il siniscalco avevano
scandito per tre volti* la formula
pax sit inter
vos
Sull’imbrunire poi gli abitanti del borgo spegnevano
ogni focolare e si portavano ad accendere delle fiac
cole alla lampada votiva che brillava nella Chiesa
dinanzi all’effige della Madonna: queste fiaccole b e
nedette da un sacerdote venivano agitate per i campi
e
con esse si rianimava il focolare domestico con un
rito pregno di poesia patriarcale. Il padre di famiglia
recatosi con i figlioli ed i servi là ove si custodivano
i frammenti del ceppo del Natale precedente, li ripo
neva sul focolare mentre s’avanzava il nuovo
c e p p o
sorretto dalle braccia di due coloni. Dopo qualche
istante, la fiamma lingueggiava gagliarda nell’ampia
bocca del camino, gettando rossa luce sulla famiglia
prosternata nella preghiera.
Un’altra usanza che a dire il vero sconfinava al
quanto nella superstizione, consisteva nel porre, p ri
ma di recarsi alla Messa di mezzanotte, dinanzi alla
soglia di casa, una scodella colma d’acqua onde poter
poi leggere sul ghiaccio, che si sarebbe formato, i pre
sagi della famiglia.
Del resto è ben logico che nelle campagne possa
rintracciarsi la messe più folta di consuetudine e
tradizioni natalizie, giacché non son forse i pastori
i veri protagonisti umani del Natale, che Iddio volle
soli con gli angeli ad assistere al grande Miracolo?
Ad essi si ispirò il fiore più odoroso e suggestivo
delle leggende e delle fantasie popolari. E noi pie
montesi possiamo a buon diritto dir qualcosa sul
l’argomento. noi che abbiamo Celindo. Chi egli fosse
e quali benemerenze vantasse, ci dice un manoscrit
to settecentesco:
« Furino inuitati san puseppe e
maria uergine per
in
heteleme a farsi sottoscrivere
dal imperator ntauiano e non attendo potuto trottar
albergo nella città furono inconterati da un jwstorc
che si chiamaua gilindo questi fu quello li inuio ad
una pouera capano...
».
Quanto a grammatica ed ortografia, lo sappiamo
anche noi. si potrebbe desiderare ben di meglio. Ma
pazienza! Natale è la festa del perdono:
« un ha.\i
nass! E tut rè desmentià!
» diceva Viriglio. Celindo
però sebbene vetusto di un ’età ultra millenaria è
nato in Piemonte nel secolo XV cioè al primo tra
sformarsi della laude sacra c i corale in drammatica,
quando il nostro vernacolo avanzava i primi timidi
l^assi nel reame della letteratura. Dal «
Gelindo
sacra rappresentazione, assai diffusa nel Monferrato
e nel Canavese. germogliarono paret i hi drammi sa
cri ed egloghe pastorali che si recitavano nelle chiese
durante la messa ili mezzanotte dopo il <■
Credo
».
Ad uno di questi spettacoli notturni partecipò, a
Villa Castelnuovo. nel IMS. Costantino Nigra, allora
decenne, che vi sostenne la parte di angelo minore.
Quell’egloga, scritta probabilmente nell’ultimo 600,
aveva un sapore spiccatamente arcadico, ed assai v ir
giliani erano i nomi dei pastori: Alceste. Titiro. Menal-
ca. Melibeo...
Talvolta ritornando dalla messa di mezzanotte si
poteva anche trovare il proprio villaggio sepolto da
una frana, come capitò agli abitanti di Erfolet. presso
Cogne, intorno al 1200.
Tuttavia nelle notti sante dei bei tempi antichi era
assai più prudente starsene nelle chiese ad assaporare
i dialoghi acerbi e spontanei delle laudi drammatiche
che non andare a zonzo. |>oichè ovunque erano in
cantesimi e misteri: conciliaboli di streghe ciarliere
confezionanti filtri ai piedi di qualche noce secolare,
folletti vagolanti fra ripostigli occulti di favolose ric
chezze. E non parliamo poi di quegli sventurati con
dannati alla perpetua cecità se il loro occhio avesse
contemplato la metamorfosi che si operava sulle balze
alpestri, ove d ’oro purissimo diventavano i tronchi e
le rocce, d ’argento la neve, mentre flutti di latte gor
gheggiavano nei ruscelli in luogo dell'acqua. E se si
nasceva nella notte di Natale peggio ancora: non c’era
altra scelta che tramutarsi in strega o lupo mannaro.
A quei tempi proprio non si scherzava!
Nelle case, invece, si verificava un fenomeno curioso:
tra il panico rianimarsi della natura, mobili ed an i
mali domestici riacquistavano la favella e conversa
vano come uomini di senno, svelandosi i loro piccoli
segreti e sfogando i malumori a lungo rattenuti, spe
eie nei confronti dei padroni che in quel momento si
trovavano magari tranquillamente a messa, o dorm i
vano sonni beati.
Pensate che spasso udire simili chiacchierate, ricche
certo di argomenti, poiché, purtroppo, breve era il
tempo concesso! Infatti tutto tornava silenzioso nel
preciso istante in cui, fra l’esultanza dei cori angelici
e le volute azzurre degli incensi, il Cristo scendeva
sulla terra!
3) - Il 3 dicembre 1947. muore, a Torino, il Sena
tore Oreste Mattirolo. botanico di fama europea ed a r
cheologo. nato il-7 dicembre 1856. Fu membro del-
l’Accademia dei Lincei, diresse gli istituti botanici di
Bologna. Firenze, Torino, ed operò importanti scoperte
in ogni campo della biologia vegetale.
4) - Il 4 dicembre 1532 un incendio violentissimo
scoppia nella Cappella Ducale del Castello di Cham-
berv : benché ravvolta dalle fiamme, la cassa d argen
to racchiudente la S. Sindone rimane miracolosamente
illesa
3 6


















