
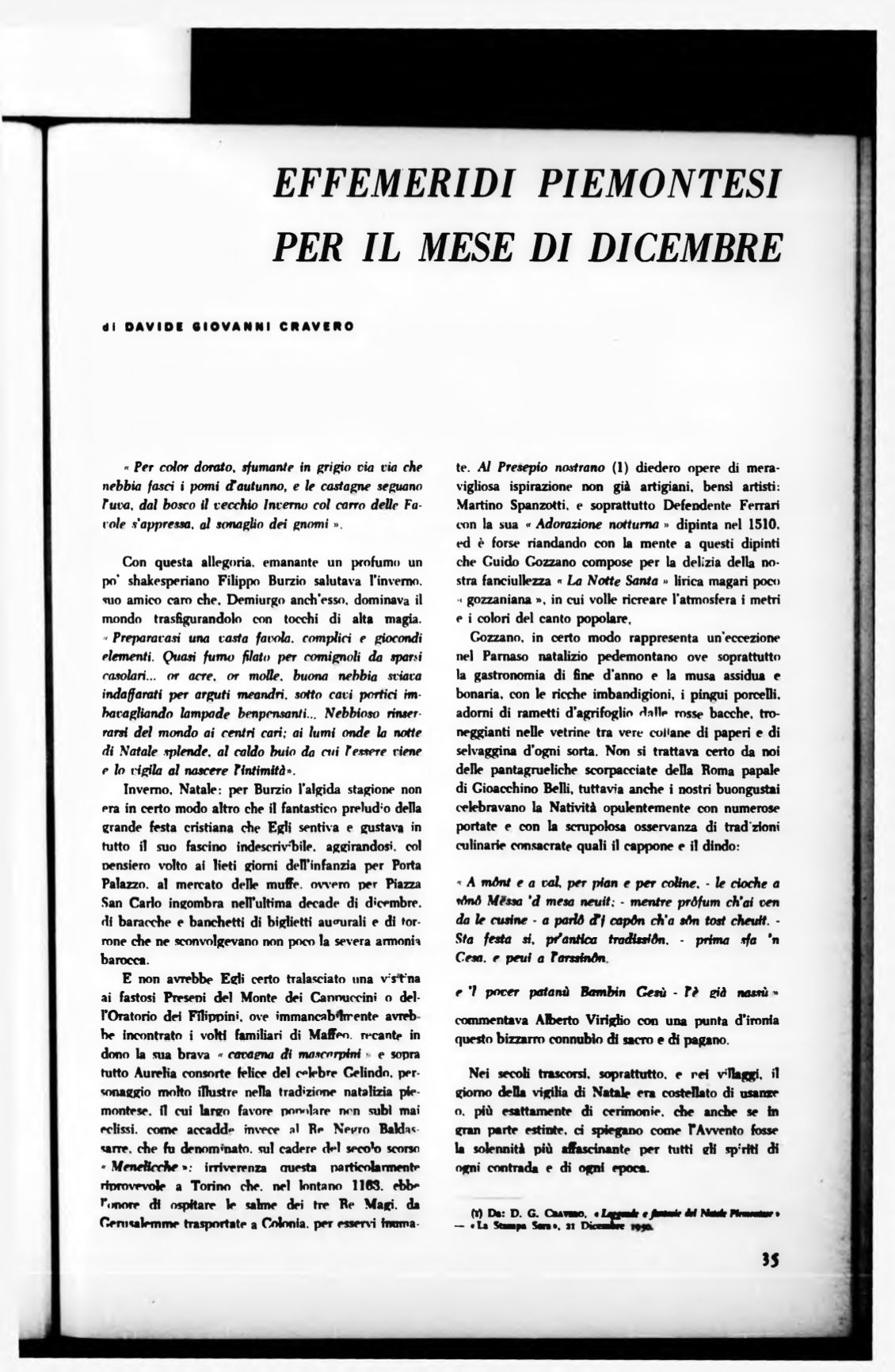
EFFEMERIDI PIEMONTESI
PER IL MESE DI DICEMBRE
di DAVIOC G I OVANN I C R A V E RO
«
Per color dorato, sfumante in
grigio
via eia che
nebbia fasci i pomi d ’autunno, e le castagne seguano
ruva, dal bosco il vecchio Inverno col carro delle Fa
vole s’appressa, al sonaglio dei gnomi
».
Con questa allegoria, emanante un profumo un
po* shakesperiano Filippo Burzio salutava l’inverno,
suo amico caro che. Demiurgo anch’esso. dominava il
mondo tra sc u ra n d o lo con tocchi di alta magia.
"
Preparavasi una vasta favola, complici e giocondi
elementi. Qttasi fumo filato per comignoli da spani
casolari... or acre, or molle, buona nebbia sviava
indaffarati per arguti meandri, sotto cavi portici im
bavagliando lampade benpensanti... Nebbioso rinser
rarsi del mondo ai centri cari; ai lumi onde la notte
di Natale splende, al caldo buio da cui Tessere viene
e lo vigila al nascere Tintimità».
Inverno. Natale: per Burzio l’algida stagione non
fra in certo modo altro che il fantastico p re lu d a della
grande festa cristiana che Egli sentiva e gustava in
tutto il suo fascino indescrivibile, aggirandosi, col
pensiero volto ai lieti giorni dell’infanzia per Porta
Palazzo, al mercato delle muffe, ovvero per Piazza
San Carlo ingombra nell’ultima decade di dicembre,
di baracche e banchetti di biglietti augurali e di tor
rone che ne sconvolgevano non poco la severa armonia
barocca.
E non avrebbe Egli certo tralasciato una v 'r f n a
ai fastosi Presepi del Monte dei Cannuccini o del-
l’Oratorio dei Filippini, ove immancab»hrente avrrb
he incontrato i volti familiari di Maffeo, recante in
dono la sua brava «
cavagna di masenrpini
- e sopra
tutto Aurelia consorte felice del celebre Celindo. per
sonaggio molto illustre nella tradizione natalizia pie
montese. il cui largo favore ponnfore nen subi mai
eclissi, come accadde invece al Re Net»ro Baldas
sarre. che fu denominato, sul cadere del seco’o scorso
«
MeneHcche
»: irriverenza ouesta particolarmente
riprovevole a Torino che. nel lontano 1183. Ab**
J\more di ospitare le salme dei tre Re Magi, da
Gerusalemme trasportate a Colonia, per esservi inuma
te.
Al Presepio nostrano
(1) diedero opere di mera
vigliosa ispirazione non già artigiani, bensi artisti:
Martino Spanzotti, e soprattutto Defendente Ferrari
con la sua «
Adorazione notturna
» dipinta nel 1510.
ed è forse riandando con la mente a questi dipinti
che Guido Cozzano compose per la delizia della no
stra fanciullezza
« La Notte Santa
» lirica magari poco
« gozzaniana », in cui volle ricreare l’atmosfera i metri
e i colori del canto popolare.
Cozzano, in certo modo rappresenta un’eccezione
nel Parnaso natalizio pedemontano ove soprattutto
la gastronomia di fine d ’anno e la musa assidua e
bonaria, con le ricche imbandigioni, i pingui porcelli,
adorni di rametti d ’agrifoglio dalle rosse bacche, tro
neggiane nelle vetrine tra vere coi'ane di paperi e di
selvaggina d ’ogni sorta. Non si trattava certo da noi
delle pantagrueliche scorpacciate della Roma papale
di Gioacchino Belli, tuttavia anche i nostri buongustai
celebravano la Natività opulentemente con numerose
portate e con la scrupolosa osservanza di trad'zioni
culinarie consacrate quali il cappone e il dindo:
«
A móni e a va i per pian e per coline,
-
le cioche a
rAn/i Messa ’d mesa neuit; - mentre prófum ch'ai cen
da le cusine
-
a parlò <Tj capón ch’a sAn tost cheuit. -
Sta festa si, pt*antica tradissifin.
-
prima sfa
’n
Cesa, e peui a TarssinAn
e
7
po ter palami Bambin Gesù
-
Tè già nassù
*
commentava Alberto Viriglio con una punta d’ironia
questo bizzarro connubio di sacro e di pagano.
Nei secoli trascorsi, soprattutto, e r e i villaggi, il
giorno della vigilia di Natale era costellato di usanze
o. più esattamente di cerimonie, che anche se In
gran parte estinte, d spiegano come
T
Avvento fosse
la solennità più affascinante p e r tu tti gli sp:rtti di
ogni contrada e di ogni epoca.
(i)
Db: D.
G.
Cum o .
» I y è
tpmmk U
Ntadr
Vkmmtm
*
— «U S fnp» Sera». » Diccmht
55


















