
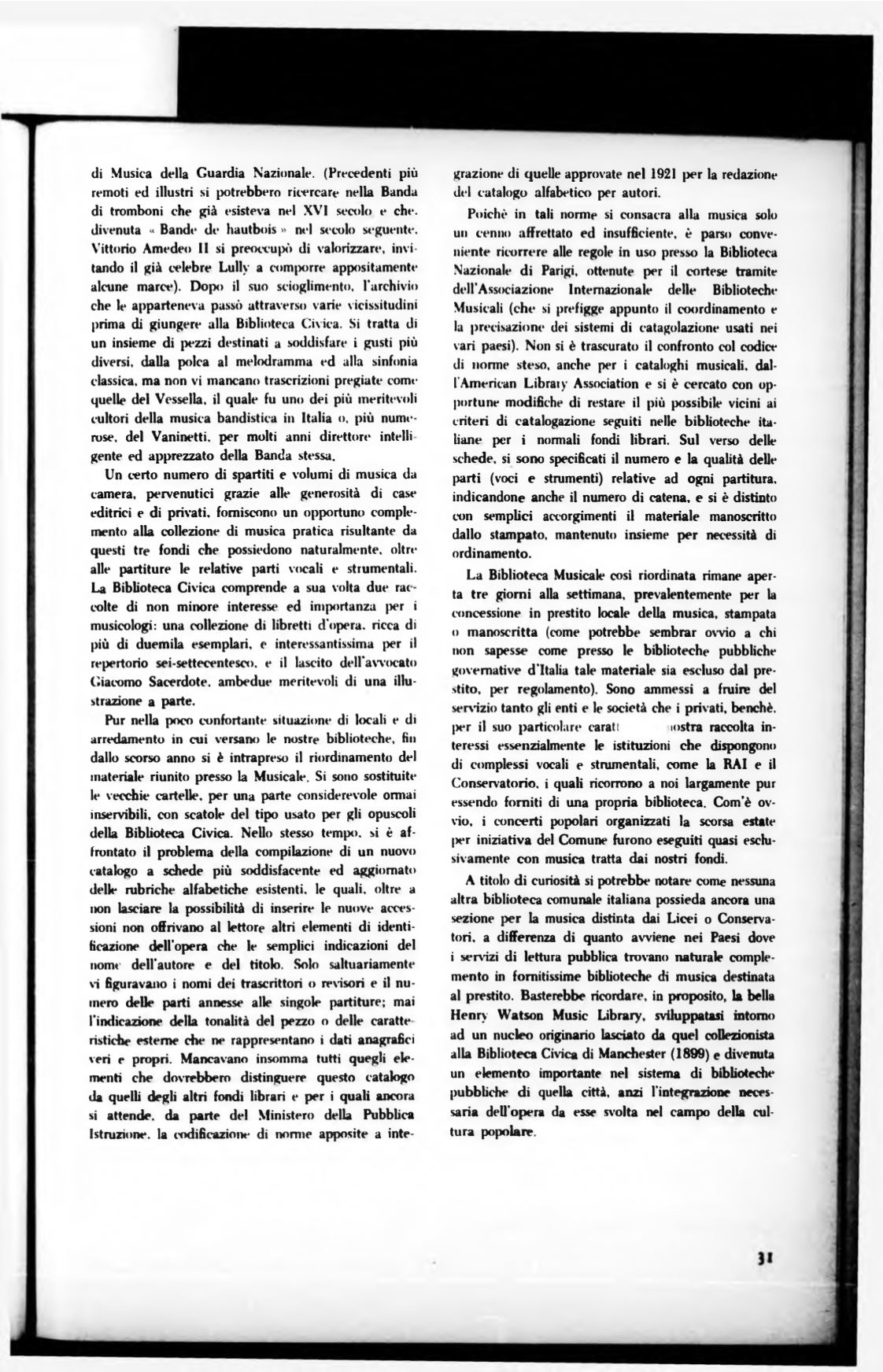
di Musica della Guardia Nazionale. (Precedenti più
remoti ed illustri si potrebbero ricercare nella Banda
di tromboni che già esisteva nel XVI secolo e che.
divenuta « Bande de hautbois » nel secolo seguente.
Vittorio Amedeo II si preoccupò di valorizzare, invi
tando il già celebre Lully a comporre appositamente
alcune marce). Dopo il suo scioglimento, l’archivio
che le apparteneva passò attraverso varie vicissitudini
prima di giungere alla Biblioteca Civica. Si tratta di
un insieme di (lezzi destinati a soddisfare i gusti più
diversi, dalla polca al melodramma ed alla sinfonia
classica, ma non vi mancano trascrizioni pregiate come
quelle del Vessella, il quale fu uno dei più meritevoli
cultori della musica bandistica in Italia o. più nume
rose, del Vaninetti, per molti anni direttore intelli
gente ed apprezzato della Banda stessa.
Un certo numero di spartiti e volumi di musica da
camera, pervenutici grazie alle generosità di case
editrici e di privati, forniscono un opportuno comple
mento alla collezione di musica pratica risultante da
questi tre fondi che possiedono naturalmente, oltre
alle partiture le relative parti vocali e strumentali.
La Biblioteca Civica comprende a sua volta due rac
colte di non minore interesse ed importanza per i
musicologi: una collezione di libretti d ’opera, ricca di
più di duemila esemplari, e interessantissima per il
repertorio sei-settecentesco, e il lascito dell’avvocato
Giacomo Sacerdote, ambedue meritevoli di una illu
strazione a parte.
Pur nella poco confortante situazione di locali e di
arredamento in cui versano le nostre biblioteche, fin
dallo scorso anno si è intrapreso il riordinamento del
materiale riunito presso la Musicale. Si sono sostituite
le vecchie cartelle, per una parte considerevole ormai
inservibili, con scatole del tipo usato per gli opuscoli
della Biblioteca Civica. Nello stesso tempo, si è af
frontato il problema della compilazione di un nuovo
catalogo a schede più soddisfacente ed aggiornato
delle rubriche alfabetiche esistenti, le quali, oltre a
non lasciare la possibilità di inserire le nuove acces
sioni non offrivano al lettore altri elementi di identi
ficazione dell'opera che le semplici indicazioni del
nome dell’autore e del titolo. Solo saltuariamente
vi figuravano i nomi dei trascrittori o revisori e il nu
mero delle parti annesse alle singole partiture; mai
l’indicazione della tonalità del pezzo o delle caratte
ristiche esterne che ne rappresentano i dati anagrafici
veri e propri. Mancavano insomma tutti quegli ele
menti che dovrebbero distinguere questo catalogo
da quelli degli altri fondi librari e per i quali ancora
si attende, da parte del Ministero della Pubblica
Istruzione, la codificazione di norme apposite a inte
grazione di quelle approvate nel 1921 per la redazione
del catalogo alfabetico per autori.
Poiché in tali norme si consacra alla musica solo
un cenno affrettato ed insufficiente, è parso conve
niente ricorrere alle regole in uso presso la Biblioteca
Nazionale d i Parigi, ottenute per il cortese tramite
deH’Associazione Intemazionale delle Biblioteche
Musicali (che si prefigge appunto il coordinamento e
la precisazione dei sistemi di catagolazione usati nei
vari paesi). Non si è trascurato il confronto col codice
di nonne steso, anche per i cataloghi musicali, dal-
l’American Librai
y
Association e si è cercato con op-
portune modifiche di restare il più possibile vicini ai
criteri di catalogazione seguiti nelle biblioteche ita
liane per i normali fondi librari. Sul verso delle
schede, si sono specificati il numero e la qualità delle
parti (voci e strumenti) relative ad ogni partitura,
indicandone anche il numero di catena, e si è distinto
con semplici accorgimenti il materiale manoscritto
dallo stampato, mantenuto insieme p e r necessità di
ordinamento.
La Biblioteca Musicale cosi riordinata rimane aper
ta tre giorni alla settimana, prevalentemente per la
concessione in prestito locale della musica, stampata
0 manoscritta (come potrebbe sembrar ovvio a chi
non sapesse come presso le biblioteche pubbliche
governative d ’Italia tale materiale sia escluso dal pre
stito, per regolamento). Sono ammessi a fruire del
servizio tan to gli enti e le società che i privati, benché,
per il suo particolare carati
lostra raccolta in
teressi essenzialmente le istituzioni che dispongono
di complessi vocali e strumentali, come la RAI e il
Conservatorio, i quali ricorrono a noi largamente pur
essendo forniti di una propria biblioteca. Com’è ov
vio, i concerti popolari organizzati la scorsa estate
|>er iniziativa del Comune furono eseguiti quasi esclu
sivamente con musica tratta dai nostri fondi.
A titolo d i curiosità si potrebbe notare come nessuna
altra biblioteca comunale italiana possieda ancora una
sezione p e r la musica distinta dai Licei o Conserva-
tori. a differenza di quanto avviene nei Paesi dove
1 servizi di lettura pubblica trovano naturale comple
mento in fornitissime biblioteche di musica destinata
al prestito. Basterebbe ricordare, in proposito, la bella
Henry Watson Music Library, sviluppatasi intorno
ad un nucleo originario lasciato da quel collezionista
alla Biblioteca Civica di Manchester (1899) e divenuta
un elemento importante nel sistema di biblioteche
pubbliche d i quella città, anzi l’integrazione neces
saria dell’opera da esse svolta nel campo della cul
tu ra popolare.


















