
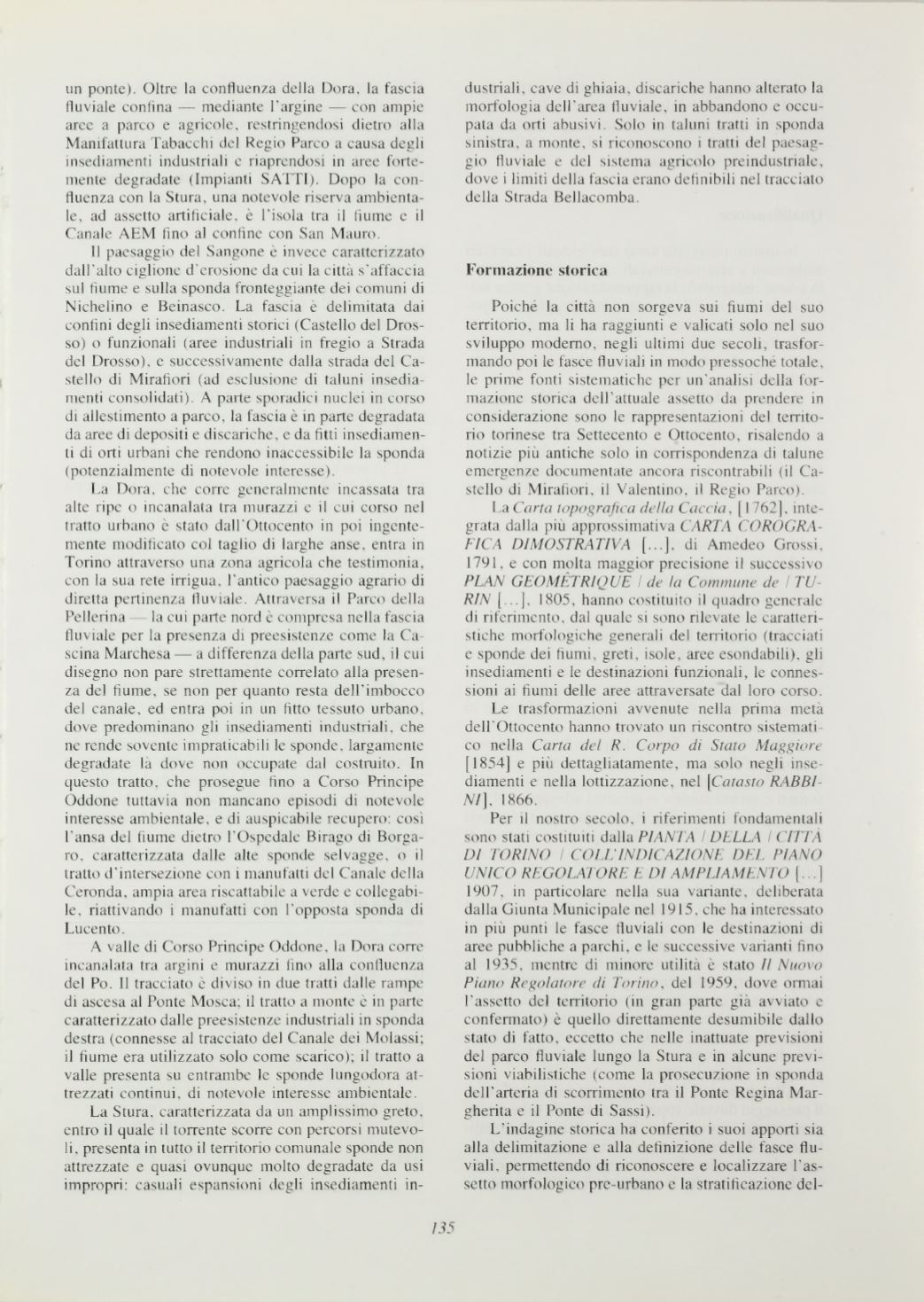
un ponte). Oltre la confluenza della Dora, la fascia
fluviale confina — mediante l'argine con ampie
aree a parco e agricole, restringendosi dietro alla
Manifattura Tabacchi del Regio Parco a causa degli
insediamenti industriali e riaprendosi in aree forte-
mente degradate (Impianti SATTI). Dopo la con-
fluenza con la Stura, una notevole riserva ambienta-
le, ad assetto artificiale, è l'isola tra il fiume e il
Canale AEM fino al confine con San Mauro.
Il paesaggio del Sangone è invece caratterizzato
dall'alto ciglione d'erosione da cui la città s'affaccia
sul fiume e sulla sponda fronteggiante dei comuni di
Nichelino e Beinasco. La fascia è delimitata dai
confini degli insediamenti storici (Castello del Dros-
so) o funzionali (aree industriali in fregio a Strada
del Drosso), e successivamente dalla strada del Ca-
stello di Mirafiori (ad esclusione di taluni insedia-
menti consolidati). A parte sporadici nuclei in corso
di allestimento a parco, la fascia
è
in parte degradata
da aree di depositi e discariche, e da fitti insediamen-
ti di orti urbani che rendono inaccessibile la sponda
(potenzialmente di notevole interesse).
La Dora, che corre generalmente incassata tra
alte ripe o incanalata tra murazzi e il cui corso nel
tratto urbano è stato dall'Ottocento in poi ingente-
mente modificato col taglio di larghe anse, entra in
Torino attraverso una zona agricola che testimonia,
con la sua rete irrigua, l'antico paesaggio agrario di
diretta pertinenza fluviale. Attraversa il Parco della
Pellerina la cui parte nord è compresa nella fascia
fluviale per la presenza di preesistenze come la Ca-
scina Marchesa a differenza della parte sud, il cui
disegno non pare strettamente correlato alla presen-
za del fiume, se non per quanto resta dell'imbocco
del canale, ed entra poi in un fitto tessuto urbano,
dove predominano gli insediamenti industriali, che
ne rende sovente impraticabili le sponde, largamente
degradate là dove non occupate dal costruito. In
questo tratto, che prosegue fino a Corso Principe
Oddone tuttavia non mancano episodi di notevole
interesse ambientale, e di auspicabile recupero: così
l'ansa del fiume dietro l'Ospedale Birago di Borga-
ro, caratterizzata dalle alte sponde selvagge, o il
tratto d'intersezione con i manufatti del Canale della
Ceronda, ampia area riscattabile a verde e collegabi-
le, riattivando i manufatti con l'opposta sponda di
Lucento.
A valle di Corso Principe Oddone, la Dora corre
incanalata tra argini e murazzi fino alla confluenza
del Po. Il tracciato è diviso in due tratti dalle rampe
di ascesa al Ponte Mosca; il tratto a monte è in parte
caratterizzato dalle preesistenze industriali in sponda
destra (connesse al tracciato del Canale dei Molassi;
il fiume era utilizzato solo come scarico); il tratto a
valle presenta su entrambe le sponde lungodora at-
trezzati continui, di notevole interesse ambientale.
La Stura, caratterizzata da un amplissimo greto,
entro il quale il torrente scorre con percorsi mutevo-
li, presenta in tutto il territorio comunale sponde non
attrezzate e quasi ovunque molto degradate da usi
impropri: casuali espansioni degli insediamenti in-
dustriali, cave di ghiaia, discariche hanno alterato la
morfologia dell'area fluviale, in abbandono e occu-
pata da orti abusivi. Solo in taluni tratti in sponda
sinistra, a monte, si riconoscono i tratti del paesag-
gio fluviale e del sistema agricolo preindustriale,
dove i limiti della fascia erano definibili nel tracciato
della Strada Bellacomba.
Formazione storica
Poiché la città non sorgeva sui fiumi del suo
territorio, ma li ha raggiunti e valicati solo nel suo
sviluppo moderno, negli ultimi due secoli, trasfor-
mando poi le fasce fluviali in modo pressoché totale,
le prime fonti sistematiche per un'analisi della for-
mazione storica dell'attuale assetto da prendere in
considerazione sono le rappresentazioni del territo-
rio torinese tra Settecento e Ottocento, risalendo a
notizie più antiche solo in corrispondenza di talune
emergenze documentate ancora riscontrabili (il Ca-
stello di Mirafiori, il Valentino, il Regio Parco).
La
Carta topografica detta Caccia,
[1762], inte-
grata dalla più approssimativa
CARTA COROGRA-
FICA DIMOSTRATIVA [...],
di Amedeo Grossi,
1791, e con molta maggior precisione il successivo
PLAN GEOMETRIQUE I de ta Commune de I TU-
RIN [...], 1805,
hanno costituito il quadro generale
di riferimento, dal quale si sono rilevate le caratteri-
stiche morfologiche generali del territorio (tracciati
e sponde dei fiumi, greti, isole, aree esondabili), gli
insediamenti e le destinazioni funzionali, le connes-
sioni ai fiumi delle aree attraversate dal loro corso.
Le trasformazioni avvenute nella prima metà
dell'Ottocento hanno trovato un riscontro sistemati-
co nella
Carta det R. Corpo di Stato Maggiore
[ 1854] e più dettagliatamente, ma solo negli inse-
diamenti e nella lottizzazione, nel
[Catasto RABBI-
NI],
1866.
Per il nostro secolo, i riferimenti fondamentali
sono stati costituiti dalla
PIANTA l DELLA I CITTÀ
DI TORINO I COLL'INDICAZIONE DEL PIANO
UNICO REGOLATORE E DI AMPLIAMENTO [...]
1907, in particolare nella sua variante, deliberata
dalla Giunta Municipale nel 1915, che ha interessato
in più punti le fasce fluviali con le destinazioni di
aree pubbliche a parchi, e le successive varianti fino
al 1935, mentre di minore utilità è stato It
Nuovo
Piano Regolatore di Torino,
del 1959, dove ormai
l'assetto del territorio (in gran parte già avviato e
confermato) è quello direttamente desumibile dallo
stato di fatto, eccetto che nelle inattuate previsioni
del parco fluviale lungo la Stura e in alcune previ-
sioni viabilistiche (come la prosecuzione in sponda
dell'arteria di scorrimento tra il Ponte Regina Mar-
gherita e il Ponte di Sassi).
L'indagine storica ha conferito i suoi apporti sia
alla delimitazione e alla definizione delle fasce flu-
viali, permettendo di riconoscere e localizzare l'as-
setto morfologico pre-urbano e la stratificazione del-
135


















