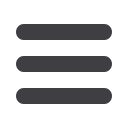
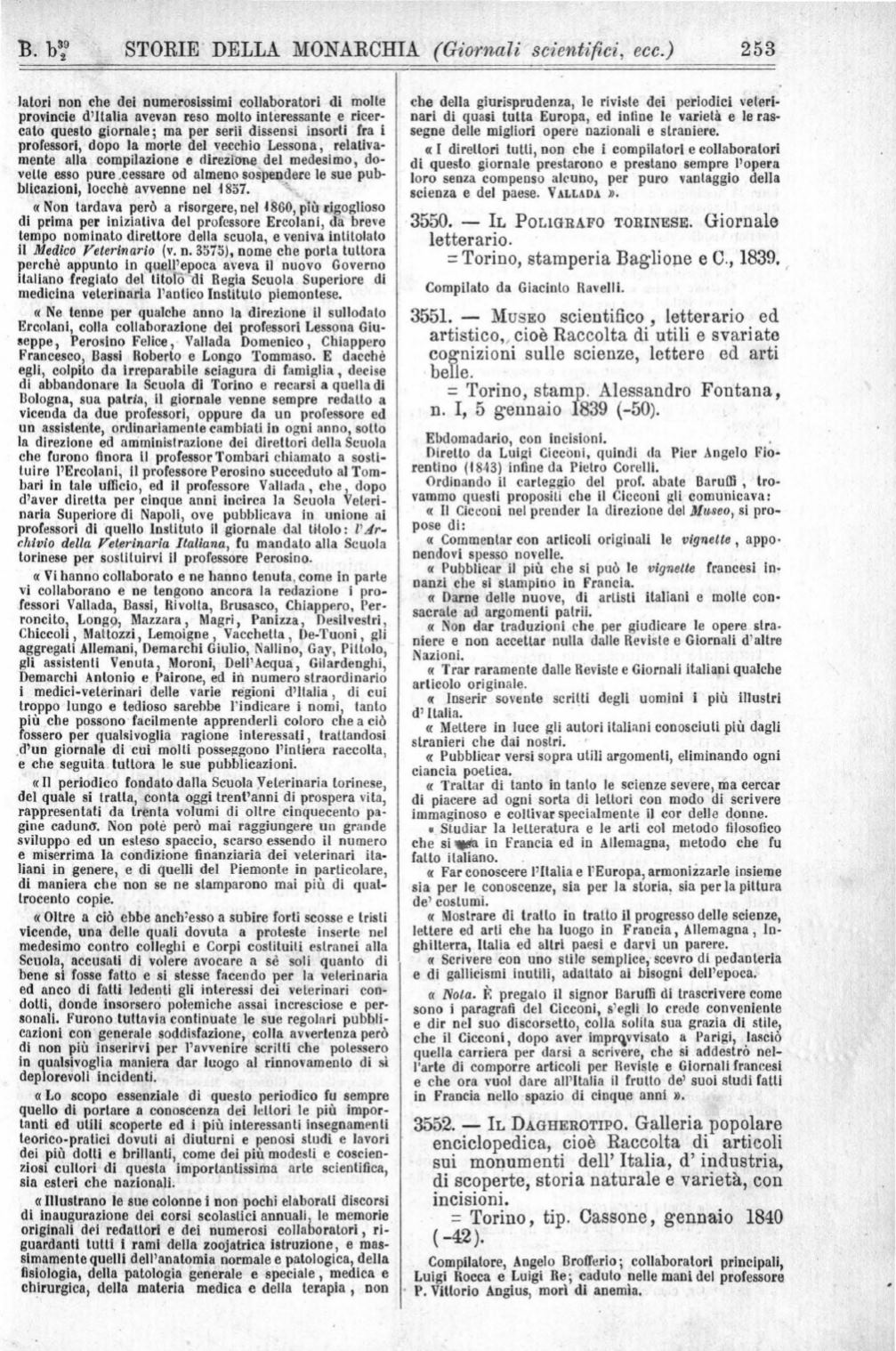
STORIE ' DELLA MONARCHIA
(Giornali scientifici, ecc.)
253
latori non che dei numerosissimi collaboratori di molle
provincie d'Italia avevan reso molto interessante e ricer–
cato questo giornale; ma per serii dissensi insorti fra i
professori, dopo la morte del vecchio Lessona, relativa–
mente alla compilazione e cHrezione del medesimo, do–
velle esso pure .cessare od almeno sospendere le sue pub-
blicazioni, lacchè avvenne nel 1857.
•
cc Non tardava però a risorgere, nel
j
860, più Jjgoglioso
di prima per iniziativa del professore Ercolani, dà breve
tempo nominato direttore della scuola, e veniva intitolato
il
Medico Veterinario
(v. n. 3575), nome che porta tuttora
perchè appunto In quell'epoca aveva
il
nuovo Governo
italiano fregiato del titolo di Regia Scuola Superiore di
medicina veterinaria l'antico Insliluto piemontese,
cc Ne tenne per qualcbe anno la direzione
il
sullodato
Ercolani, colla collaborazione dei professori Lessona Giu–
seppe, Peroslno Felice, Vallada Domenico, Chiappero
Francesco, Bassi Roberto e Longa Tommaso. E dacchè
egli, colpito da irreparabile sciagura di famiglia, decise
di abbandonare la Scuola di Torino e recarsi a quella di
Bologna, sua patria, Il giornale venne sempre redatto a
vicenda da due professori, oppure da un professore ed
un assistente, ordinariamente cambiati in ogni anno, sotto
la direzione ed amministrazione dei direttori della Scuola
che furono finora Il professor Tombari chiamato a sosti–
tuire l'Ercolani, Il pl'ofessore Perosino succeduto al Tom–
bari in tale ufficio, ed
il
professore Vallada, che, dopo
d'aver diretta per cinque anni incirca la Scuola Veteri –
naria Superiore di Napoli, ave pubblicava in unione ai
professori di quello Inslituto il giornale dal titolo :
l'Ar–
chivio della Vel,erinaria Italiana,
fu mandato alla Scuola
torinese per sostituirvi
il
professore Perosino,
cc Vi hanno collaborato e ne banno lenuta, come in parte
vi collaborano e ne tengono ancora la redazione i pro–
fessori Vallada, Bassi, Rivolta, Ilrusasco, Chiappero, Per–
roncito, Long9, lIIazzara, Magri, Panizza, Desilvestri,
Chiccoli, Mattozzi, Lemoigne, Vacchetla, De-Tuoni, gli
aggregati Allemani, Demarchi Giulio, Naltino, Gay, Piltoto,
gli assistenti Venuta, Moroni, Dell' Acqua, Gilardenghi,
Demarchi Antonio e Pairone, ed ili numero straordinario
I medici-veterinari delle varie regioni d'Italia, di cui
troppo lungo e tedioso sarehbe l'indicare i nomi, tanto
più che possono ' facilmente apprenderli coloro che a ciò
fossero per qualRivoglia ragione interessati, trattandosi
.d'un giornale 'di cui molti posseggono l'intiera raccolta,
e che seguita, tuttora le sue pubblicazioni.
cc Il periodiCO fondato dalla Scuola Yeterinaria torinese,
del quale si tratta, conta oggi trent'anni di prospera vita,
rappresentati da trenta volumi di oltre cinquecento pa·
gine cadun<J, Non potè però mai raggiungere un grande
sviluppo ed un esteso spaccio, scarso essendo
il
numero
e miserrima la condizione finanziaria dei veterinari ila–
liani in genere, e di quelli del Piemonte in particolare,
di maniera che non se ne stamparono mai più di quat–
trocento copie.
cc Oltre a ciò ebbe anch'esso a subire forti scosse e tristi
vicende, una delle quali dovuta a proteste inserte nel
medesimo contro
coll~ghi
e Corpi costituili estranei alla
Scuola, accusati di volere avocare a sè soli quanto di
bene si fosse fatto e si stesse facendo per la velerinaria
ed anca di fatti ledenti gli interessi dei veterinari con–
doUi, donde insorsero polemiche assai incresciose e per–
sonali. Furono-tultavia continuate le sue regolari
pubb.li–
cazioni con generale soddisfazione, colla avvertenza però
di non più inserirv l per l'avvenire scritti che potessero
in qualsivoglia maniera dar luogo al rinnovamento di
si
deplorevoli incidenti.
cc Lo 8COpO essenziale di questo periodico fu sempre
quello di portare a conoscenza dei lettori le più impor–
tanti ed utili scoperte ed i più interessanti insegnamenti
teorico-pratici dovuti ai diuturni e peDosi studi e lavori
dei più dotti e brillanti, come dei più modesti e coscien–
ziosi cultori di questa importantissima arte scientifica,
sia esteri che nazionali.
cc Illustrano le sue colonne i non pochi elaborati discorsi
di inaugurazione dei corsi scolastici annuali, le memorie
originali
d~i
redattori e dei numerosi collaboratori, ri–
guardanti tutti I rami della zoojatrica istruzione, e mas–
simamente quelli dell'anatomia normale e patologica, della
fisiologia, della patologia generale e speciale, medica e
chirurgica, della maleria medica e della terapia, non
che della giurisprudenza, le rivisle dei periodici vetAri–
nari di quasi tutta Europa, ed inline le varietà e le raso
segne delte migliori opere nazionali e straniere.
C(
I dil'eltori tutti, non che i compilalorl e collaboratori
di questo giornalo prestarono e prestano sempre l'opera
loro senza compenso alruDo, per puro vantaggio della
scienza e del paese. VALLADA
Il.
,3550. -
IL
POLIGRAFO TORINESE,
Giornale
letterario.
:=
Torino, stamperia Bagliope e
C" 1839. ,
Compilato da Giacinto Ravell i.
3551. -
MUSEO
scientifico, letterario ed
artistico" cioè Raccolta di utili e svariate
cognizioni sulle scienze, lettere ed arti
belle.
:=
Torino, stamp , Alessandro Fontana,
n. I,
5
gennaio
1839 (-50).
Ebdomadario, con incisioni.
Diretto da Luigi Cicconi, quindi da Pier Angelo Fio–
rentino
(1843)
infine da Pietro COl'elli.
Ordinando it carteggio det prof, abate Baruffi, tro–
vammo questi propositi che
il
CiCCOlli gli comunicava:
cc Il Ciccoui oel prender la direzione del
Museo,
si pro–
pose di:
cc Commentar con arlicoli originali le
vignette,
appo·
nendovi spesso novelle.
(C
Puqblicar
il
più che si può le
vignette
francesi in–
nanzi che si stampino in Francia,
cc Darne delle nuove, di arlisli italiani e molte con·
sacrate ad argomenti patrii.
cc Non dar traduzioni ehe per giudicare le opere stra–
niere e non accettar nulla dalle Reviste e Giornali d'altre
Nazioni.
cc Trar raramente dalle Reviste e Giornali italiani qualcbe
articolo originale,
«
Inserir sovente scritti degli uomini
i
più illustri
d' Italia.
cc Mettere in luce gli autori italiani conosciuti più dagli
stranieri che dai nostri.
cc Pubblicar versi sopra ulili argomenti, eliminando ogni
ciancia poetica.
cc Tl'altar di tanto in tanto le scienze severe, ma cercar
di piacere ad ogui sorta di lellori con modo di scrivere
immaginoso e coltivar specialmente il cor delle donne.
• SLuùiar la lettel'atura e le arti col metodo filosofico
che' si,.m in Francia ed in Atlemagna, metodo che fu
falto italiano.
,
cc Far conoscere l'lIalia e l'Europa, armonizzarle insieme
sia per le conoscenze, sia per la storia: sia per la pittura
de' costumi.
cc Mostrare di trallo in tratto
il
progresso delle scienze,
leltere ed arti che ha luogo in Francia, Allemagna, In–
ghilterra, Italia ed altri paesi e darvi un parere.
cc Scrivere con uno stile semplice,' scevro di pedanteria
e di gallidsmi inutili, adaUato ai bisogni dell'epoca.
cc
Nola.
F.
pregato
il
signor Baruffi di trascrivere come
sono i paragrafi del CiCCODi, s'egli lo crede conveniente
e dir nel suo discorselto, colla solita sua grazia di. stile,
cbe
il
Cicconi, dopo aver imprC4vvisato a Parigi, .'asciò
quella caniera per darsi a sc,'ive,:e, che si addestro nel–
l'arte di comporre articoli per
Revi~te
e Giornali francesi
e cbe ora vuoI dare all'Italia il frulto de' suoi studi faUi
in Francia nello spazio di cinque anni
II.
3552. - IL
DAGHEROTIPO.
Galleria popolare
enciclopedica, cioè Raccolta di articoli
sui monumenti dell' Italia, d'industria,
di scoperte, storia naturale e varietà, con
incisioni.
,
:=
Torino, tip. Cassone, genn'aio
1840
( -42).
Compilatore, Angelo Brofferio; collaboratori principali,
Luigi Rocca e Luigi Re; caduto nelle mani del professore
P. Vittorio Angius, mori di anemÌa.


















