
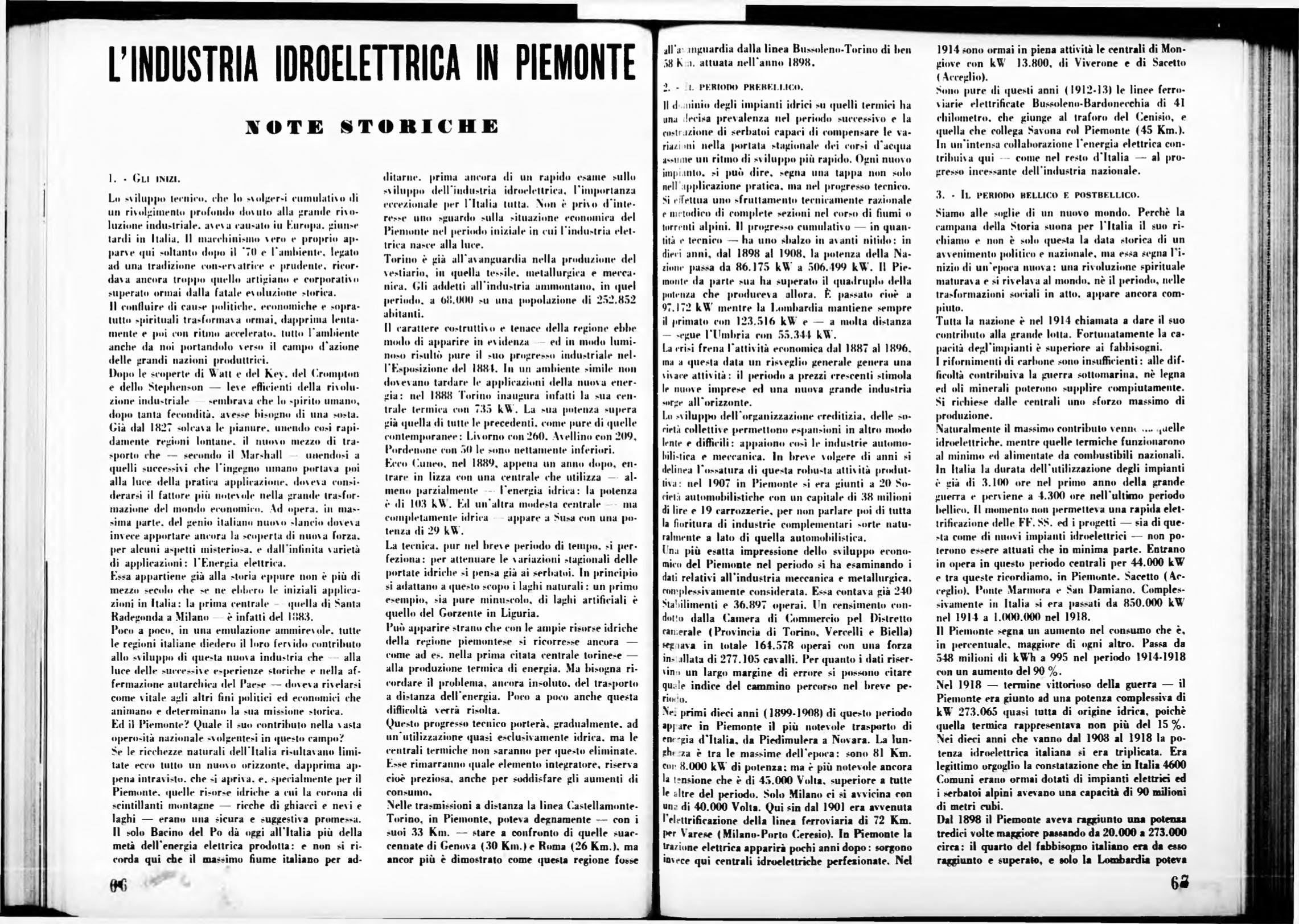
L’INDUSTRIAIDROELETTRICA INPIEMONTE
M O T E S T O R I C H E
1. - G
l i
in iz i
.
Lo sviluppo tecnico, ohe lo svolgersi cumulativo ili
un rivolgimento profondo dovuto alla grande rivo
luzione industriale, aveva causato iu Kuropa. giunse
tardi iu Italia. Il macchinismo vero e proprio ap
parve qui soltanto dopo il *70 e l'ambiente, legato
ad una tradizione conservatrice e prudente, ricor
dava ancora troppo quello artigiano e corporativo
superato ormai dalla fatale evoluzione storica.
Il confluire «li cause p«diticlie. economiche e sopra
tutto spirituali trasformava ormai, dapprima lenta
mente e poi con ritmo accelerato, tutto l'ambiente
anche da noi portandtdo verso il campo d'azione
delle grandi nazioni produttrici.
Dopo le scoperte di Vi att e del K e y. del Grompton
e dello Stephenson — leve efficienti «Iella rivolu
zione industriale — sembrava che lo spirito umano,
dopo tanta fecondità, avesse bisogno di una sosta.
Già dal 1827 solcava le pianure, unendo cosi rapi
damente regioni lontane, il nuovo mezzo di tra
sporto che — secondo il Marshall — unendosi a
«juelli successivi che l'ingegno umano portava poi
alla luce della pratica applicazione, <h»veva consi
derarsi il fattore più notevole nella grande trasfor
mazione del mondo economico. Ad opera, iu mas
sima parte, del genio italiano nuovo slancio doveva
invece apportare ancora la scoperta di nuova forza,
per alcuni aspetti misteriosa, e dall infinita varietà
di applicazioni: l'Energia elettrica.
Essa appartiene già alla storia eppure non è più di
mezzo secolo che se ne ebbero le iniziali applica
zioni in Italia: la prima centrale — quella di Santa
Kadegonda a M ilano — è infatti del 1883.
Poco a poco, in una emulazione ammirevole, tutte
le regioni italiane diedero il loro fervido contributo
allo sviluppo di que-ta nuova industria che — alla
luce «Ielle sturessive esperienze storiche e nella af-
fermazi«»ne autarchica «lei Paese — doveva rivelarsi
come vitale agli altri fini politici ed economici che
animami e determinano la sua missione storica.
Ed il Piemonte? Quale il suo contributo nella vasta
operosità nazionale svolgentesi in <|uesto campo?
Se le ricchezze naturali d ell'Italia risultavano lim i
tate ecco tutto un nuovo orizzonte, dapprima ap
pena intravisto, che si apriva, e. specialmente per il
Piemonte, «ptelle risorse idrit'he a cui la corona di
scintillanti montagne — ricche di ghiacci e nevi e
laghi — erano una sicura e suggestiva promessa.
Il solo Bacino del Po dà oggi a ll’Italia più della
metà dell'energia elettrica prodotta: e non si r i
corda qui che il massimo fiume italiano per ad-
«litanie, prima ancora di un rapido esame sullo
sviluppo dell'industria idroelettrica, l'importanza
eccezionale per l'Ita lia tutta. Non è privo d 'in te
resse unii sguardo
sulla
situazione economica del
Pienitmte nel periodo iniziale in cui l'industria elet
trica nasce alla luce.
Torino è già all'avanguardia nella produzione del
vestiario, iu quella tessile, metallurgica e mecca
nica. (rii addetti all'industria ammontano, in «ptel
periodo, a Oiì.OOO su una ptipolazione di 252.852
abitanti.
Il carattere costruttivo e tenace «Iella regione ebbe
mo«lo di apparire iu evidenza — ed in modo lum i
noso risultò pure il suo progresso industriale nel-
l'Esposizione del 1884. Iu un ambiente simile non
dovevano tardare le applicazioni della nuova ener
gia: nel 1888 Torino inaugura infatti la
sua
cen
trale termica con 735 kW . La sua potenza supera
già «{nella di tutte le precedenti, come pure di «pielle
contemporanee: Livorno con 260. Avellino con 209,
Pordenone con .*>0 le sono nettamente inferiori.
Ecco Cuneo, nel 1889, appena un anno dopo, en
trare in lizza con una centrale che utilizza — al
meno parzialmente — l'energia idrica: la potenza
è ili 103 k\X . K«l un'altra modesta centrale — ma
completamente idrica — appare a Susa con una po
tenza di 29 kW .
La tecnica, pur nel breve periodo di tempo, si per
feziona: per attenuare le variazioni stagionali delle
portate idriche si pensa già ai serbatoi. In principio
si a«lattano a questo scopo i laghi naturali: un primo
esempio, sia pure minuscolo, di laghi artificiali è
quello del Gorzenle in Liguria.
Può apparire strano che con le ampie risorse idriche
della regione piemontese si ricorresse ancora —
come ad es. nella prima citata centrale torinese —
alla produzione termica di energia. Ma bisogna r i
cordare il problema, ancora insoluto, del trasporto
a distanza dell'energia. Poco a poco anche questa
difficoltà verrà risolta.
Questo progresso tecnico porterà, gradualmente, ad
un'utilizzazione quasi esclusivamente idrica, ma le
centrali termiche non saranno per questo eliminate.
Esse rimarranno quale elemento integratore, riserva
cioè preziosa, anche per soddisfare gli aumenti di
consumo.
Nelle trasmissioni a distanza la linea Castellamonte-
Torino, in Piemonte, poteva degnamente — con i
suoi 33 Km . — stare a confronto di quelle suac
cennate di Genova (30 Km .) e Roma (26 Km .), ma
ancor più è dimostrato come questa regione fosse
all'avanguardia dalla linea Bussoleno-Torino di ben
.18 k :i. attuata nell'anno 1898.
2.
- I. PERIODO PREBELLICO.
Il (I'.minio degli impianti idrici su «pielli termici ha
una decisa prevalenza nel periodo successivo e la
costrizione di serbatoi capaci di compensare le va-
ria/.i mi nella (toriata stagionale dei corsi d'acqua
aulirne un ritmo di sv iluppo più rapido. Ogni nuovo
impianto, si può dire, segna una tappa non solo
nell applicazione pratica, ma nel progresso tecnico.
Si effettua uno sfruttamento tecnicamente razionale
e metodico di complete sezioni nel corso di fiumi o
torrenti alpini. Il pntgresso cumulativo — in quan
tità e tecnico — ha uno sbalzo in avanti nitido: in
dieci anni, dal 1898 al 1908. la potenza della N a
zione passa da 86.175 k W a 506.199 k W . Il P ie
monte da parte sua ha superato il quadruplo della
potenza che produceva allora. È passato cioè a
97.172 k W mentre la Lombardia mantiene sempre
il primato con 123.516 kW e — a molta distanza
— segue l'Um b ria c«m 55.344 kW .
La «‘risi frena l'attività economica dal 1887 al 1896.
ma a questa data un risveglio generale genera una
vivace attività: il perioibi a prezzi crescenti stimola
le nuove imprese ed una nuova grande industria
>«irge all'orizzonte.
Lo sviluppo deH'orgaiiizzazione creditizia, delle so
cietà collettive permettono espansioni in altro modo
lente e difficili : appaiono così le industrie automi»-
lùli-tica e meccanica. In breve volgere di anni si
delinca l'ossatura di questa robusta attività produt
tiva: nel 1907 in Piemonte si era giunti a 20 So
cietà automobilistiche con un capitale di 38 milioni
di lire e 19 carrozzerie, per non parlare poi di tutta
la fioritura di industrie complementari sorte natu
ralmente a lato di quella automobilistica.
I na più esatta impressione dello sv iluppo econo
mico del Piemonte nel periodo si ha esaminando i
dati relativi all'industria meccanica e metallurgica,
complessivamente considerata. Essa contava già 240
Staliilimenti e 36.897 «qierai. Un censimento con
dotto dalla Camera di Commercio pel Distretto
camerale (Pro vin cia di Torino, Vercelli e Biella)
segnava in totale 164.578 operai con una forza
in.» aliata di 277.105 cavalli. Per quanto i dati riser
vine un largo margine di errore si possono citare
qui»le indice del cammino percorso nel breve pe
rii»;o.
Ne. primi dieci anni (1899-1908) di questo periodo
>|*| are in Piemonte il più notevole trasporto di
enrr-gia d 'Ita lia , da Piedimulera a Novara. La lun-
fdi* za è tra le massime dell'epoca: sono 81 Km .
cor 8.000 kW di potenza: ma è più notevole ancora
la tensione che è di 45.000 Volta, superiore a tutte
le altre del periodo. Solo M ilano ci si avvicina con
un;- di 40.000 Volta. Qui sin dal 1901 era avvenuta
I elettrificazione della linea ferroviaria di 72 Km .
per \ arese ( Milano-Porto Ceresio). In Piemonte la
tra/ione elettrica apparirà pochi anni dopo: sorgono
invece qui centrali idroelettriche perfezionate. Nel
1914 sono ormai in piena attività le centrali di Mon-
giove con kW 13.800, di Viverone e di Sacetto
( Acceglio).
Sono pure di questi anni (1912-13) le linee ferro
viarie elettrificate Bussoleno-Bardonecchia di 41
chilometro, che giunge al traforo del Cenisio, e
quella che collega Savona col Piemonte (45 Km .).
In un'intensa collaborazione l'energia elettrica con
tribuiva qui — come nel resto d 'Ita lia — al pro
gresso incessante dell'industria nazionale.
Siamo alle soglie di un nuovo mondo. Perchè la
campana della Storia suona per l'Ita lia il suo r i
chiamo e non è solo «|uesta la data storica di un
avvenimento politico e nazionale, ma essa segna 1 i-
nizio di un'epoca nuova : una riv oluzione spirituale
maturava e si rivelav a al mondo, nè il periodo, nelle
trasformazioni sociali in atto, appare ancora com
piuto.
Tutta la nazione è nel 1914 chiamata a dare il suo
contributo alla grande lotta. Fortunatamente la ca
pacità degl'impianti è superiore ai fabbisogni.
I rifornimenti di carbone sono insufficienti: alle d if
ficoltà contribuiva ia guerra sottomarina, nè legna
ed oli minerali poterono supplire compiutamente.
Si richiese dalle centrali uno sforzo massimo di
produzione.
Naturalmente il massimo contributo venia .... jje lle
idroelettriche, mentre quelle termiche funzionarono
al minimo ed alimentate da combustibili nazionali.
In Italia la durata dell'utilizzazione degli impianti
è già di 3.100 ore nel primo anno della grande
guerra e perviene a 4.300 ore nell'ultimo periodo
bellico. Il momento non permetteva una rapida elet
trificazione delle F F . SS. ed i progetti — sia di que
sta come di nuovi impianti idroelettrici — non po
terono essere attuati che in minima parte. Entrano
in opera in questo periodo centrali per 44.000 kW
e tra queste ricordiamo, in Piemonte. Sacetto ( Ac
ceglio). Ponte Marmora e San Damiano. Comples
sivamente in Italia si era passati da 850.000 kW
nel 1914 a 1.000.000 nel 1918.
II Piemonte segna un aumento nel consumo che è,
in percentuale, maggiore di ogni altro. Passa da
548 milioni di kW h a 995 nel periodo 1914-1918
con un aumento del 90 % .
Nel 1918 — termine vittorioso della guerra — il
Piemonte era giunto ad una potenza complessiva di
kW 273.065 quasi tutta di origine idrica, poiché
quella termica rappresentava non più del 15 % .
Nei dieci anni che vanno dal 1908 al 1918 la po
tenza idroelettrica italiana si era triplicata. E ra
legittimo orgoglio la constatazione che in Italia 4600
Comuni erano ormai dotati di impianti elettrici ed
i serbatoi alpini avevano una capacità di 90 milioni
di metri cubi.
Dal 1898 il Piemonte aveva raggiunto una potenza
tredici volte maggiore passando da 20.000
a
273.000
circa: il quarto del fabbisogno italiano era da esso
raggiunto e superato, e solo la Lombardia poteva
6 3
3. - I
l
perio do
b e l l ic o
e
p o s t b e l l ic o
.


















