
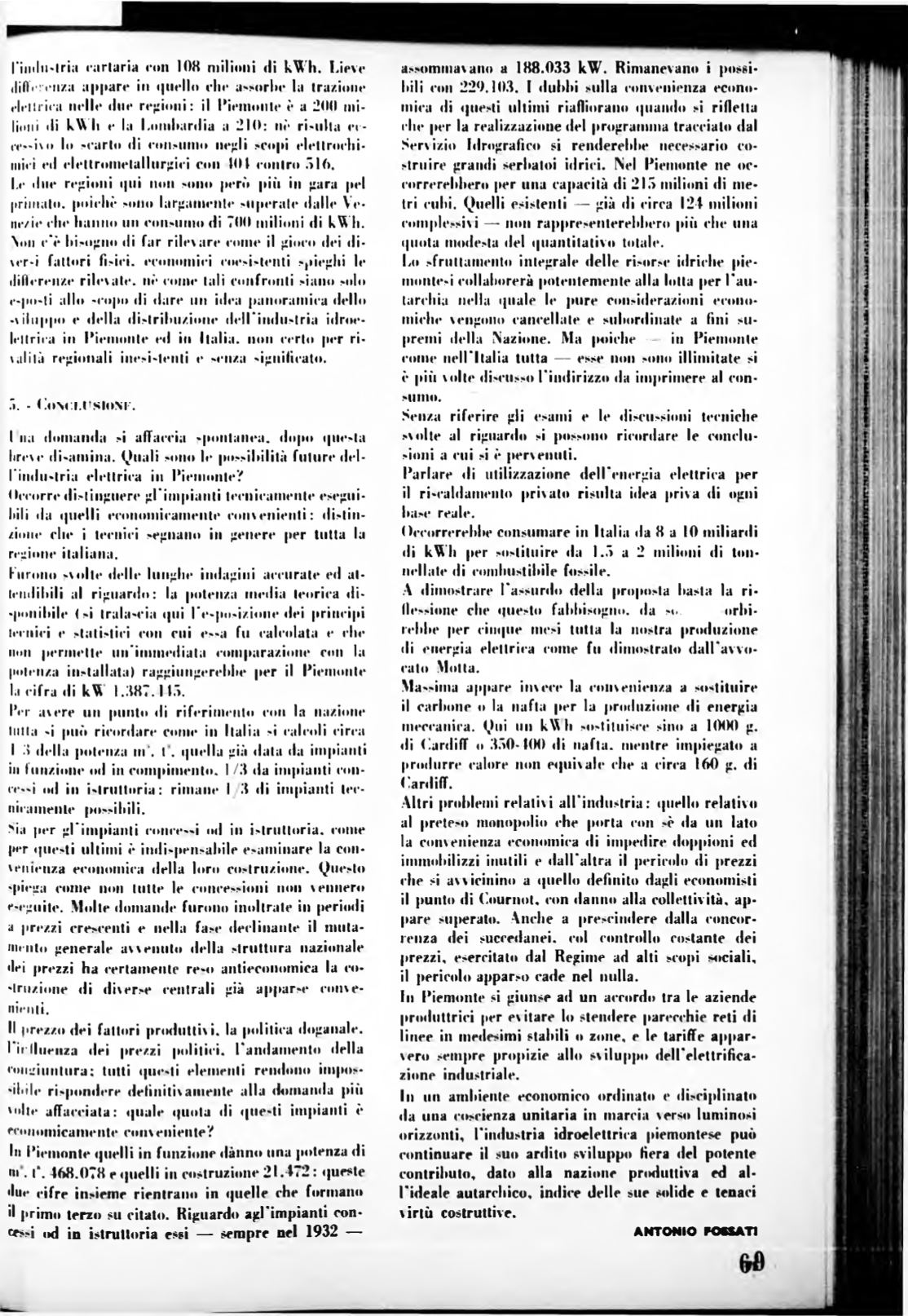
riinlii'triii cartaria con 108 milioni di kW h. Lieve
differenza appare in quello d ie assorbe la trazione
elettrica nelle due regioni: il Piemonte è a 1200 mi
lioni di k\Vh e la Lombardia a 210: nè risulta ec-
ce.»i\o lo scarto di consumo negli scopi elettrochi-
mici ed elettrometallurgici con 104 contro 516.
Le due regioni qui non sono però più in gara pel
primato, poiché sono largamente superate dalle V e
nezie che hanno un consumo di 700 milioni di kWh.
Non c'è bisogno di far rilevare come il gioco dei di-
\er-i fattori fisici, economici coesistenti spieghi le
differenze rilevate, nè come tali confronti siano solo
C'po«ti allo scopo di dare un idea panoramica dello
•viluppo e della distrihu/.ione dell'industria idroe
lettrica in Piemonte ed in Italia, non certo per ri
valità regionali inesistenti e senza significato.
r>. - (!
o x
:
i
.
u s iu n k
.
I na domanda si affaccia spontanea, dopo questa
lireve dUamina. (Ju ali sono le possibilità future del-
l'industria elettrica ili Piemonte?
Occorre distinguere gl'impianti tecnicamente esegui
bili da quelli economicamente convenienti: distin
zione clic i tecnici segnano ili genere per tutta la
regione italiana.
Furono s\olte delle lunghe indagini accurate ed at
tendibili al riguardo: la potenza inedia teorica di-
'punibile (si tralascia qui l'esposizione dei principi
tecnici e statistici con cui essa fu calcolata e che
non permette un'immediata comparazione con la
potenza installata) raggiungerebbe per il Piemonte
la cifra di kW 1.387.115.
IV r a\ere un punto di riferimento con la nazione
tutta 'i può ricordare come in Italia si calcoli circa
I
3
della potenza in', t . quella già data da impianti
in funzione od in compimento. 1/3 da impianti con-
ce-'i od in istruttoria : rimane I 3 di impianti tec
nicamente possibili.
>ia per gl'impianti concessi od in istruttoria, come
per questi ultimi è indispensabile esaminare la con-
temenza economica della loro costruzione. Questo
spiega come non tutte le concessioni non vennero
C'Cguite. Molte domande furono inoltrate in periodi
a prezzi crescenti e nella fase declinante il muta
mento generale avvenuto della struttura nazionale
«lei prezzi ha certamente reso antieconomica la co
rruzione di diverse centrali già apparse come-
nienti.
II prezzo dei fattori produttivi. la politica doganale.
I influenza dei prezzi politici, l'andamento della
congiuntura; tutti questi elementi rendono impos-
'iliile rifo n d e re d e fin iti aniente alla domanda più
'••Ite affacciata: quale quota di questi impianti è
economicamente con\ eniente?
In Piemonte quelli in funzione danno una potenza di
ni . t*. 468.078 e quelli in costruzione 21.4«2 : queste
«lue cifre insieme rientrano in quelle che formano
il primo terzo su citato. Riguardo agl'impianti con*
•ttsi od in istruttoria essi — sempre nel 1932 —
assommavano a 188.033 kW . Rimanevano i possi
bili con 229.103. I dubbi sulla convenienza econo
mica di questi ultimi riaffiorano quando si rifletta
che per la realizzazione del programma tracciato dal
Servizio Idrografico si renderebbe necessario co
struire grandi serbatoi idrici. Nel Piemonte ne oc
correrebbero per una capacità di 215 milioni di me
tri cubi. Quelli esistenti — già di circa 124 milioni
complessivi — non rappresenterebbero più che una
quota modesta del quantitativo totale.
Lo sfruttamento integrale delle risorse idriche pie
montesi collahorerà potentemente alla lotta per l'a u
tarchia nella «piale le pure considerazioni econo
miche vengono cancellate e subordinate a fini su
premi della Nazione. Ma poiché — in Piemonte
come nell'Italia tutta — esse non sono illim itate si
è più volte discusso l'indirizzo da imprimere al con
sumo.
Senza riferire gli esami e le discussioni tecniche
svolte al riguardo si possono ricordare le conclu
sioni a cui si è pervenuti.
Parlare di utilizzazione dell'energia elettrica per
il riscaldamento privato risulta idea priva di ogni
base reale.
Occorrerebbe consumare in Italia da 8 a 10 m iliardi
di kWh per sostituire da 1.5 a 2 milioni di ton
nellate di combustibile fossile.
A dimostrare l'assurdo della proposta basta la r i
flessione che questo fabbisogno, da st..
orbi-
rehbe per cinque mesi tutta la nostra produzione
di energia elettrica come fu dimostralo dall'avvo-
cato Motta.
Massima appare invece la coincidenza a sostituire
il carbone o la nafta per la produzione di energia
meccanica. Qui un k\\ h sostituisce siilo a 1000 g.
di (lardiff o 350-400 di nafta. mentre impiegato a
produrre calore non equivale che a circa 160 g. di
Cardiff.
A ltri problemi relativi all'industria: quello relativo
al preteso monopolio che porta con sè da un lato
la convenienza economica di impedire doppioni ed
immobilizzi inutili e dall'altra il pericolo di prezzi
che si avvicinino a quello definito dagli economisti
il punto di Cournot, con danno alla collettività, ap
pare superato. Anche a prescindere dalla concor
renza dei succedanei, col controllo costante dei
prezzi, esercitato dal Regime ad alti scopi sociali,
il pericolo apparso cade nel nulla.
In Piemonte si giunse ad un accordo tra le aziende
produttrici per evitare lo stendere parecchie reti di
linee in medesimi stabili o zone, e le tariffe appar
vero sempre propizie allo sviluppo dell'elettrifica
zione industriale.
In un ambiente economico ordinato e disciplinato
da una coscienza unitaria in marcia verso luminosi
orizzonti, l'industria idroelettrica piemontese può
continuare il suo ardito sviluppo fiera del potente
contributo, dato alla nazione produttiva ed al
l'ideale autarchico, indice delle sue solide e tenaci
virtù costruttive.
ANTONIO POSSATI


















