
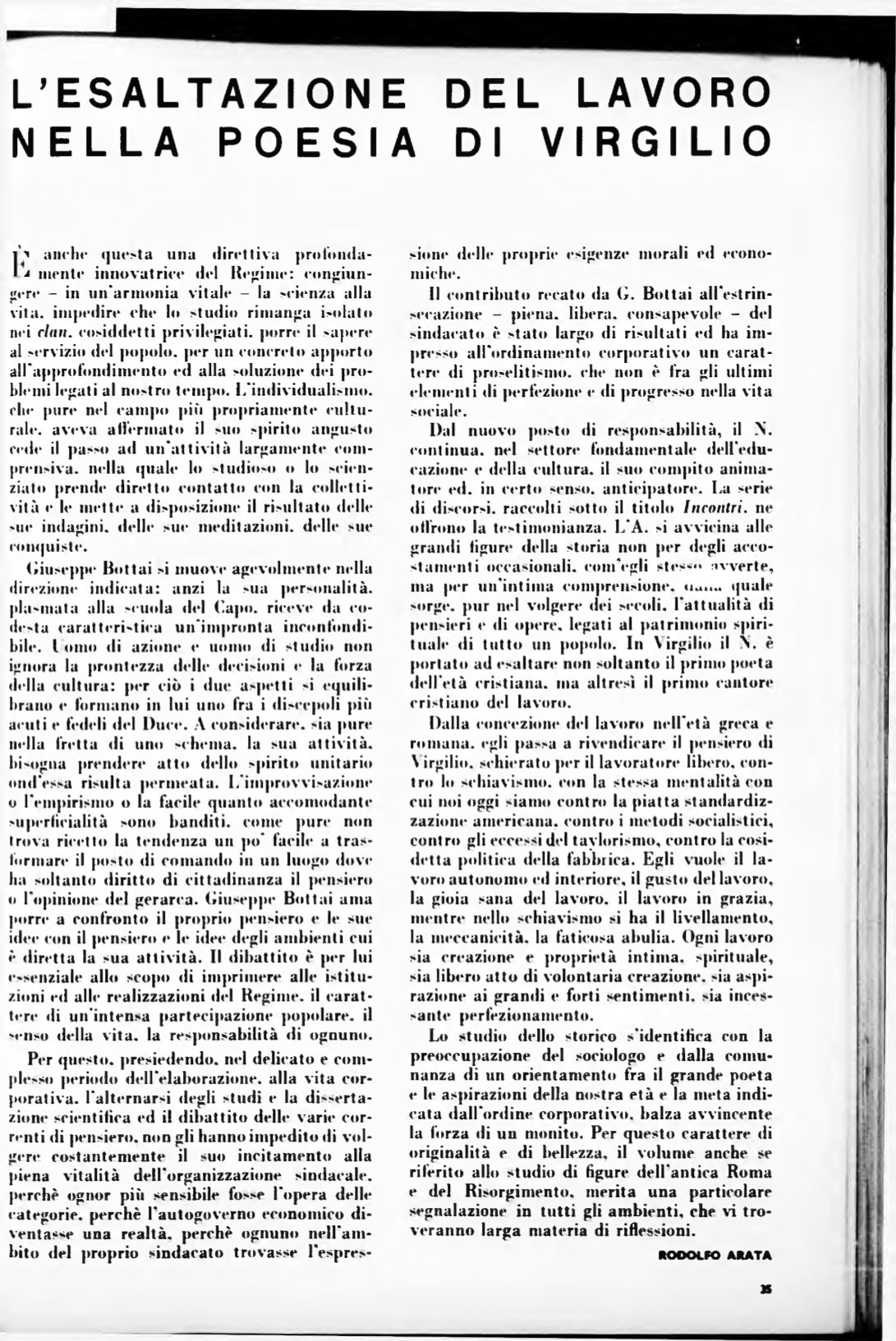
L ’ E S A L T A Z I ONE DE L LAVORO
N E L L A P O E S I A DI VI RGI L I O
I
N anche questa una direttiva profonda*
*
mente innovatrice del Redime: congiun-
pere - in un'armonia vitale - la scienza alla
vita, impedire che lo studio rimanda isolato
nei
clan,
cosiddetti privilegiati, porre il sapere
al servizio del popolo, per un concreto apporto
sH'approfondimcnto ed alla soluzione dei pro
blemi legati al nostro tempo. I/individualismo,
clic pure nel campo più propriamente cultu
rale. aveva affermato il suo spirito angusto
cede il passo ad un'attività largamente com
prensiva. nella «piale lo studioso o lo scien
ziato prende diretto contatto con la colletti
vità e le inette a disposizione il risultato delle
sue indagini, delle sue meditazioni, delle sue
conquiste.
Giuseppe Bottai si muove agevolmente nella
direzione indicata: anzi la sua personalità,
plasmata alla scuola del Capo, riceve da co
detta caratteristica un'impronta inconfondi
bile. I omo di azione e uomo di studio non
ignora la prontezza delle decisioni e la forza
della cultura: per ciò i due aspetti si equili
brano e formano in lui uno fra i discepoli più
acuti e fedeli del Duce. A considerare, sia pure
nella fretta di uno schema, la sua attività,
bisogna prendere atto dello spirito unitario
ondYssa risulta permeata, l/improvvisazione
o l'empirismo o la facile quanto accomodante
superficialità sono banditi, come pure non
trova ricetto la tendenza un po' facile a tras
formare il posto di comando in un luogo dove
ha soltanto diritto di cittadinanza il pensiero
o l'opinione del gerarca. Giuseppe Bottai ama
porre a confronto il proprio pensiero e le sue
idee con il pensiero e le idee degli ambienti cui
è diretta la sua attività. Il dibattito è per lui
essenziale allo scopo di imprimere alle istitu
zioni ed alle realizzazioni del Regime, il carat
tere di un'intensa partecipazione popolare, il
senso della vita, la responsabilità di ognuno.
Per questo, presiedendo, nel delicato e com
plesso periodo dell'elaborazione, alla vita cor
porativa. l'alternarsi degli studi e la disserta
zione scientifica ed il dibattito delle varie cor
renti di pensiero, non gli hanno impedito di vol
gere costantemente il suo incitamento alla
piena vitalità dell'organizzazione sindacale,
perchè ognor più sensibile fosse l’opera delle
categorie, perchè l'autogoverno economico di
ventasse una realtà, perchè ognuno neU'am-
bito del proprio sindacato trovasse l'espres
sione
delle proprie esigenze mitrali ed econo
miche.
11
contributo recato da G. Bottai all’estrin-
secazione - piena, libera, consapevole - del
sindacato è stato largo di risultati ed ha im
presso all'ordinamento corporativo un carat
tere di proselitismo, che non è fra gli ultimi
elementi «li perfezione «•di progresso nella vita
sociale.
Dal nuovo posto di responsabilità, il NT.
continua, nel settore fondamentale dell'edu-
cazionc e della cultura, il suo compito anima
tore ed. in certo senso, anticipatore. La serie
di discorsi, raccolti sotto il titolo
Incontri,
ne
offrono la testimonianza. L 'A . si avvicina alle
grandi figure «Iella st«>ria non per degli acco
stamenti occasionali, com’egli st«*s>-‘» avverte,
ma p«*r un'intima comprensione, «iu».M quale
sorge,
pur nel v«>Igere dei secoli, l'attualità «li
pensieri e di opere, legati al patrimonio spiri
tuale di tutti» un popolo. In \ irgilio il N. è
portato ad esaltare non soltanto il primo poeta
dell'età cristiana, ma altresì il primo cantore
cristiano del lavoro.
Dalla concezione «lei lavoro nell'età greca e
romana, egli passa a rivendicare il pensiero di
\ irgilio. schi«*rato p«*r il lavoratore libero, con
tro lo schiavismo, con la stessa mentalità con
cui noi oggi siamo contro la piatta standardiz
zazioni* americana, contro i metodi socialistici,
contro gli eccessi del taylorismo, contro la cosi-
detta politica della fabbrica. Egli vuole il la
voro autonomo e«l interiore, il gusto «lei lavoro,
la gioia sana del lavoro, il lavoro in grazia,
mentre nello schiavismo si ha il livellamento,
la meccanicità, la faticosa abulia. Ogni lavoro
sia creazione e proprietà intima, spirituale,
sia lib«*ro atto di volontaria creazione, sia aspi
razione ai grandi e forti sentimenti, sia inces
sante perfezionamento.
Lo studio dello storico s'identifica con la
preoccupazione del sociologo e dalla comu
nanza di un orientamento fra il grande poeta
e le aspirazioni della nostra età e la meta indi
cata dall'ordine corporativo, balza avvincente
la forza di un monito. Per questo carattere di
originalità e di bellezza, il volume anche se
riferito allo studio di figure dell'antica Roma
e del Risorgimento, merita una particolare
segnalazione in tutti gli ambienti, che vi tro
veranno larga materia di riflessioni.
RODOLFO A IU T A
3S


















