
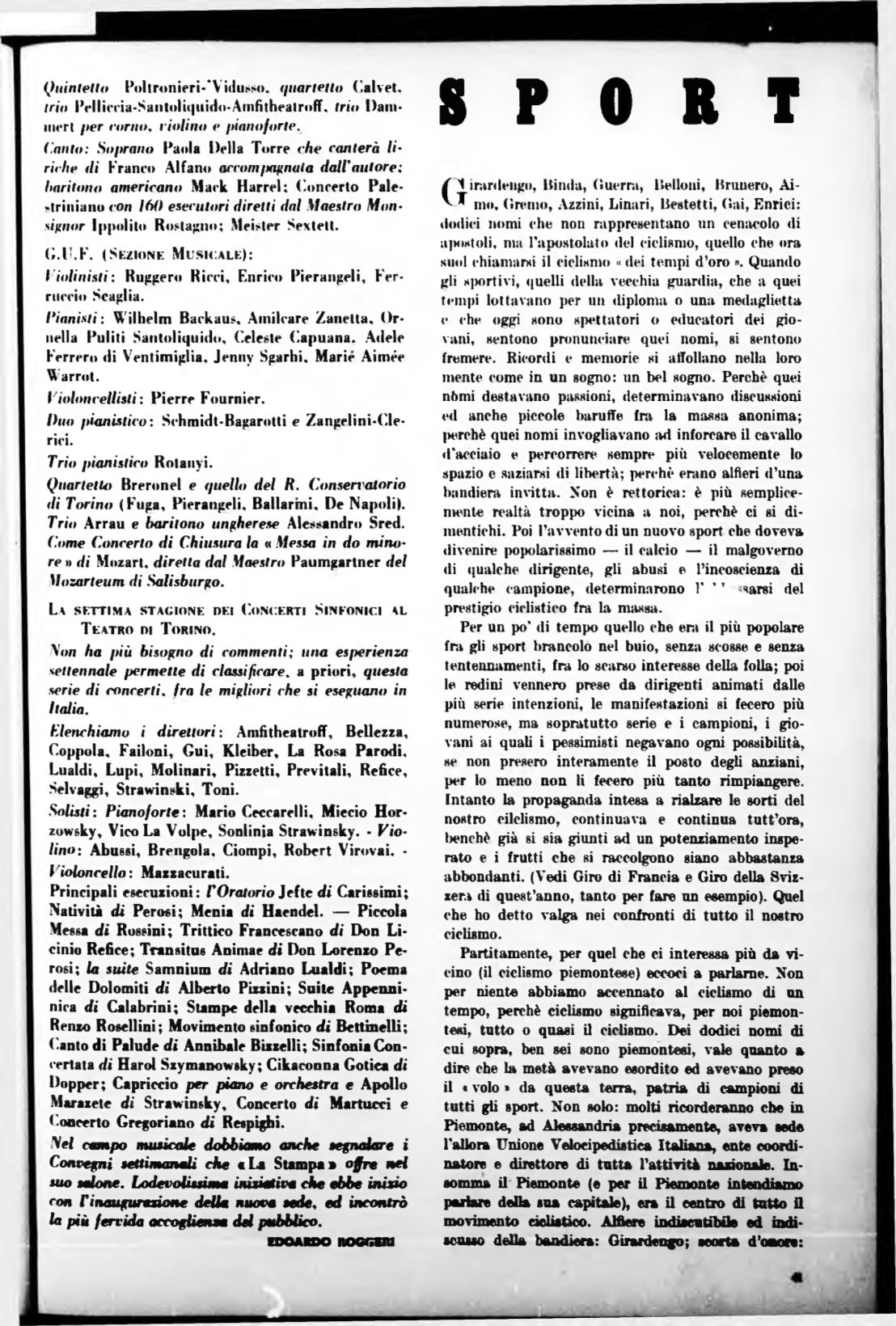
Quintetto
Poltronieri-’Vidusso,
quartetto
Calvet,
trio
Pelliccia-Santoliquido-Ainfitheatroff.
trio
Dam-
meri
per corno, riolino e pianoforte.
('.auto: Soprano
Paola Della Torre
che canterà li-
riche ili
Franco Alfano
accom/lagnala dall'autore;
baritono americano
Mark Harrel; Concerto Pale-
«triniano
con 160 esecutori diretti dal Maestro Mon
signor
Ippolito Roslagno; Meister Sextell.
G.U.F.
(S
e z io n e
M
u s ic a l e
):
Violinisti
: Ruggero Ricci, Enrico Pierangeli, Fer
ruccio Scaglia.
Pianisti :
Wilhelm Backaus, Amilcare Zanella, Or
nella Puliti Santoliquido, Celeste Capuana. Adele
Ferrerò di Ventimiglia. Jenny Sgarhi. Marie Aimée
Warrot.
Violoncellisti
: Pierre Fournier.
Duo pianistico
: Schmidt-Ba^arotti
e
Zangelini-Cle-
rici.
Trio pianistico
Rotanyi.
Quartetto
Breronel
e quello del R. Conservatorio
di Torino
(Fuga, Pierangeli, Ballarmi, De Napoli).
Trio
Arrau e
baritono ungherese
Alessandro Sred.
Come Concerto di Chiusura la
«
Messa in do m ino
re
»
di
Mozart,
diretta dal Maestro
Paumgartner
del
Mozarteum di Salisburgo.
L
a
s e t t im a
s t a g io n e
o ei
C
o n c er t i
S
in f o n ic i
a l
T
ea t r o
ni T
o r in o
.
Vort
ha più bisogno di commenti; una es/terienza
settennale permette di classificare,
a priori,
questa
serie di concerti, fra le migliori che si eseguano in
Italia.
Elenchiamo i direttori
: Amfitheatroff, Bellezza,
Coppola, Failoni, Gui, Kleiber, La Rosa Parodi.
Lualdi, Lupi, Molinari, Pizzetti, Previtali, Refice,
Selvaggi, Strawinski, Toni.
Solisti: Pianoforte
: Mario Ceccarelli, Miecio Hor-
zowsky, Vico La Volpe, Sonlinia Strawinsky. -
V io
lino:
Abussi, Brengola, Ciompi, Robert Virovai. -
f ioloncello :
Mazzacurati.
Principali esecuzioni:
VOratorio
Jeftc
di
Carissimi;
Natività
di
Perosi; Menia
di
Haendel. — Piccola
Messa
di
Rossini; Trittico Francescano
di
Don Li
cinio Refice; Transitus Animae
di
Don Lorenzo Pe
rosi;
la suite
Samnium
di
Adriano Lualdi; Poema
delle Dolomiti
di
Alberto Pizzini; Suite Appenni
nica
di
Calabrini; Stampe della vecchia Roma
di
Renzo Rosellini; Movimento sinfonico
d i
Bettinelli;
Canto di Palude
di
Annibaie Bizzelli; Sinfonia Con
certata
di
Harol Szymanowsky; Cikaconna Gotica
di
Dopper; Capriccio
per piano e orchestra e
Apollo
Marazete
di
Strawinsky, Concerto
di
Martucci
e
Concerto Gregoriano
di
Respighi.
Ve/
campo musicale dobbiamo anche segnalare i
Convegni settimanali che
«La Stampa»
offre nel
suo salone. Lodevolissima iniziativa che ebbe inizio
fon V inaugurazione della nuova sede
,
ed incontrò
la più fervida accoglienza dei pubblico.
EDOARDO TMW rH W
S P O R T
(
1 irurdeugo, Binda, Guerra, Belloni, Brunero, Ai-
^ ino, (iremo, Azzini, Linari, Bestetti, Gai, Enrici:
dodici nomi ohe non rappresentano un cenacolo di
apostoli, ma l’apostolato del ciclismo, quello che ora
suol chiamarsi il ciclismo «dei tempi d’oro ». Quando
gli sportivi, quelli della vecchia guardia, che a quei
tempi lottavano per un diploma o una medaglietta
c che oggi sono spettatori o educatori dei gio
vani, sentono pronunciare quei nomi, si sentono
fremere. Ricordi e memorie si affollano nella loro
mente come in un sogno: un bel sogno. Perchè quei
nómi destavano passioni, determinavano discussioni
ed anche piccole baruffe fra la massa anonima;
!>erchè quei nomi invogliavano ad inforcare il cavallo
«l'acciaio e percorrere sempre più velocemente lo
spazio e saziarsi di libertà; perchè erano alfieri d’una
bandiera invitta. Non è rettorica: è più semplice
mente realtà troppo vicina a noi, perchè ci si di
mentichi. Poi l’avvento di un nuovo sport che doveva
divenire popolarissimo — il calcio — il malgoverno
di qualche dirigente, gli abusi e l’incoscienza di
qualche campione, determinarono T ’ ’ sarei del
prestigio ciclistico fra la massa.
Per un po' di tempo quello che era il più popolare
fra gli sport brancolo nel buio, senza scosse e senza
tentennamenti, fra lo scarso interesse della folla; poi
le redini vennero prese da dirigenti animati dalle
più serie intenzioni, le manifestazioni si fecero più
numerose, ma sopratutto serie e i campioni, i gio
vani ai quali i pessimisti negavano ogni possibilità,
se non presero interamente il posto degli anziani,
per lo meno non li fecero più tanto rimpiangere.
Intanto la propaganda intesa a rialzare le sorti del
nostro cilclismo, continuava e continua tu tt’ora,
benché già si sia giunti ad un potenziamento inspe
rato e i frutti che si raccolgono siano abbastanza
abbondanti. (Vedi Giro di Francia e Giro della Sviz
zera di quest’anno, tanto per fare un esempio). Quel
che ho detto valga nei confronti di tutto il nostro
ciclismo.
Paratamente, per quel che ci interessa più da vi
cino (il ciclismo piemontese) eccoci a parlarne. Non
per niente abbiamo accennato al ciclismo di un
tempo, perchè ciclismo significava, per noi piemon
tesi, tutto o quasi il ciclismo. Dei dodici nomi di
cui sopra, ben sei sono piemontesi, vale quanto a
dire che la metà avevano esordito ed avevano preso
il «volo » da questa terra, patria di campioni di
tutti gli sport. Non solo: molti ricorderanno che in
Piemonte, ad Alessandria precisamente, aveva sede
l'allora Unione Velocipedistica Italiana, ente coordi
natore e direttore di tutta l'attività nazionale. In-
somma il Piemonte (e per il Piemonte intendiamo
parlare della sua capitale), era il centro di tatto 11
movimento ciclistico. Alfiere indiscutibile ed indi-
scasso della bandiera: Girardengo; senta d’onore:


















