
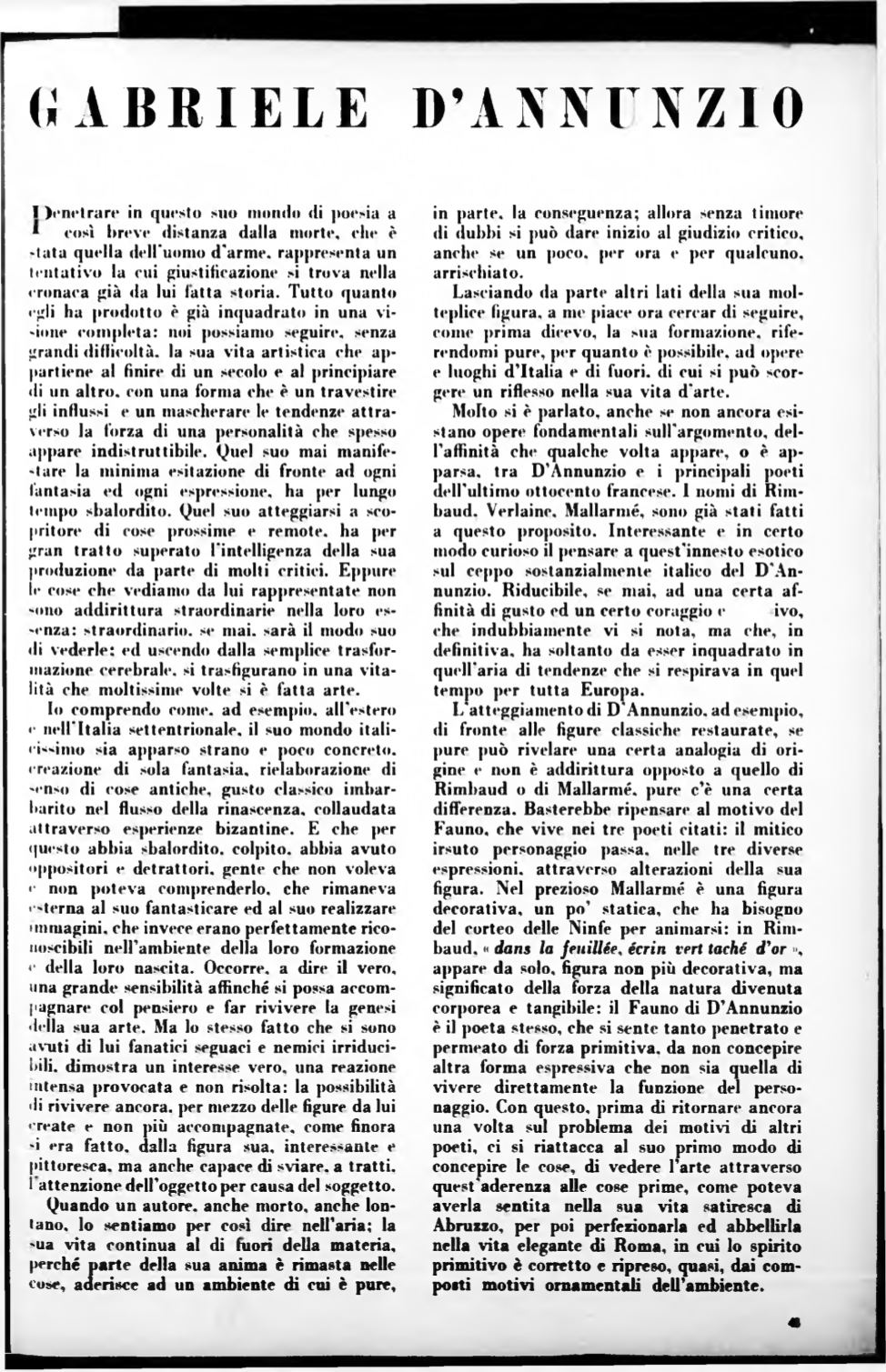
G A B R I E L E D’ ANNUNZIO
I )enetrare in questo suo mondo di poesia a
* così breve distanza dalla morte, che è
«lata quella dell'uomo d'arme, rappresenta un
tentativo la cui giustificazione si trova nella
«Tonaca già da lui latta storia. Tutto quanto
(‘gli ha prodotto è già inquadrato in una vi-
'ione completa: noi possiamo seguire, senza
grandi difficoltà, la sua vita artistica che ap-
partiene al finire di un secolo e al principiare
di un altro, con una forma che è un travestire
gli influssi e un mascherare le tendenze attra
verso la forza di una personalità che spesso
appare indistruttibile. Quel suo mai manife-
'tare la minima esitazione di fronte ad ogni
fantasia ed ogni espressione, ha per lungo
tempo sbalordito. Quel suo atteggiarsi a sco
pritore di cose prossime e remote, ha per
gran tratto superato l'intelligenza della sua
produzione da parte di molti critici. Eppure
le cose che vediamo da lui rappresentate non
>ono addirittura straordinarie nella loro es
senza: straordinario, se mai. sarà il modo suo
di vederle; ed uscendo dalla semplice trasfor
mazione cerebrale, si trasfigurano in una vita
lità che moltissime volte si è fatta arte.
Io comprendo come, ad esempio, all'estero
e nell'Italia settentrionale, il suo mondo itali-
cissimo sia apparso strano e poco concreto,
creazione di sola fantasia, rielaborazione di
'(•nso di cose antiche, gusto classico imbar
barito nel flusso della rinascenza, collaudata
attraverso esperienze bizantine. E che per
questo abbia sbalordito, colpito, abbia avuto
oppositori «* detrattori, gente che non voleva
•• non poteva comprenderlo, che rimaneva
esterna al suo fantasticare ed al suo realizzare
immagini, che invece erano perfettamente rico
noscibili nelPambiente della loro formazione
e della loro nascita. Occorre, a dire il vero,
una grande sensibilità affinché si possa accom
pagnare col pensiero e far rivivere la genesi
«Iella sua arte. Ma lo stesso fatto che si sono
avuti di lui fanatici seguaci e nemici irriduci
bili. dimostra un interesse vero, una reazione
intensa provocata e non risolta: la possibilità
•li rivivere ancora, per mezzo delle figure da lui
create e non più accompagnate, come finora
'i era fatto, dalla figura sua, interessante e
pittoresca, ma anche capace di sviare, a tratti.
I attenzione dell'oggetto per causa del soggetto.
Quando un autore, anche morto, anche lon
tano. lo sentiamo per così dire nell’aria; la
'Ua vita continua al di fuori della materia,
perché parte della sua anima è rimasta nelle
cose, aderisce ad un ambiente di cui è pure,
in parte, la conseguenza; allora senza timore
di dubbi si può dare inizio al giudizio critico,
anche se un poco, per ora e per qualcuno,
arrischiato.
Lasciando da parte altri lati della sua mol
teplice figura, a me piace ora cercar di seguire,
come prima dicevo, la sua formazione, rife
rendomi pure, per quanto è possibile, ad opere
e luoghi d'Italia e di fuori, di cui si può scor
gere un riflesso nella sua vita d'arte.
Molto si è parlato, anche se non ancora esi
stano opere fondamentali suU'argomento, del
l'affinità che qualche volta appare, o è ap
parsa. tra D’Annunzio e i principali poeti
dell'ultimo ottocento francese. I nomi di Riin-
baud. Verlaine. Mallarmé, sono già stati fatti
a questo proposito. Interessante e in certo
modo curioso il pensare a quest'innesto esotico
sul ceppo sostanzialmente italico del D'An
nunzio. Riducibile, se mai, ad una certa af
finità di gusto ed un certo coraggio e
ivo,
che indubbiamente vi si nota, ma che, in
definitiva, ha soltanto da esser inquadrato in
quell'aria di tendenze che si respirava in quel
tempo per tutta Europa.
L'atteggiamento di D'Annunzio, ad esempio,
di fronte alle figure classiche restaurate, se
pure può rivelare una certa analogia di ori
gine e non è addirittura opposto a quello di
Rimbaud o di Mallarmé, pure c'è una certa
differenza. Basterebbe ripensare al motivo del
Fauno, che vive nei tre poeti citati: il mitico
irsuto personaggio passa, nelle tre diverse
espressioni, attraverso alterazioni della sua
figura. Nel prezioso Mallarmé è una figura
decorativa, un po’ statica, che ha bisogno
del corteo delle Ninfe per animarsi: in Rim
baud. «
dans la feuillée
,
écrin vert taché d'or
»,
appare da solo, figura non più decorativa, ma
significato della forza della natura divenuta
corporea e tangibile: il Fauno di D’Annunzio
è il poeta stesso, che si sente tanto penetrato e
permeato di forza primitiva, da non concepire
altra forma espressiva che non sia quella di
vivere direttamente la funzione del perso
naggio. Con questo, prima di ritornare ancora
una volta sul problema dei motivi di altri
poeti, ci si riattacca al suo primo modo di
concepire le cose, di vedere l’arte attraverso
quest'aderenza alle cose prime, come poteva
averla sentita nella sua vita
satiresca di
Abruzzo, per
poi perfezionarla ed
abbellirla
nella vita elegante
di
Roma,
in cui lo
spirito
primitivo è
corretto
e ripreso, quasi, dai
com
posti motivi ornamentali dell’ambiente,
41
■


















