
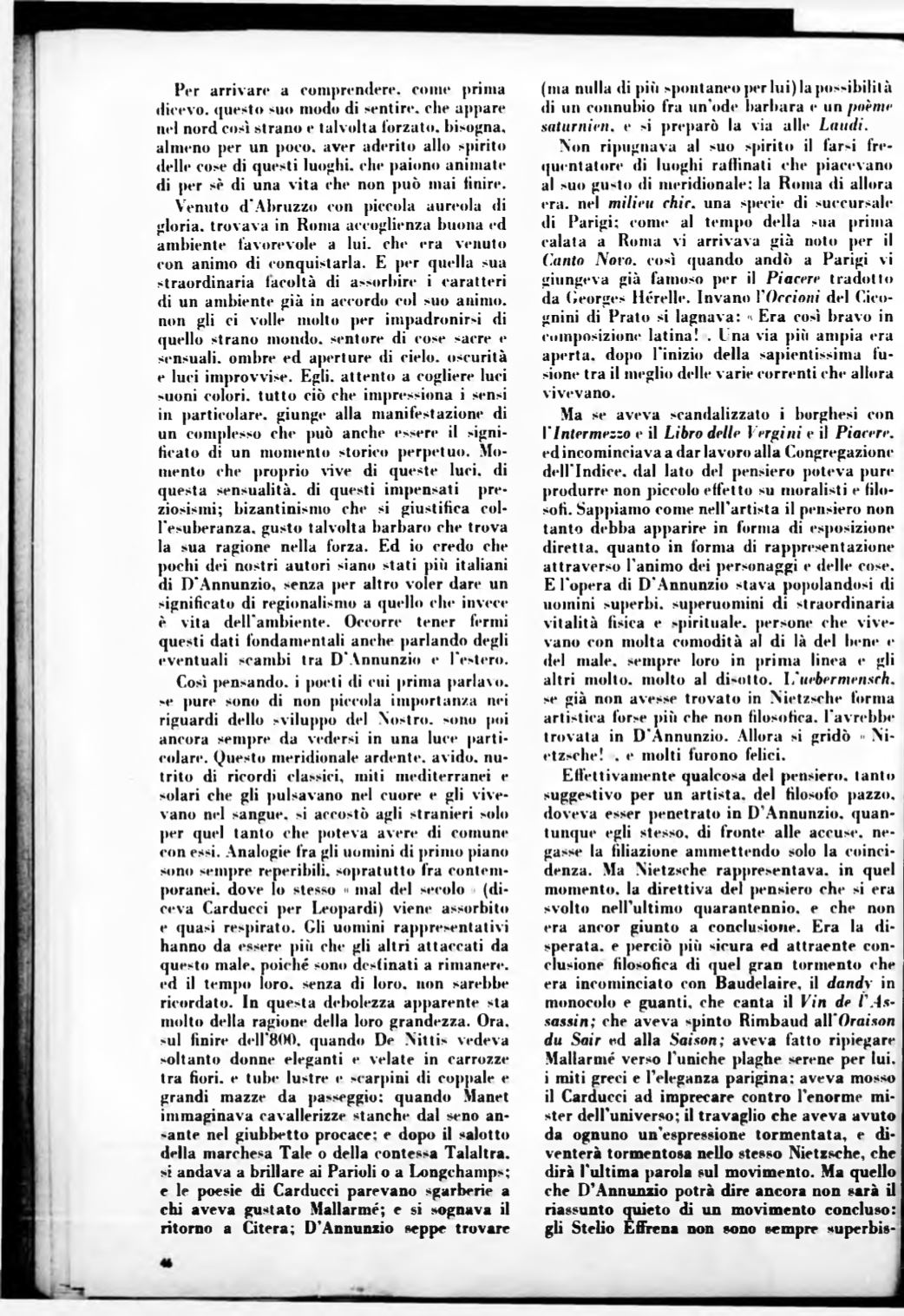
Per arrivare a comprendere, come prima
dicevo, questo suo modo di sentire, che appare
nel nord così strano e talvolta l'orzato, bisogna,
almeno per un poco, aver aderito allo spirito
«Ielle cose di questi luoghi, che paiono animate
di per sè di una vita che non può mai finire.
Venuto d'Abruzzo con piccola aureola di
gloria, trovava in Roma accoglienza buona ed
ambiente favorevole a lui. che era venuto
con animo di conquistarla. E per quella sua
straordinaria facoltà di assorbire i caratteri
di un ambiente già in accordo col suo animo,
non gli ci volle molto per impadronirsi di
quello strano mondo, sentore di cose sacre e
sensuali, ombre ed aperture di cielo, oscurità
e luci improvvise. Egli, attento a cogliere luci
suoni colori, tutto ciò che impressiona i sensi
in particolare, giunge alla manifestazione di
un complesso che può anche essere il signi
ficato di un momento storici» perpetuo. Mo
mento che proprio vive di queste luci, di
questa sensualità, di questi impensati pre
ziosismi; bizantinismo che si giustifica col
l'esuberanza. gusto talvolta barbaro che trova
la sua ragione nella forza. Ed io credo che
pochi dei nostri autori siano stati più italiani
di D'Annunzio, senza per altro voler dare un
significato di regionalismo a quello clic invece
è vita deH'ambientc. Occorre tener fermi
questi dati fondamentali anche parlando degli
eventuali scambi tra D'Annunzio e l'estero.
Così pensando, i poeti di cui prima parlavo,
se pure sono di non piccola importanza nei
riguardi dello sviluppo del Nostro, sono poi
ancora sempre da vedersi in una luce parti
colare. Questo meridionale ardente, avido, nu
trito di ricordi classici, miti mediterranei e
solari che gli pulsavano nel cuore e gli vive
vano nel sangue. >i accostò agli stranieri solo
per quel tanto che poteva avere di comune
con essi. Analogie fra gli uomini di primo piano
sono sempre reperibili, sopratutto fra contem
poranei. dove lo stesso « mal del secolo » (di
ceva Carducci per Leopardi) viene assorbito
e quasi respirato. Gli uomini rappresentativi
hanno da essere più che gli altri attaccati da
questo male, poic hé sono destinati a rimanere,
ed il tempo loro, senza di loro, non sarebbe
ricordato. In questa debolezza apparente sta
molto della ragione della loro grandezza. Ora.
>ul finire dell*800. quando De Nittis vedeva
soltanto donne eleganti e velate in carrozze
tra fiori, e tube lustre e carpini di coppale e
grandi mazze da passeggio: quando Manet
immaginava cavallerizze stanche dal seno an-
-ante nel giubbetto procace; e dopo il salotto
della marchesa Tale
o
della contessa Talaltra,
si andava a brillare ai Parioli
o
a Longchamps;
e
le poesie di Carducci parevano sgarberie a
chi
aveva gustato Mallarmé;
e si
sognava il
ritorno a Citerà; D'Annunzio seppe trovare
(ma nulla di più spontaneo per lui) la possibilità
di un connubio fra un’ode barbara c un
poèmi'
saturni
v ii
, e »i preparò la via alle
Laudi.
Non ripugnava al suo spirito il farsi fre
quentatore di luoghi raffinati che piacevano
al suo gu-to di meridionale; la Roma di allora
era. nel
milieu chic,
una specie di succursale
di Parigi; come al tempo della
M ia
prima
calata a Roma vi arrivava già noto per il
Canta Novo,
così quando andò a Parigi vi
giungeva già famoso per il
Piacere
tradotto
da Georges Hérelle. Invano
VOrciorli
del Cico
gnini di Prato si lagnava: « Era così bravo in
composizione latina! . Una via più ampia era
aperta, dopo l'inizio della sapientissima fu
sione tra il meglio delle varie correnti che allora
vivevano.
Ma se aveva scandalizzato i borghesi con
l'
Intermezzo
e il
Libro delle Vergini
e il
Piovere.
ed incominciava a dar lavoro alla Congregazione
dell'indice, dal lato del pensiero poteva pure
produrre non piccolo effetto su moralisti e filo
sofi. Sappiamo come nell’artista il pensiero non
tanto debba apparire in forma di esposizione
diretta, quanto in forma di rappresentazione
attraverso l'animo dei personaggi e delle cose.
E l'opera di D'Annunzio stava popolandosi di
uomini superbi, superuomini di straordinaria
vitalità fisica e spirituale, persone che vive
vano con molta comodità al di là del bene e
del male, sempre loro in prima linea e gli
altri molto, molto al di-otto,
h'uebermensch.
se già non avesse trovato in Nietzsche forma
artistica forse più che non filosofica, l'avrebbe
trovata in D'Annunzio. Allora si gridò » Ni
etzsche! ", e molti furono felici.
Effettivamente qualcosa del pensiero, tanto
suggestivo per un artista, del filosofo pazzo,
doveva esser penetrato in D’Annunzio, quan
tunque egli stesso, di fronte alle accuse, ne
gasse la filiazione ammettendo solo la coinci
denza. Ma Nietzsche rappresentava, in quel
momento, la direttiva del pensiero che si era
svolto nell'ultimo quarantennio, e che non
era ancor giunto a conclusione. Era la di
sperata. e perciò più sicura ed attraente con
clusione filosofica di quel gran tormento che
era incominciato con Baudelaire, il
dandy
in
monocolo e guanti, che canta il
Vin de VAs~
sassin;
che aveva spinto Rimbaud
dW'Oraison
du Soir
ed alla
Saìson;
aveva fatto ripiegare
Mallarmé verso Tuniche plaghe serene per lui.
i miti greci e l’eleganza parigina: aveva mosso
il Carducci ad imprecare contro l’enorme mi
ster dell’universo ; il travaglio che aveva avuto
da ognuno un'espressione tormentata, e di*
venterà tormentosa nello stesso Nietzsche, che
dirà
l'ultima parola sul movimento. Ma quello
che
D’Annunzio potrà dire ancora non sarà il
riassunto quieto di un movimento concluso:
gli Stelio ESfrena non sono sempre superbis-


















