
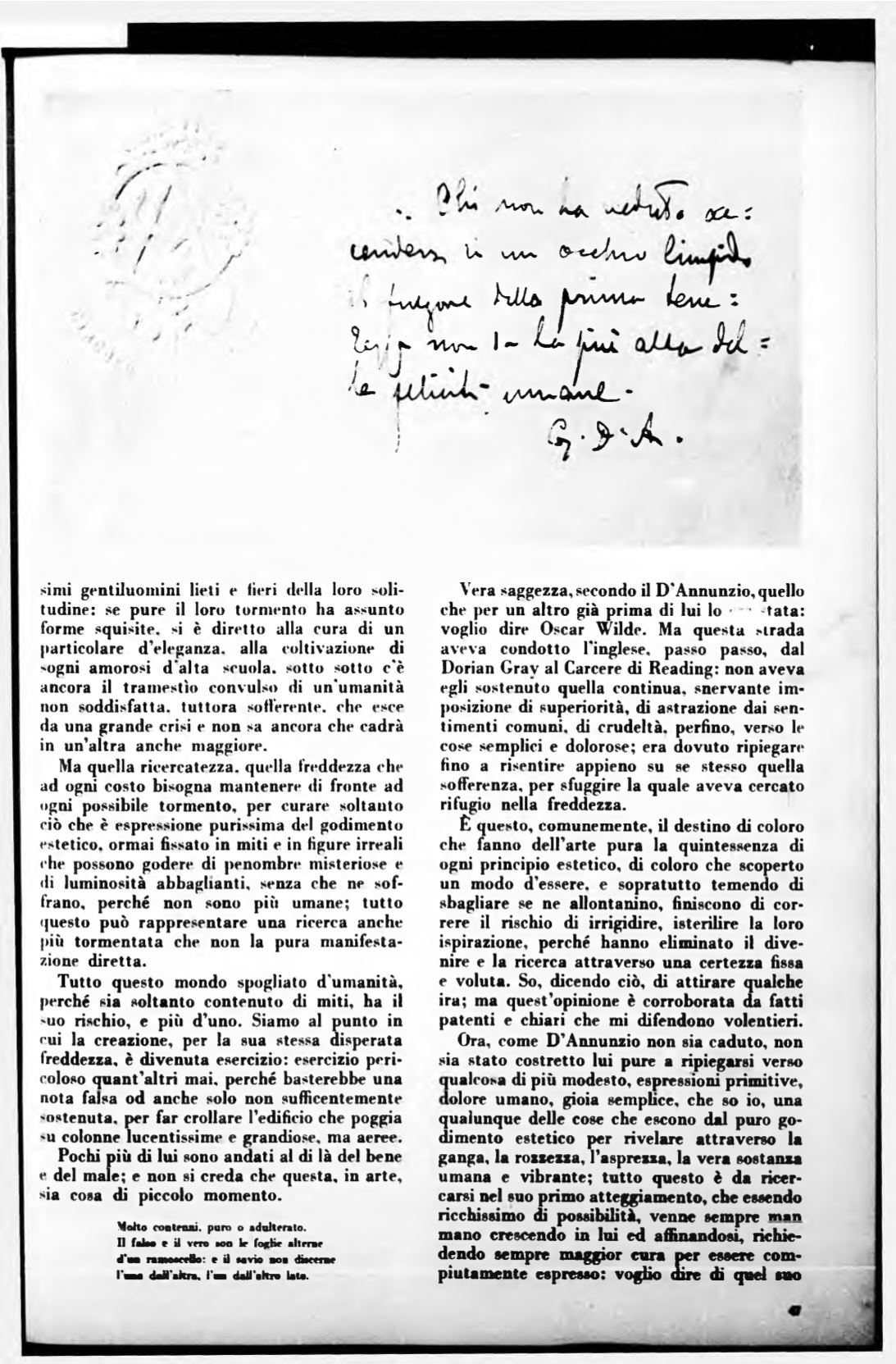
-
, W u
^
g
/ X X - ;
'
1
f
/ '
l * m a a
^ - ^ t^A ^ y O
- ; "
i >
U
a
J
u
.
v
^
K U a ^ u -
l e ^ A J u i
U / K 'H v ^ - I •*'
fd
W '
&£
I / J r ' I
/
''A -
V v v V * '^ kA/v^ — "
j
'
£ • > ' / •
simi gentiluomini lieti e fieri della loro soli
tudine: se pure il loro tormento ha assunto
forme squisite, si è diretto alla cura di un
particolare d'eleganza, alla coltivazione di
>ogni amorosi d alta scuola, sotto sotto c*è
ancora il tramestìo convulso di un'umanità
non soddisfatta, tuttora sofferente, che esce
da una grande crisi e non sa ancora che cadrà
in un'altra anche maggiore.
Ma quella ricercatezza, quella freddezza che
ad ogni costo bisogna mantenere di fronte ad
ogni possibile tormento, per curare soltanto
ciò che è espressione purissima del godimento
estetico, ormai fissato in miti e in figure irreali
ehe possono godere di penombre misteriose e
<li luminosità abbaglianti, senza che ne sof
frano, perché non sono più umane; tutto
questo può rappresentare una ricerca anche
più tormentata che non la pura manifesta
zione diretta.
Tutto questo mondo spogliato d'umanità,
perché sia soltanto contenuto di miti, ha il
>uo rischio, e più d'uno. Siamo al punto in
eui la creazione, per la sua stessa disperata
freddezza, è divenuta esercizio: esercizio peri
coloso quant'altri mai. perché basterebbe una
nota falsa od anche solo non sufficentemente
sostenuta. per far crollare l'edifìcio che poggia
'U colonne lucentissime e grandiose, ma aeree.
Pochi più di lui sono andati al di là del bene
e del male; e non si creda che questa, in arte,
sia cosa di piccolo momento.
M olto contraili, puro o adulterato.
Il falso e il vero ton Ir foghe alterne
«l’un ramoderilo: e il «avio non dùcente
l'una dall'altra, l'un dall’altro lata.
Vera saggezza, secondo il D'Annunzio, quello
che per un altro già prima di lui lo • ■-tata:
voglio dire Oscar Wilde. Ma questa >irada
aveva condotto l'inglese, passo passo, dal
Dorian Grav al Carcere di Reading: non aveva
egli sostenuto quella continua, snervante im
posizione di superiorità, di astrazione dai sen
timenti comuni, di crudeltà, perfino, verso le
cose semplici e dolorose; era dovuto ripiegare
fino a risentire appieno su se stesso quella
sofferenza, per sfuggire la quale aveva cercato
rifugio nella freddezza.
£ questo, comunemente, il destino di coloro
che fanno dell'arte pura la quintessenza di
ogni principio estetico, di coloro che scoperto
un modo d'essere, e sopratutto temendo di
sbagliare se ne allontanino, finiscono di cor
rere il rischio di irrigidire, isterilire la loro
ispirazione, perché hanno eliminato il dive
nire e la ricerca attraverso una certezza fissa
e voluta. So, dicendo ciò, di attirare qualche
ira; ma quest'opinione è corroborata da fatti
patenti e chiari che mi difendono volentieri.
Ora, come D'Annunzio non sia caduto, non
sia stato costretto lui pure a ripiegarsi verso
ualcosa di più modesto, espressioni primitive,
olore umano, gioia semplice, che so io, una
qualunque delle cose che escono dal puro go
dimento estetico per rivelare attraverso la
ganga, la rozzezza, l'asprezza, la vera sostanza
umana e vibrante; tutto questo è da ricer
carsi nel suo primo atteggiamento, che essendo
ricchissimo di possibilità, venne sempre man
mano crescendo in lui ed affinandosi, richie
dendo sempre maggior cura per essere com
piutamente espresso: voglio dire di quel suo


















