
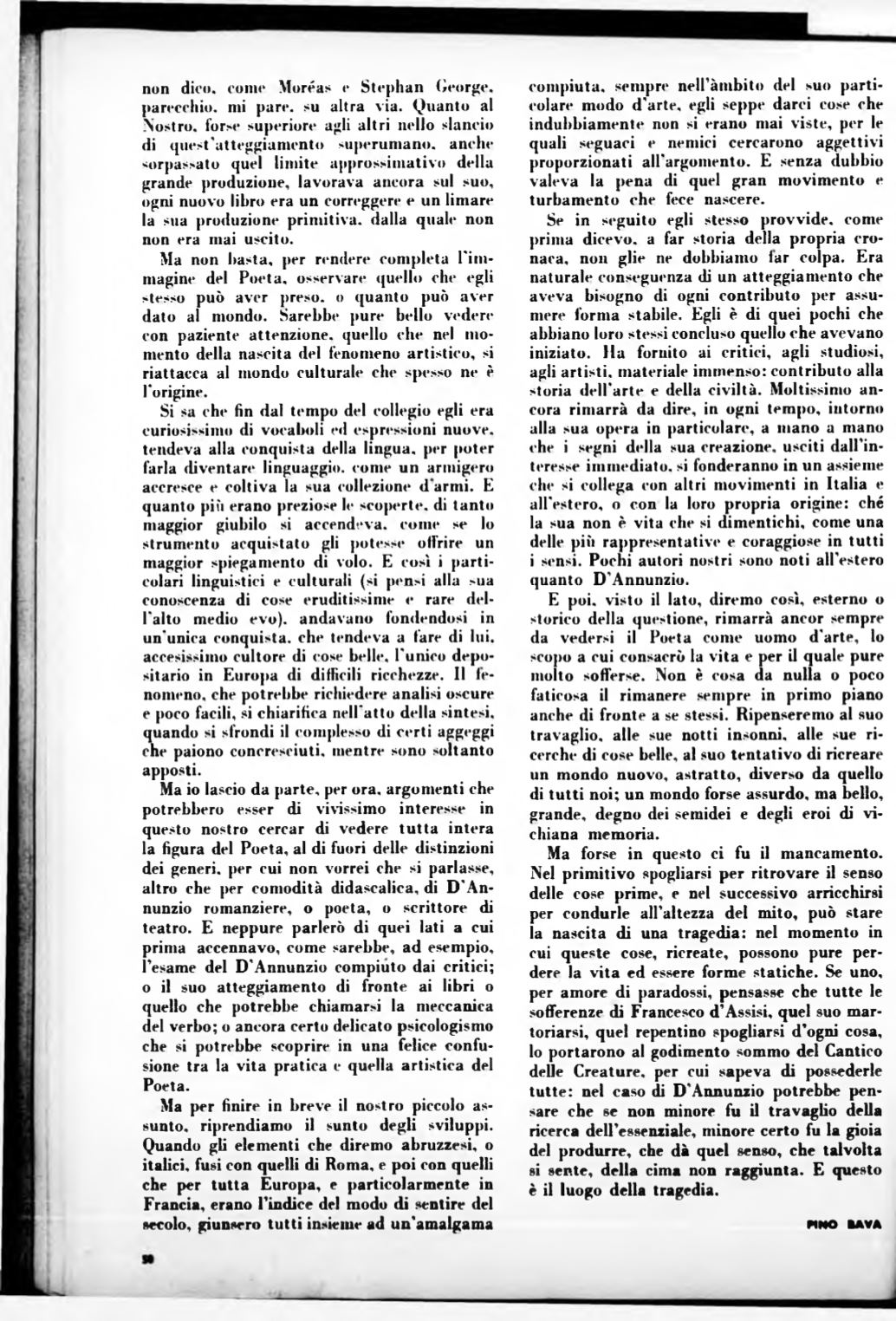
non dico, come Moréas e Stephan George,
parecchio, mi pare, su altra via. Quanto al
Nostro, forse superiore agli altri nello slancio
di quest’atteggiamento superumano, anche
sorpassato quel limite approssimativo della
grande produzione, lavorava ancora sul suo,
ogni nuovo libro era un correggere e un limare
la sua produzione primitiva, dalla quale non
non era mai uscito.
Ma non basta, per rendere completa l'im
magine del Poeta, osservare quello che egli
stesso può aver preso, o quanto può aver
dato al mondo. Sarebbe pure bello vedere
con paziente attenzione, quello che nel mo
mento della nascita del fenomeno artistico, si
riattacca al mondo culturale che spesso ne è
l'origine.
Si sa che fin dal tempo del collegio egli era
curiosissimo di vocaboli ed espressioni nuove,
tendeva alla conquista della lingua, per poter
farla diventare linguaggio, come un armigero
accresce e coltiva la sua collezione d armi. E
quanto più erano preziose le scoperte, di tanto
maggior giubilo si accendeva, come se lo
strumento acquistato gli potesse offrire un
maggior spiegamento di volo. E così i parti
colari linguistici e culturali (si pensi alla sua
conoscenza di cose eruditissime e rare del
l’alto medio evo), andavano fondendosi in
un'unica conquista, che tendeva a fare di lui.
accesissimo cultore di cose belle, l'unico depo
sitario in Europa di difficili ricchezze. Il fe
nomeno, che potrebbe richiedere analisi oscure
e poco facili, si chiarifica nell’atto della sintesi,
quando si sfrondi il complesso di certi aggeggi
che paiono concresciuti, mentre sono soltanto
apposti.
Ma io lascio da parte, per ora. argomenti che
potrebbero esser di vivissimo interesse in
questo nostro cercar di vedere tutta intera
la figura del Poeta, al di fuori delle distinzioni
dei generi, per cui non vorrei che si parlasse,
altro che per comodità didascalica, di D ’An
nunzio romanziere, o poeta, o scrittore di
teatro. E neppure parlerò di quei lati a cui
prima accennavo, come sarebbe, ad esempio,
Pesame del D'Annunzio compiuto dai critici;
o il suo atteggiamento di fronte ai libri o
quello che potrebbe chiamarsi la meccanica
del verbo; o ancora certo delicato psicologismo
che si potrebbe scoprire in una felice confu
sione tra la vita pratica e quella artistica del
Poeta.
Ma per finire in breve il nostro piccolo as
sunto, riprendiamo il sunto degli sviluppi.
Quando gli elementi che diremo abruzzesi, o
italici, fusi con quelli di Roma, e poi con quelli
che per tutta Europa, e particolarmente in
Francia, erano l'indice del modo di sentire del
secolo, giunsero tutti insieme ad un'amalgama
compiuta, sempre nell’àmbito del suo parti
colare modo d'arte, egli seppe darci cose che
indubbiamente non si erano mai viste, per le
quali seguaci e nemici cercarono aggettivi
proporzionati all'argomento. E senza dubbio
valeva la pena di quel gran movimento e
turbamento che fece nascere.
Se in seguito egli stesso provvide, come
prima dicevo, a far storia della propria cro
naca. non glie ne dobbiamo lar colpa. Era
naturale conseguenza di un atteggiamento che
aveva bisogno di ogni contributo per assu
mere forma stabile. Egli è di quei pochi che
abbiano loro stessi concluso quello che avevano
iniziato. Ha fornito ai critici, agli studiosi,
agli artisti, materiale immenso: contributo alla
storia dell'arte e della civiltà. Moltissimo an
cora rimarrà da dire, in ogni tempo, intorno
alla sua opera in particolare, a mano a mano
che i segni della sua creazione, usciti dall'in
teresse immediato, si fonderanno in un assieme
che si collega con altri movimenti in Italia e
all’estero, o con la loro propria origine: ché
la sua non è vita che si dimentichi, come una
delle più rappresentative e coraggiose in tutti
i sensi. Pochi autori nostri sono noti all'estero
quanto D ’Annunzio.
E poi. visto il lato, diremo così, esterno o
storico della questione, rimarrà ancor sempre
da vedersi il Poeta come uomo d'arte, lo
scopo a cui consacrò la vita e per il quale pure
molto sofferse. Non è cosa da nulla o poco
faticosa il rimanere sempre in primo piano
anche di fronte a se stessi. Ripenseremo al suo
travaglio, alle sue notti insonni, alle sue ri
cerche di cose belle, al suo tentativo di ricreare
un mondo nuovo, astratto, diverso da quello
di tutti noi; un mondo forse assurdo, ma bello,
grande, degno dei semidei e degli eroi di vi-
chiana memoria.
Ma forse in questo ci fu il mancamento.
Nel primitivo spogliarsi per ritrovare il senso
delle cose prime, e nel successivo arricchirsi
per condurle all’altezza del mito, può stare
la nascita di una tragedia: nel momento in
cui queste cose, ricreate, possono pure per
dere la vita ed essere forme statiche. Se uno,
per amore di paradossi, pensasse che tutte le
sofferenze di Francesco d’Assisi, quel suo mar
toriarsi, quel repentino spogliarsi d'ogni cosa,
lo portarono al godimento sommo del Cantico
delle Creature, per cui sapeva di possederle
tutte: nel caso di D ’Annunzio potrebbe pen
sare che se non minore fu il travaglio della
ricerca dell'essenziale, minore certo fu la gioia
del produrre, che dà quel senso, che talvolta
si sente, della cima non raggiunta. E questo
è il luogo della tragedia.
MNO BAVA


















