
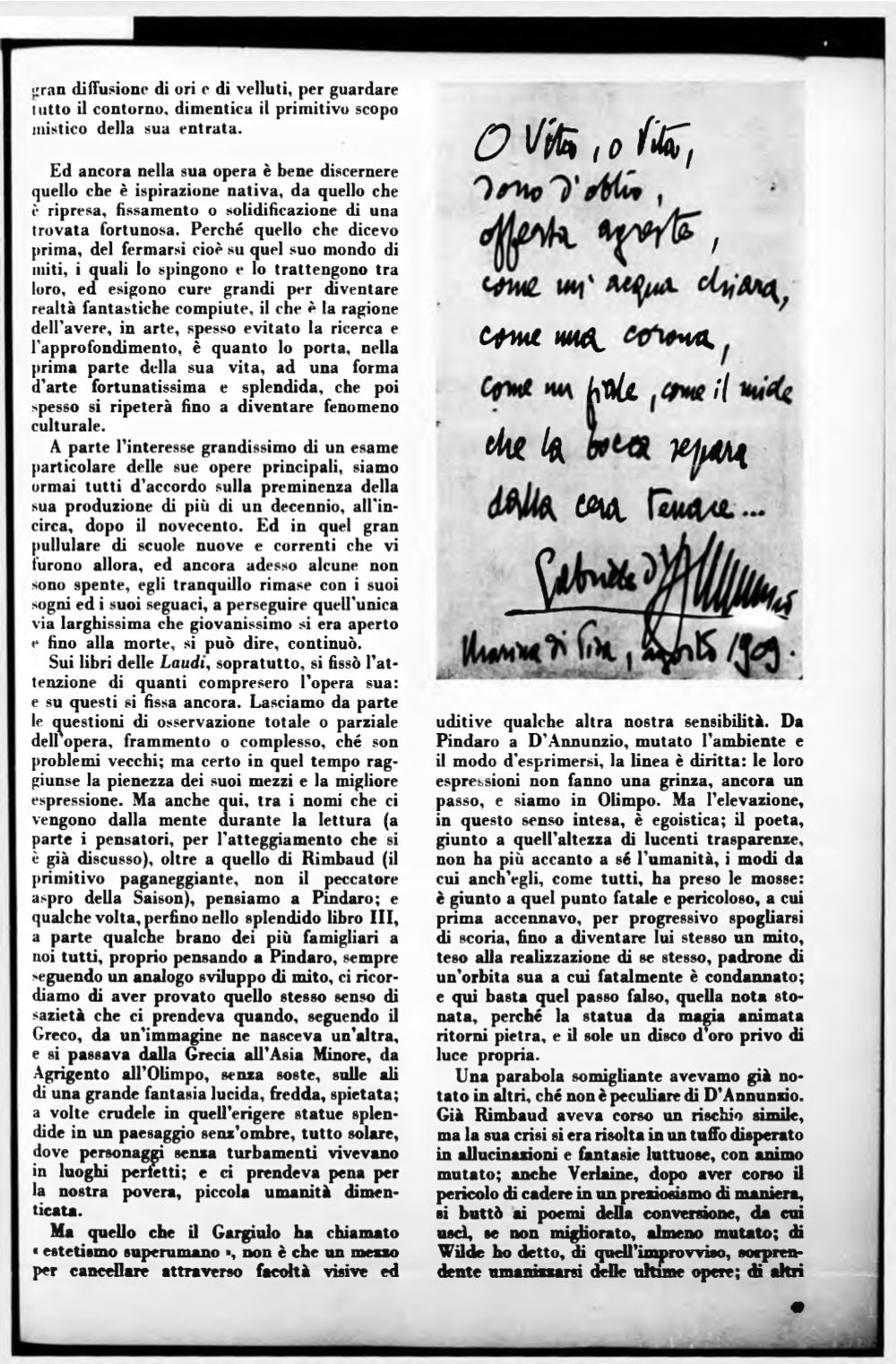
•rran diffusione di ori c di velluti, per guardare
lutto il contorno, dimentica il primitivo scopo
mistico della sua entrata.
Ed ancora nella sua opera è bene discernere
quello che è ispirazione nativa, da quello che
è
ripresa, fissamento o solidificazione di una
trovata fortunosa. Perché quello che dicevo
prima, del fermarsi cioè su quel suo mondo di
miti, i quali lo spingono e lo trattengono tra
loro, ed esigono cure grandi per diventare
realtà fantastiche compiute, il che è la ragione
dell’avere, in arte, spesso evitato la ricerca e
l’approfondimento, è quanto lo porta, nella
prima parte della sua vita, ad una forma
d’arte fortunatissima e splendida, che poi
spesso si ripeterà fìno a diventare fenomeno
culturale.
A parte l’interesse grandissimo di un esame
particolare delle sue opere principali, siamo
ormai tutti d’accordo sulla preminenza della
sua produzione di più di un decennio, all'in-
circa, dopo il novecento. Ed in quel gran
pullulare di scuole nuove e correnti che vi
furono allora, ed ancora adesso alcune non
sono spente, egli tranquillo rimase con i suoi
sogni ed i suoi seguaci, a perseguire quell'unica
via larghissima che giovanissimo si era aperto
e fino alla morte, si può dire, continuò.
Sui libri delle Laudi, sopratutto, si fissò l’at-
tenzione di quanti compresero l’opera sua:
e su questi si fìssa ancora. Lasciamo da parte
le questioni di osservazione totale o parziale
dell opera, frammento o complesso, ché son
problemi vecchi; ma certo in quel tempo rag
giunse la pienezza dei suoi mezzi e la migliore
espressione. Ma anche qui, tra i nomi che ci
vengono dalla mente durante la lettura (a
parte i pensatori, per l’atteggiamento che si
è
già discusso), oltre a quello di Rimbaud (il
primitivo paganeggiante, non il peccatore
aspro della Saison), pensiamo a Pindaro; e
qualche volta, perfino nello splendido libro
III,
a parte qualche brano dei più famigliali a
noi tutti, proprio pensando a Pindaro, sempre
seguendo un analogo sviluppo di mito, ci ricor*
diamo di aver provato quello stesso senso di
sazietà che ci prendeva quando, seguendo il
Greco, da un’immagine ne nasceva un’altra,
e si passava dalla Grecia all’Asia Minore, da
Agrigento all’Olimpo, senza soste, sulle ali
di una grande fantasia lucida, fredda, spietata;
a volte crudele in quell’erigere statue splen
dide in un paesaggio senz’ombre, tutto solare,
dove personaggi senza turbamenti vivevano
in luoghi perfetti; e ci prendeva pena per
la nostra povera, piccola umanità dimen
ticata.
Ma quello che il Gargiulo ha chiamato
«estetismo superumano », non è che un messo
per cancellare attraverso facoltà visive ed
o
i/fc
i o
/ir,
j
t f M L W ó L
H / t l
h v U
l i
r i i * k
M 4 / H
t M ,
j
uditive qualche altra nostra sensibilità. Da
Pindaro a D ’Annunzio, mutato l’ambiente e
il modo d’esprimersi, la linea è diritta: le loro
espressioni non fanno una grinza, ancora un
passo, e siamo in Olimpo. Ma l’elevazione,
in questo senso intesa, è egoistica; il poeta,
giunto a quell’altezza di lucenti trasparenze,
non ha più accanto a sé l’umanità, i modi da
cui anch’egli, come tutti, ha preso le mosse:
è giunto a quel punto fatale e pericoloso, a cui
prima accennavo, per progressivo spogliarsi
di scoria, fino a diventare lui stesso un mito,
teso alla realizzazione di se stesso, padrone di
un’orbita sua a cui fatalmente è condannato;
e qui basta quel passo falso, quella nota sto
nata, perché la statua da magia animata
ritorni pietra, e il sole un disco d’oro privo di
luce propria.
Una parabola somigliante avevamo già no
tato in altri, ché nonèpeculiare di D’Annunzio.
Già Rimbaud aveva corso
un
rischio simile,
ma la sua crisi si era risolta in
un
tuffo disperato
in allucinazioni e fantasie luttuose, con animo
mutato; anche Verlaine, dopo aver corso il
perìcolo di cadere in un presiosismo di maniera,
si buttò ai poemi della conversione, da cui
uscì, se non migliorato, almeno mutato; di
Wilde ho detto, di quell'improvviso, sorpren
dente umanizzarsi delle ultime opere; di altri
«


















