
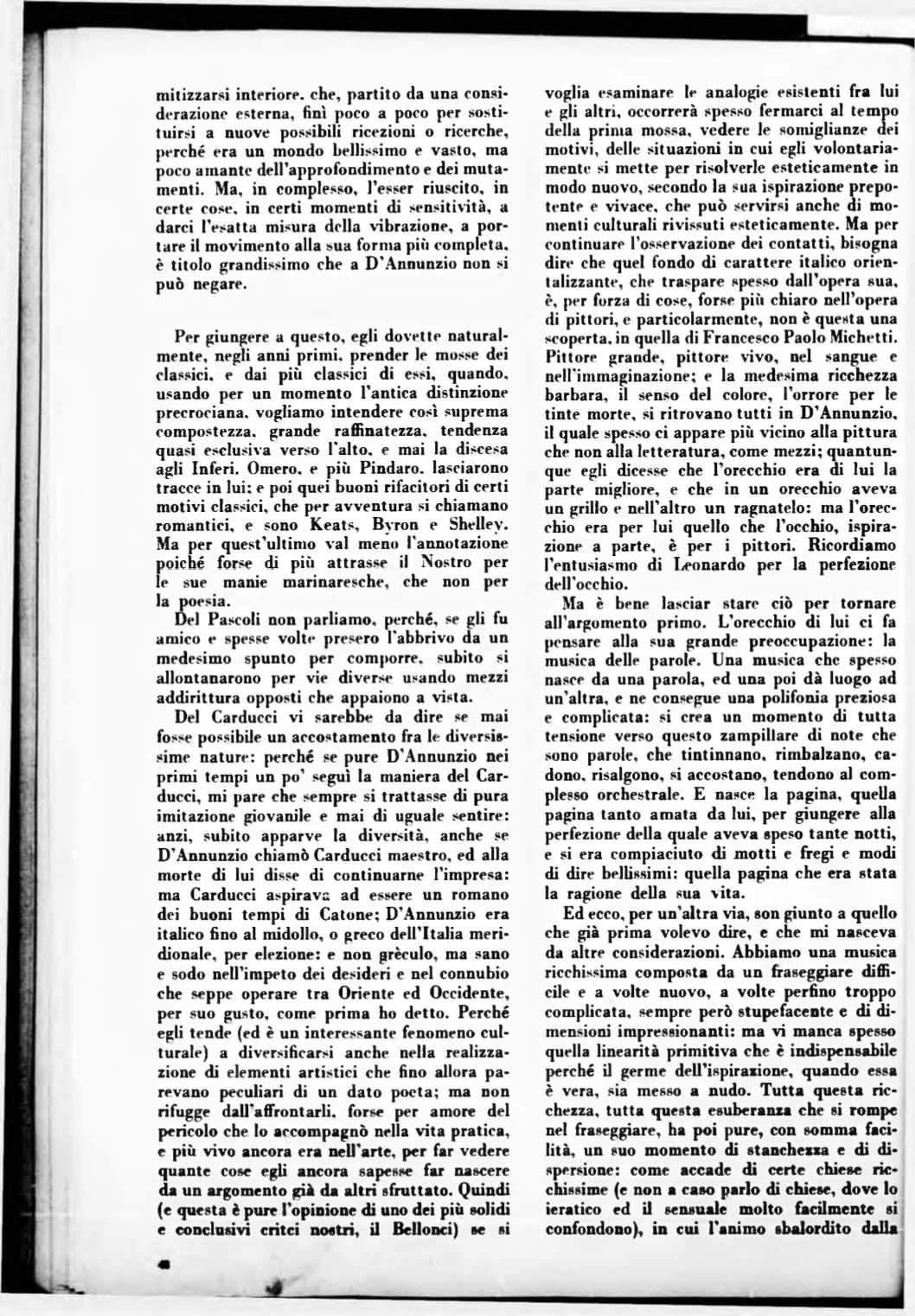
mitizzarsi interiore, che, partito da una consi
derazione esterna, finì poco a poco per sosti
tuirsi a nuove possibili ricezioni o ricerche,
perché era un mondo bellissimo e vasto, ma
poco amante delFapprofondimento e dei muta
menti. Ma, in complesso, Tesser riuscito, in
certe cose, in certi momenti di sensitività, a
darci l’esatta misura della vibrazione, a por
tare il movimento alla sua forma più completa,
è titolo grandissimo che a D'Annunzio non si
può negare.
Per giungere a questo, egli dovette natural
mente, negli anni primi, prender le mosse dei
classici, e dai più classici di essi, quando,
usando per un momento l'antica distinzione
precrociana, vogliamo intendere così suprema
compostezza, grande raffinatezza, tendenza
quasi esclusiva verso l'alto, e mai la discesa
agli Inferi. Omero, e più Pindaro. lasciarono
tracce in lui: e poi quei buoni rifacitori di certi
motivi classici, che per avventura si chiamano
romantici, e sono Keats, Byron e Shelley.
Ma per quest'ultimo vai meno l'annotazione
poiché forse di più attrasse il Nostro per
le sue manie marinaresche, che non per
la poesia.
Del Pascoli non parliamo, perché, se gli fu
amico e spesse volte presero l'abbrivo da un
medesimo spunto per comporre, subito si
allontanarono per vie diverse usando mezzi
addirittura opposti che appaiono a vista.
Del Carducci vi sarebbe da dire se mai
fosse possibile un accostamento fra le diversis
sime nature: perché se pure D'Annunzio nei
primi tempi un po' seguì la maniera del Car
ducci, mi pare che sempre si trattasse di pura
imitazione giovanile e mai di uguale sentire:
anzi, subito apparve la diversità, anche se
D'Annunzio chiamò Carducci maestro, ed alla
morte di lui disse di continuarne l’impresa:
ma Carducci aspirava ad essere un romano
dei buoni tempi di Catone; D’Annunzio era
italico fino al midollo, o greco dell’Italia meri
dionale, per elezione: e non grèculo, ma sano
e sodo nell’impeto dei desideri e nel connubio
che seppe operare tra Oriente ed Occidente,
per suo gusto, come prima ho detto. Perché
egli tende (ed è un interessante fenomeno cul
turale) a diversificarsi anche nella realizza
zione di elementi artistici che fino allora pa
revano peculiari di un dato poeta; ma non
rifugge dall'affrontarli. forse per amore del
pericolo che lo accompagnò nella vita pratica,
e più vivo
ancora
era nell'arte, per far vedere
quante cose egli ancora sapesse
far
nascere
da un argomento già da altri sfruttato. Quindi
(e questa è pure l'opinione di uno dei più solidi
e conclusivi critci nostri, il Bellonci) se si
voglia esaminare le analogie esistenti fra lui
e gli altri, occorrerà spesso fermarci al tempo
della prima mossa, vedere le somiglianze dei
motivi, delle situazioni in cui egli volontaria
mente si mette per risolverle esteticamente in
modo nuovo, secondo la sua ispirazione prepo
tente e vivace, che può servirsi anche di mo
menti culturali rivissuti esteticamente. Ma per
continuare l’osservazione dei contatti, bisogna
dire che quel fondo di carattere italico orien
talizzante, che traspare spesso dall’opera sua,
è, per forza di cose, forse più chiaro nell’opera
di pittori, e particolarmente, non è questa una
scoperta, in quella di Francesco Paolo Michetti.
Pittore grande, pittore vivo, nel sangue e
neirimmaginazione; e la medesima ricchezza
barbara, il senso del colore, l’orrore per le
tinte morte, si ritrovano tutti in D'Annunzio,
il quale spesso ci appare più vicino alla pittura
che non alla letteratura, come mezzi; quantun
que egli dicesse che l’orecchio era di lui la
parte migliore, e che in un orecchio aveva
un grillo e nell’altro un ragnatelo: ma l’orec
chio era per lui quello che l’occhio, ispira
zione a parte, è per i pittori. Ricordiamo
l’entusiasmo di Leonardo per la perfezione
dell'occhio.
Ma è bene lasciar stare ciò per tornare
all’argomento primo. L’orecchio di lui ci fa
pensare alla sua grande preoccupazione: la
musica delle parole. Una musica che spesso
nasce da una parola, ed una poi dà luogo ad
un’altra, e ne consegue una polifonia preziosa
e complicata: si crea un momento di tutta
tensione verso questo zampillare di note che
sono parole, che tintinnano, rimbalzano, ca
dono. risalgono, si accostano, tendono al com
plesso orchestrale. E nasce la pagina, quella
pagina tanto amata da lui, per giungere alla
perfezione della quale aveva speso tante notti,
e si era compiaciuto di motti e fregi e modi
di dire belUssimi: quella pagina che era stata
la ragione della sua vita.
Ed ecco, per un’altra via, son giunto a quello
che già prima volevo dire, e che mi nasceva
da altre considerazioni. Abbiamo una musica
ricchissima composta da un fraseggiare diffi
cile e a volte nuovo, a volte perfino troppo
complicata, sempre però stupefacente e di di
mensioni impressionanti: ma vi manca spesso
quella linearità primitiva che è indispensabile
perché il germe dell’ispirazione, quando essa
è vera, sia messo a nudo. Tutta questa ric
chezza, tutta questa esuberanza che si rompe
nel fraseggiare, ha poi pure, con somma faci*
lità, un suo momento di stanchezza e di di
spersione: come accade di certe chiese ric
chissime (e non a caso parlo di chiese, dove lo
ieratico ed il sensuale molto facilmente si
confondono), in cui l'animo sbalordito dalla


















