
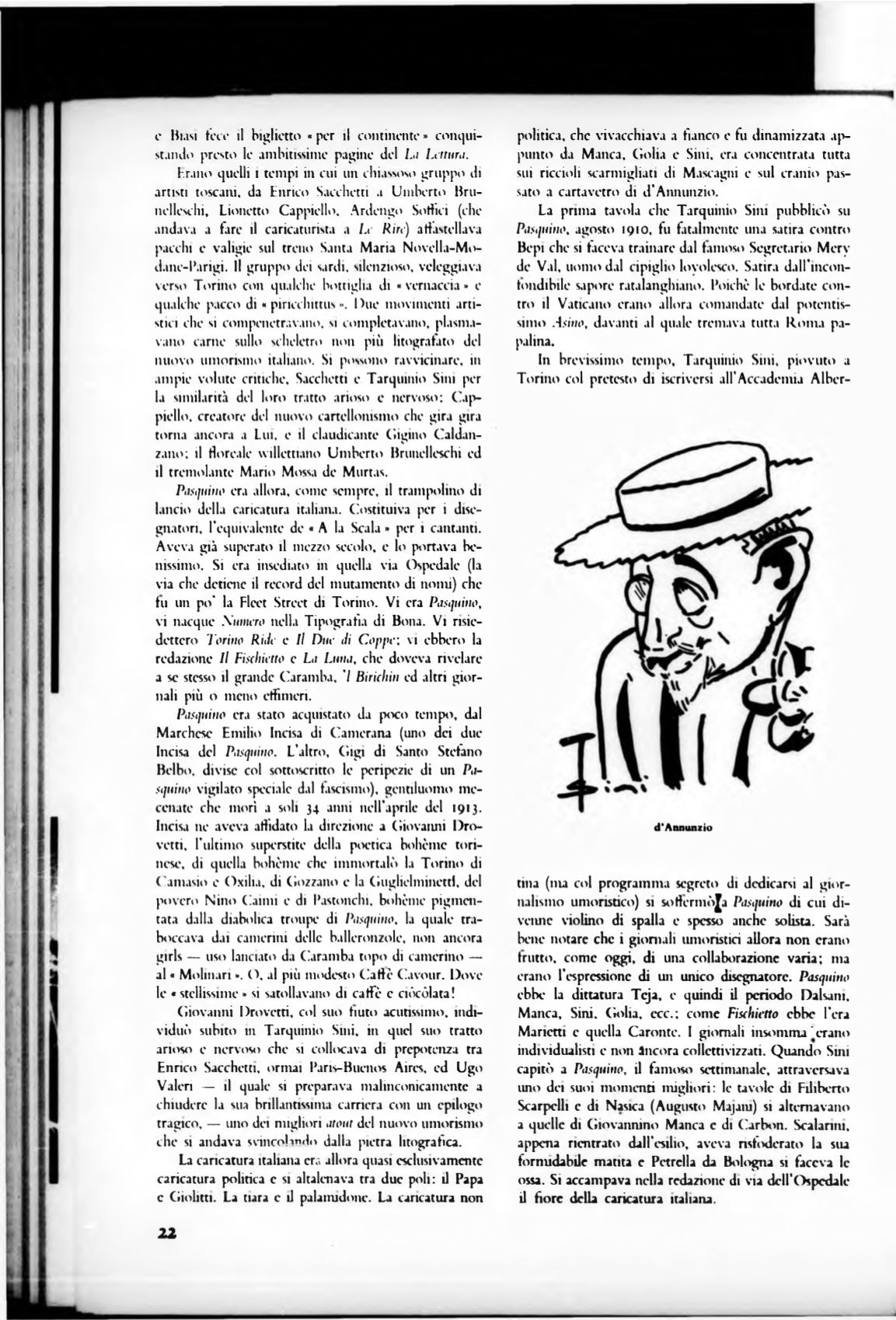
e Biasi feci' il biglietto « per il continente » conqui
stando presto le ambitissime pagine del
L i Lettura.
Erano quelli 1 tempi in cui un chiassoso gruppo di
artisti toscani, da Enrico Sacchetti a Umberti» Bru-
nelleschi, Lionetto Cappiello, Ardengo Sortici (che
andava a fare tl caricaturista a
Ix Rirc)
affastellava
pacchi e valigie sul treno Santa Maria Novell.i-Mi>-
dane-l’arigi. Il gruppo dei sardi, silenziosi», veleggiava
verso Torino con qualche bottiglia di «vernaccia» e
qualche pacco di « piricchittus ». Due movimenti arti
stici che si compcnctravano, si completavano, plasma
vano carne sullo scheletro non più litografato del
nuovo umorismo italiano. Si possono ravvicinare, in
ampie volute critiche. Sacchetti e Tarquinio Siili per
la similarità del loro tratto arioso e nervoso: Cup-
picllo, creatore del nuovo cartcllonismo che gira gira
torna ancora a Lui. e il claudicante Gigino Caldan-
zano: il floreale willettiano Umberto Brunclleschi ed
il tremolante Mario Mossa de Murtas.
Pasquino
era allora, come sempre, il trampolino di
lancio della caricatura italiana. Costituiva per i dise
gnatori, l'equivalente de « A la Scala » per i cantanti.
Aveva già superato il mezzo secolo, e li» portava be
nissimo. Si era insediato in quella via Ospedale (la
via che detiene il record del mutamento di nomi) che
tu un po' la Fleet Street di Torino. Vi era
Pasquino,
vi nacque
Sumero
nella Tipografia di Bona. Vi risie
dettero
Torino Ridi
e
II Due di Coppe:
vi ebbero la
redazione
II Fischietto
c
L i Luna,
che doveva rivelare
a se stesso il grande Caramba, ’/
Birichin
ed altri gior
nali più o meno effimeri.
Pasquino
era stato acquistato da poco tempi», dal
Marchese Emilio Incisa di Camcrana (uno dei due
Incisa del
Pasquino.
L’altro, Gigi di Santo Stefano
Belbo. divise col sottoscritto le peripezie di un
Pa
squino
vigilato speciale dal fascismo), gentiluomo me
cenate che morì a soli 34 anni nell'aprile del 1913.
Incisa ne aveva affidato la direzione a Giovanni Dro-
vetti, l’ ultimo superstite della poetica bohème tori
nese. di quella bohème che immortalò la Torino di
Caniasio e Oxilia, di Gozzano e la Gugliclminetri, del
povero Nino Caitni e di Pastonchi, bohème pigmcti-
tata dalla diabolica troupe di
Pasquino,
la quale tra
boccava dai camerini delle balleronzole, non ancora
girls — usi» lanciato da Caramba topo di camerino —
al « Molmari ». O, al più
modesto
Caffè Cavour. Dove
le « stelhssime » si satollavano di caffè c ciòcólata!
Giovanni Drovctti, col suo fiuti» acutissimo, indi
viduò subito 111 Tarquinio Siili, in quel suo tratto
arioso e nervoso che si collocava di prepotenza tra
Enrico Sacchetti, ormai Paris-Bucnos Aires, ed Ugo
Valeri — il quale si preparava malinconicamente a
chiudere la sua brillantissima carriera con un epilogo
tragico, — uno dei migliori
atout
del nuovo umorismi»
che si andava svincolando dalla pietra litografica.
La caricatura italiana era allora quasi esclusivamente
caricatura politica e si altalenava tra due poh: il Papa
e Giolito. La tiara e il palamidone. La caricatura non
politica, che vivacchiava a fianco e fu dinamizzata ap
punto da Manca, Golia e Siili, era concentrata tutta
sui riccioli scarmigliati di Mascagni e sul cranio pas
sato a cartavetro di d ’ Annunzio.
La prima tavola che Tarquinio Siili pubblicò su
Pasquino,
agosto 1910, fu fatalmente una satira contri»
Bepi che si faceva trainare dal famoso Segretario Mery
de Val, uomo dal cipiglio loyolesco. Satira dall'incon
fondibile sapore ratalanghiuno. Poiché le bordate con
tro il Vaticano erano allora comandate dal potentis
simo
Asino,
davanti al quale tremava tutta Roma pa
palina.
In brevissimo tempo, Tarquinio Siili, piovuto a
Torino col pretesto di iscriversi all’ Accademia Alber
ti'Annunzio
tina (ma col programma segreto di dedicarsi al gior
nalismo umoristico) si sotìcrmòju
Pasquino
di cui di-
venne violino di spalla e spesso anche solista. Sarà
bene notare che i giornali umoristici allora non erano
frutti», come oggi, di una collaborazione varia; ma
erano l’espressione di un unico disegnatore.
Pasquino
ebbe la dittatura Tcja, e quindi il periodo Dalsam,
Manca, Sini, Golia, ecc.; come
Fischietto
ebbe l’era
Marietti c quella Caronte. I giornali insomma
'
erano
individualisti e non Incora collettivizzati. Quando Smi
capitò a
Pasquino,
il famoso settimanale, attraversava
uno dei suoi momenti migliori: le tavole di Filiberto
Scarpelli e di Nasica (Augusto Majaiu) si alternavano
a quelle di Giovannino Manca e di Carbon. Scalarmi,
appena rientrato dall’esilio, aveva risfodcrato la sua
fornudabile matita e Petrclla da Bologna si faceva le
ossa. Si accampava nella redazione di via deU’Ospcdale
U fiore della caricatura italiana.
22


















