
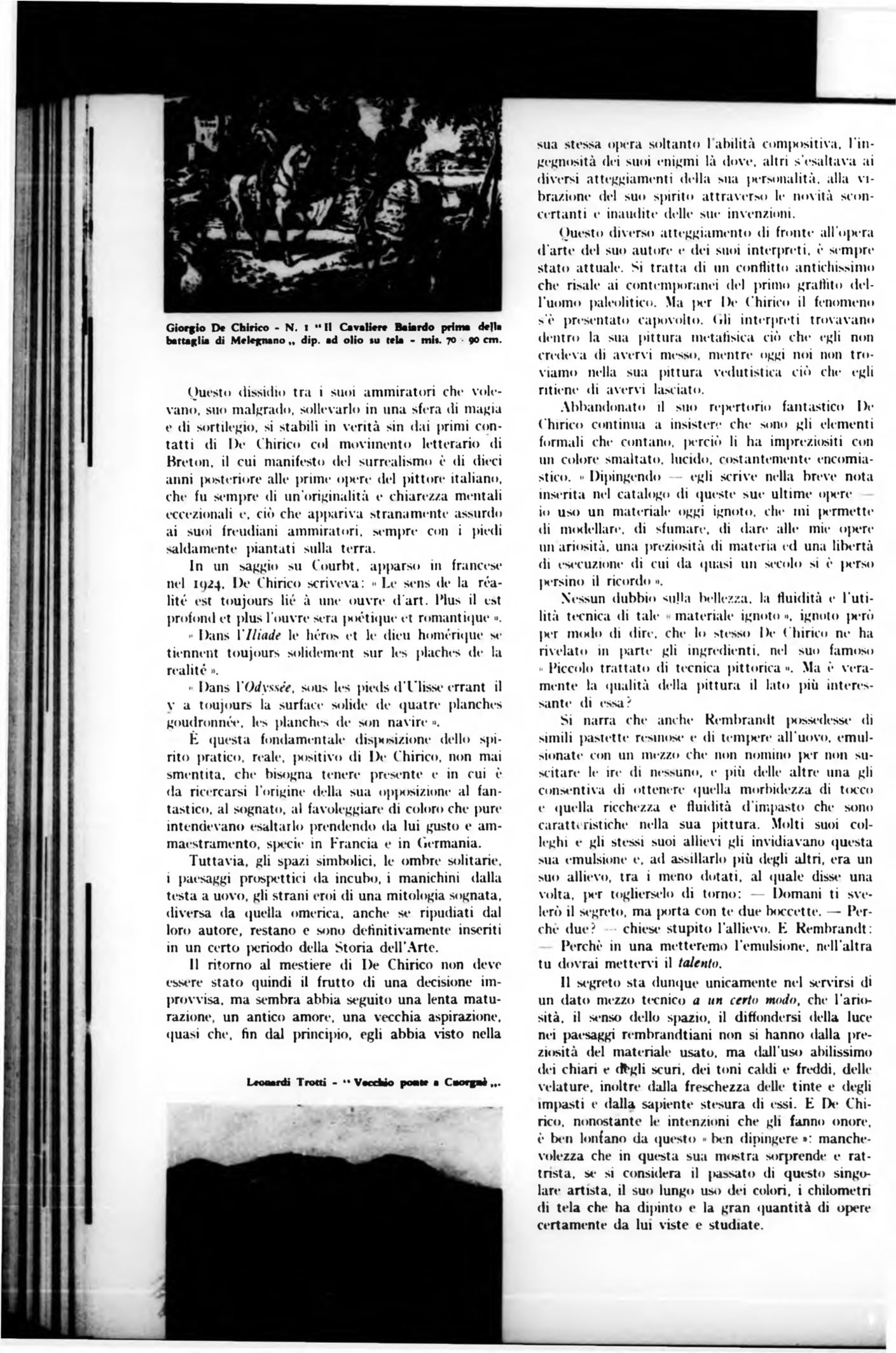
Giorgio De Chirico - N.
1
“ Il Cavaliere Baiardo prima della
battaglia di Melegnano „ dip. ad olio tu tela - mis.
70
-
90
cm.
Questi» dissidio tra i suoi ammiratori chr volo-
vano, suo malgrado, sollevarlo in una sfera di magia
0 di sortilegio, si stabilì in verità sin dai primi con
tatti di De Chirico col movimento letterario di
Breton, il cui manifesto del surrealismo è di dieci
anni posteriore alle prime ojx-re del pittore italiano,
che fu sempre ili un'originalità e chiarezza mentali
eccezionali e, ciò che appariva stranamente assurdo
ai suoi freudiani ammiratori, sempre con i piedi
saldamente piantati sulla terra.
In un saggio su Courbt, apparso in francese
nel 11)24. De Chirico scriveva: « Le sens de la réa-
lité est toujours lié à ime ouvre d 'art. l’ius il est
profonil et plus l’ouvre sera j»oótique et romantique ».
" Dans
Ylliade
le héros et le dieu homériiiue se
tiennent toujours solidement sur les plaches de la
realité ».
<■Dans
YOdyssée,
sous les pieds d ’I ’ lisse errant il
v a toujours la surface solide de quatre planches
goudronnée, les planches de son navire ».
È questa fondamentale disjxtsizione dello spi
rito pratico, reale, jxisitivo di De Chirico, non mai
smentita, che bisogna tenere presente e in cui è
ila ricercarsi l'origine della sua opjxjsizione al fan
tastico, al sognato, al favoleggiare di coloro che pure
intendevano esaltarlo prendendo da lui gusto e am
maestramento, sjx^cie in Francia e in Germania.
Tuttavia, gli spazi simbolici, le ombre solitarie,
1 paesaggi prospettici da incubo, i manichini dalla
testa a uovo, gli strani eroi di una mitologia sognata,
diversa da quella omerica, anche se ripudiati dal
loro autore, restano e sono definitivamente inseriti
in un certo periodo della Storia dell’Arte.
Il ritorno al mestiere di De Chirico non deve
essere stato quindi il frutto di una decisione im
provvisa. ma sembra abbia seguito una lenta matu
razione, un antico amore, una vecchia aspirazione,
quasi che, fin dal principio, egli abbia visto nella
Leonardi Trotti - “ Vecchio ponte a C a o r p i„ .
sua stessa opera soltanto l abilità compositiva, l'in
gegnosità ilei suoi enigmi là dove, altri s'esaltava ai
diversi atteggiamenti della sua personalità, alla v i
brazione del suo spirito attraverso le novità scon
certanti e inaudite delle sue invenzioni.
Questo diverso atteggiamento di fronte all'opera
d'arte del suo autore e dei suoi interpreti, è sempre
stato attuale. Si tratta di un conflitto antichissimo
che risale ai contemporanei ilei primo graffito del
l'uomo paleolitico. Ma |>er De Chirico il fenomeno
s ’è presentato capovolto, (ili interpreti trovavano
dentro la sua pittura metafisica ciò che egli non
credeva di avervi messo, mentre oggi noi non tro
viamo nella sua pittura vedutistica ciò che egli
ritiene di avervi lasciato.
Abbandonato il suo repertorio fantastico De
Chirico continua a insistere che sono ^li elementi
formali che contano, perciò li ha impreziositi con
1111 colore smaltato, lucido, costantemente encomia
stico. » Dipingendo — egli scrive nella breve nota
inserita nel catalogo di queste sue ultime opere
io uso un materiale oggi ignoto, che mi permette
di modellare, di sfumare, di dare alle mie opere
1111 ariosità, una preziosità di materia ed una libertà
di esecuzione di cui da quasi 1111 secolo si è |x*rso
jxTsino il ricordo ».
Nessun dubbio sulla bellezza, la fluidità e l'uti
lità tecnica di tale materiale ignoto ». ignoto jx-rò
j»er minio di dire, che lo stesso De Chirico ne ha
rivelato in parte gli ingredienti, nel suo famoso
" Piccolo trattato di tecnica pittorica ». Ma è vera
mente la qualità della pittura il lato più interes
sante di essa?
Si narra che anche Kembrandt |x»sseilesse di
simili pastette resinose e di tenqxTe all'uovo, emul
sionate con un mezzo che non nomino per non su
scitare le ire di nessuno, e più delle altre una j^li
consentiva di ottenere quella morbidezza di ti»cco
e quella ricchezza e fluidità d'impasto che sono
caratteristiche nella sua pittura. Molti suoi col
leglli e gli stessi suoi allievi gli invidiavano questa
sua emulsione e. ad assillarlo più degli altri, era un
suo allievo, tra i meno dotati, al quale disse una
volta, per toglierselo di torno: — Domani ti sve
lerò il segreto, ma porta con te due bixxette. — Per
chè due? — chiese stupito l'allievo. K Kembrandt:
Perchè in una metteremo l'emulsione, nell'altra
tu dovrai mettervi il
talento.
11 segreto sta dunque unicamente nel servirsi di
un dato mezzo ti-cnico
a un certa modo,
che l ’arii»-
sità. il senso dello spazio, il diffondersi della luce
nei paesaggi rembrandtiani non si hanno dalla pre-
ziosità del materiale usato, ma dall’uso abilissimo
dei chiari e ifrgli scuri, dei toni caldi e freddi, dello
velature, inoltre dalla freschezza delle tinte e degli
impasti e dalla sapiente stesura di essi. E De Chi
rico. nonostante le intenzioni che gli fanno onore,
è ben lontano da questo
>•
ben dipingere »: manche
volezza che in questa sua mi»stra sorprende e rat
trista. se si considera il passato di questo singo
lari* artista, il suo lungo uso dei colori, i chilometri
di tela che ha dipinto e la gran quantità di opere
certamente da lui viste e studiate.


















