
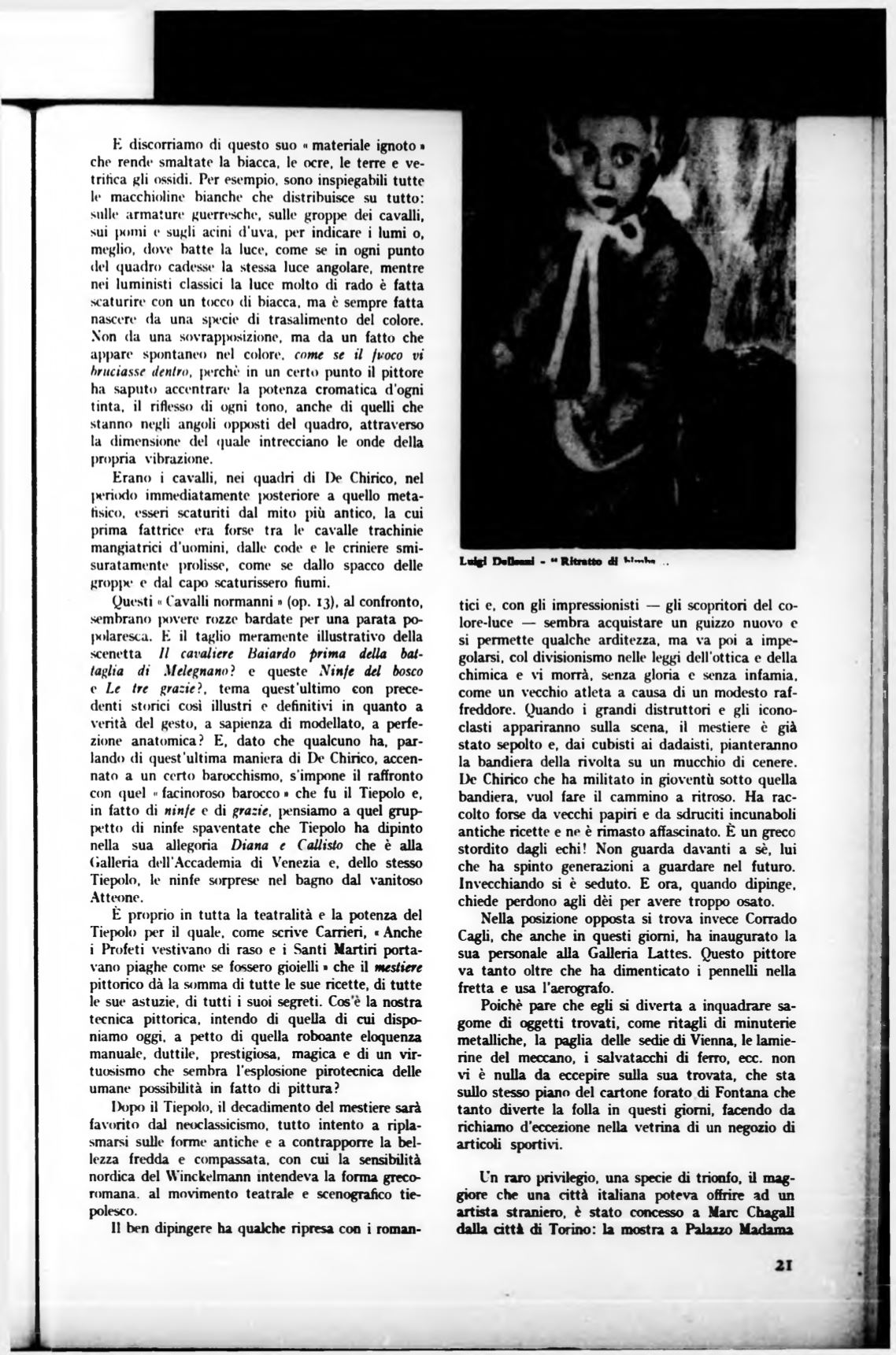
K discorriamo di questo suo « materiale ignoto »
che rende smaltate la biacca, le ocre, le terre e ve
trifica gli ossidi. Per esempio, sono inspiegabili tutte
le macchioline bianche che distribuisce su tutto:
sulle armature guerresche, sulle gropjx* dei cavalli,
sui pomi e sugli acini d ’uva, per indicare i lumi o,
meglio, dove batte la luce, come se in ogni punto
del quadro cadesse la stessa luce angolare, mentre
nei luministi classici la luce molto di rado è fatta
scaturire con un tocco di biacca, ma è sempre fatta
nascere da una specie di trasalimento del colore.
Non da una sovrapposizione, ma da un fatto che
appare spontaneo nel colore,
come se il fuoco vi
bruciasse dentro,
perchè in un certo punto il pittore
ha saputo accentrare la potenza cromatica d ’ogni
tinta, il riflesso di ogni tono, anche di quelli che
stanno negli angoli opposti del quadro, attraverso
la dimensione del quale intrecciano le onde della
propria vibrazione.
Erano i cavalli, nei quadri di I)e Chirico, nel
|>eriodo immediatamente j>osteriore a quello meta
fisico, esseri scaturiti dal mito più antico, la cui
prima fattrice era forse tra le cavalle trachinie
mangiatrici d ’uomini, dalle code e le criniere smi
suratamente prolisse, come se dallo spacco delle
gropjx" e dal capo scaturissero fiumi.
Questi «Cavalli normanni » (op. 13), al confronto,
sembrano povere rozze bardate per una parata po-
jx>laresca. E il taglio meramente illustrativo della
scenetta
11 cavaliere Baiardo prima della bat
taglia di Mdegnano!
e queste
Ninfe del bosco
e
Le tre grazie
?, tema quest’ultimo con prece
denti storici così illustri e definitivi in quanto a
verità del gesto, a sapienza di modellato, a perfe
zione anatomica? E, dato che qualcuno ha, par
lando di quest ‘ultima maniera di De Chirico, accen
nato a un certo barocchismo, s ’impone il raffronto
con quel « facinoroso barocco » che fu il Tiepolo e,
in fatto di
ninfe
e di
grazie,
pensiamo a quel grup
petto di ninfe spaventate che Tiepolo ha dipinto
nella sua allegoria
Diana e Callisto
che è alla
Galleria dell'Accademia di Venezia e, dello stesso
Tiepolo, le ninfe sorprese nel bagno dal vanitoso
Atteone.
È proprio in tutta la teatralità e la potenza del
Tiepolo per il quale, come scrive Carrieri, «Anche
i Profeti vestivano di raso e i Santi Martiri porta
vano piaghe come se fossero gioielli * che il
mestiere
pittorico dà la somma di tutte le sue ricette, di tutte
le sue astuzie, di tutti i suoi segreti. Cos e la nostra
tecnica pittorica, intendo di quella di cui dispo
niamo oggi, a petto di quella roboante eloquenza
manuale, duttile, prestigiosa, magica e di un vir
tuosismo che sembra l’esplosione pirotecnica delle
umane possibilità in fatto di pittura?
Dopo il Tiepolo, il decadimento del mestiere sarà
favorito dal neoclassicismo, tutto intento a ripla
smarsi sulle forme antiche e a contrapporre la bel
lezza fredda e compassata, con cui la sensibilità
nordica del Winckelmann intendeva la forma greco-
romana, al movimento teatrale e scenografico tie-
polesco.
11 ben dipingere ha qualche ripresa con i roman
Un raro privilegio, una specie di trionfo, il mag
giore che una città italiana poteva offrire ad un
artista straniero, è stato concesso a Marc Chagall
dalla città di Torino: la mostra a Palazzo Madama
Luigi DeDoni ■“ Ritratto di *•>-*"<...
tici e, con gli impressionisti — gli scopritori del co
lore-luce — sembra acquistare un guizzo nuovo c
si permette qualche arditezza, ma va poi a impe
golarsi, col divisionismo nelle leggi dell’ottica e della
chimica e vi morrà, senza gloria e senza infamia,
come un vecchio atleta a causa di un modesto raf
freddore. Quando i grandi distruttori e gli icono
clasti appariranno sulla scena, il mestiere è già
stato sepolto e, dai cubisti ai dadaisti, pianteranno
la bandiera della rivolta su un mucchio di cenere.
De Chirico che ha militato in gioventù sotto quella
bandiera, vuol fare il cammino a ritroso. Ha rac
colto forse da vecchi papiri e da sdruciti incunaboli
antiche ricette e ne è rimasto affascinato. È un greco
stordito dagli echi! Non guarda davanti a sé, lui
che ha spinto generazioni a guardare nel futuro.
Invecchiando si è seduto. E ora, quando dipinge,
chiede perdono agli dèi per avere troppo osato.
Nella posizione opposta si trova invece Corrado
Cagli, che anche in questi giorni, ha inaugurato la
sua personale alla Galleria Lattes. Questo pittore
va tanto oltre che ha dimenticato i pennelli nella
fretta e usa l’aerografo.
Poiché pare che egli si diverta a inquadrare sa
gome di oggetti trovati, come ritagli di minuterie
metalliche, la paglia delle sedie di Vienna, le lamie-
rine del meccano, i salvatacchi di ferro, ecc. non
vi è nulla da eccepire sulla sua trovata, che sta
sullo stesso piano del cartone forato di Fontana che
tanto diverte la folla in questi giorni, facendo da
richiamo d ’eccezione nella vetrina di un negozio di
articoli sportivi.


















