
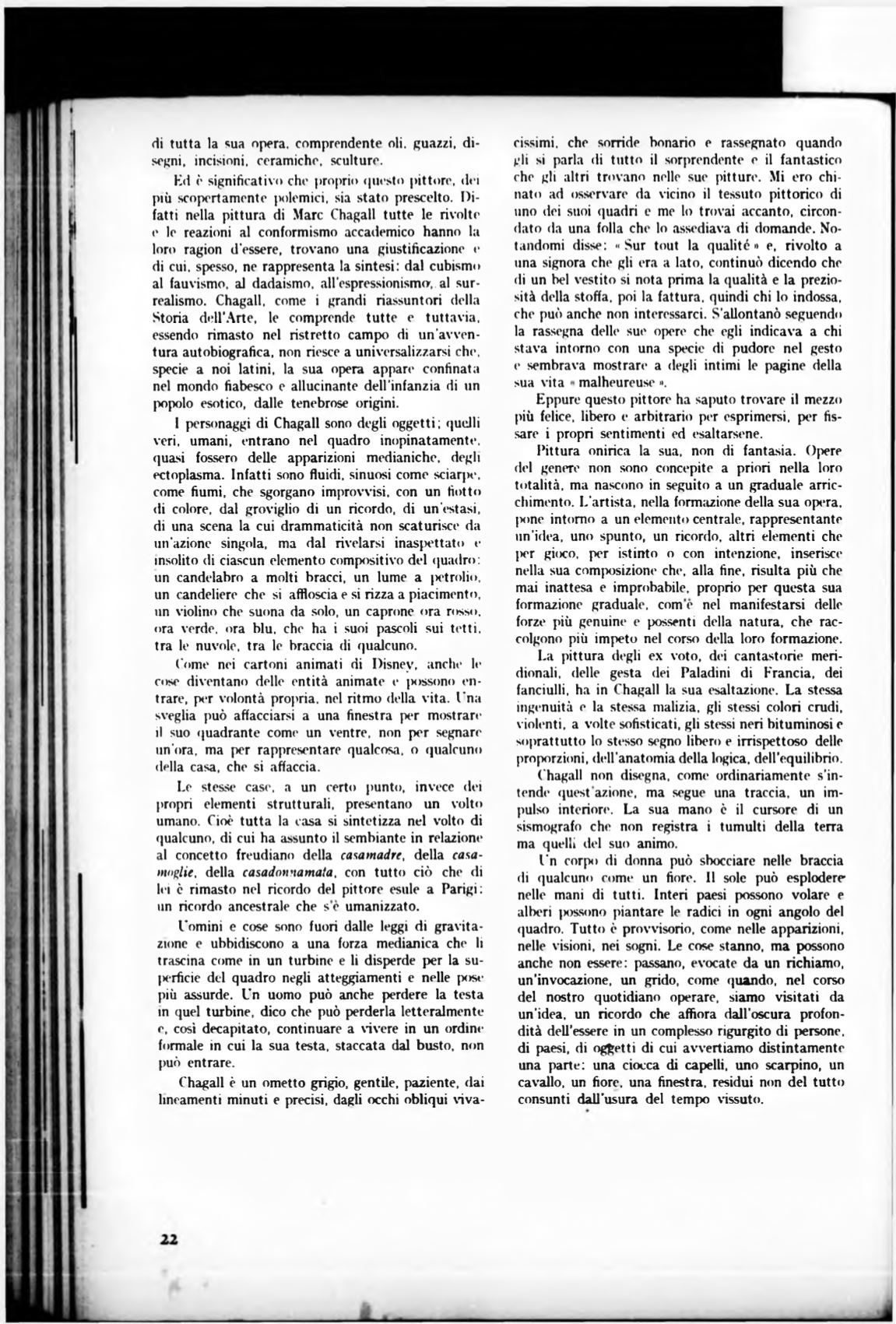
di tutta la sua opera, comprendente oli. guazzi, di
segni, incisioni, ceramiche, sculture.
Kd è significativo che proprio questo pittore, dei
più scopertamente polemici, sia stato prescelto. Di
fatti nella pittura di Marc Chagall tutte le rivolte
e le reazioni al conformismo accademico hanno la
loro ragion d ’essere, trovano una giustificazione e
di cui. spesso, ne rappresenta la sintesi: dal cubismo
al fauvismo, al dadaismo, all’espressionismo;, al sur
realismo. Chagall, come i grandi riassuntori della
Storia dell’Arte, le comprende tutte e tuttavia,
essendo rimasto nel ristretto campo di un’avven
tura autobiografica, non riesce a universalizzarsi che,
specie a noi latini, la sua opera appare confinata
nel mondo fiabesco e allucinante dell’infanzia di un
popolo esotico, dalle tenebrose origini.
1
personaggi di Chagall sono degli oggetti; quelli
veri, umani, entrano nel quadro inopinatamente,
quasi fossero delle apparizioni medianiche, degli
ectoplasma. Infatti sono fluidi, sinuosi come sciarpe,
come fiumi, che sgorgano improvvisi, con un fiotto
di colore, dal groviglio di un ricordo, di un'estasi,
di una scena la cui drammaticità non scaturisce da
un'azione singola, ma dal rivelarsi inaspettato e
insolito di ciascun elemento compositivo del quadro:
un candelabro a molti bracci, un lume a |>etrolio,
un candeliere che si affloscia e si rizza a piacimento,
un violino che suona da solo, un caprone ora rosso,
ora verde, ora blu. che ha i suoi pascoli sui tetti,
tra le nuvole, tra le braccia di qualcuno.
Come nei cartoni animati di Disney, anche le
cose diventano delle entità animate e possono en
trare, per volontà propria, nel ritmo della vita, Una
sveglia può affacciarsi a una finestra per mostrare
il suo quadrante come un ventre, non per segnare
un'ora, ma per rappresentare qualcosa, o qualcuno
della casa, che si affaccia.
Le stesse case, a un certo punto, invece dei
propri elementi strutturali, presentano un volto
umano. Cioè tutta la casa si sintetizza nel volto di
qualcuno, di cui ha assunto il sembiante in relazione
al concetto freudiano della
casamadre,
della
casa-
moglie,
della
casadotmamata,
con tutto ciò che di
lei è rimasto nel ricordo del pittore esule a Parigi:
un ricordo ancestrale che s e umanizzato.
Uomini e cose sono fuori dalle leggi di gravita
zione e ubbidiscono a una forza medianica che li
trascina come in un turbine e li disperde per la su-
[K-rficie del quadro negli atteggiamenti e nelle pose
più assurde. Un uomo può anche perdere la testa
in quel turbine, dico che può perderla letteralmente
e, cosi decapitato, continuare a vivere in un ordine
formale in cui la sua testa, staccata dal busto, non
può entrare.
Chagall è un ometto grigio, gentile, paziente, dai
lineamenti minuti e precisi, dagli occhi obliqui v iva
cissimi, che sorride bonario e rassegnato quando
vii si parla di tutto il sorprendente e il fantastico
che gli altri trovano nelle sue pitture. Mi ero chi
nato ad osservare da vicino il tessuto pittorico di
uno dei suoi quadri e me lo trovai accanto, circon
dato da una folla che lo assediava di domande. No
tandomi disse: «Sur tout la qualité » e, rivolto a
una signora che gli era a lato, continuò dicendo che
di un bel vestito si nota prima la qualità e la prezio
sità della stoffa, poi la fattura, quindi chi lo indossa,
che può anche non interessarci. S ’allontanò seguendo
la rassegna delle sue opere che egli indicava a chi
stava intorno con una specie di pudore nel gesto
e sembrava mostrare a degli intimi le pagine della
sua vita malheureuse •».
Eppure questo pittore ha saputo trovare il mezzo
più felice, libero e arbitrario per esprimersi, per fis
sare i propri sentimenti ed esaltarsene.
Pittura onirica la sua, non di fantasia. Opere
del genere non sono concepite a priori nella loro
totalità, ma nascono in seguito a un graduale arric
chimento. L'artista, nella formazione della sua opera,
|K»ne intorno a un elemento centrale, rappresentante
un'idea, uno spunto, un ricordo, altri elementi che
per gioco, per istinto o con intenzione, inserisce
nella sua composizione che, alla fine, risulta più che
mai inattesa e improbabile, proprio per questa sua
formazione graduale, come nel manifestarsi delle
forze più genuine e possenti della natura, che rac
colgono più impeto nel corso della loro formazione.
La pittura degli ex voto, dei cantastorie meri
dionali, delle gesta dei Paladini di Francia, dei
fanciulli, ha in Chagall la sua esaltazione. La stessa
ingenuità e la stessa malizia, gli stessi colori crudi,
violenti, a volte sofisticati, gli stessi neri bituminosi e
soprattutto lo stesso segno libero e irrispettoso delle
proporzioni, dell’anatomia della logica, dell’equilibrio.
Chagall non disegna, come ordinariamente s ’in
tende quest azione, ma segue una traccia, un im
pulso interiore. La sua mano è il cursore di un
sismografo che non registra i tumulti della terra
ma quelli del suo animo.
Un corpo di donna può sbocciare nelle braccia
di qualcuno come un fiore. 11 sole può esplodere
nelle mani di tutti. Interi paesi possono volare e
alberi |K)ssono piantare le radici in ogni angolo del
quadro. Tutto è provvisorio, come nelle apparizioni,
nelle visioni, nei sogni. Le cose stanno, ma possono
anche non essere: passano, evocate da un richiamo,
un’invocazione, un grido, come quando, nel corso
del nostro quotidiano operare, siamo visitati da
un’idea, un ricordo che affiora dall’oscura profon
dità dell’essere in un complesso rigurgito di persone,
di paesi, di oggetti di cui avvertiamo distintamente
una parte: una ciocca di capelli, uno scarpino, un
cavallo, un fiore, una finestra, residui non del tutto
consunti dall’usura del tempo vissuto.


















