
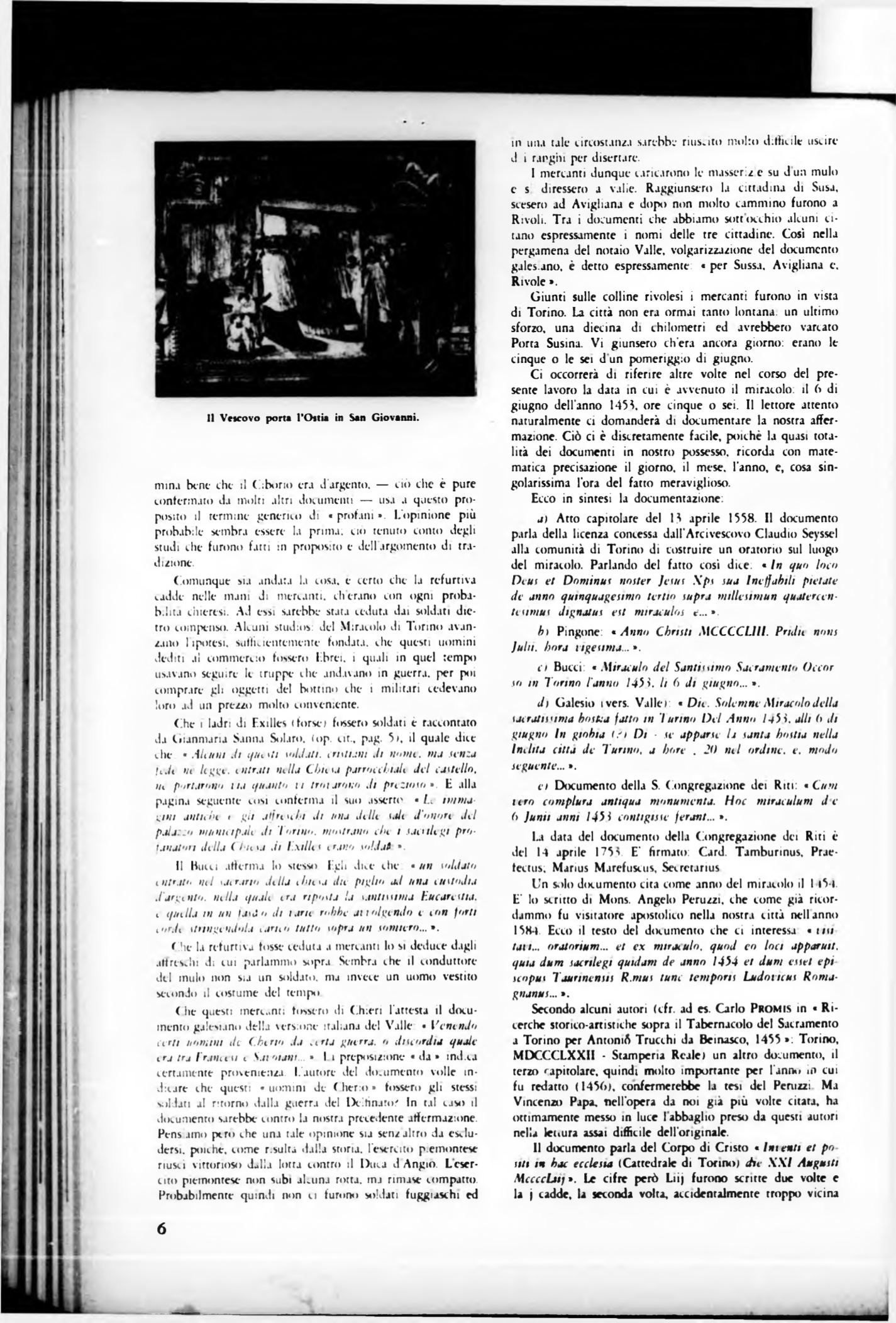
Il Vescovo porta ('Ostia in San Giovanni.
mina beni- che il Ciborio era d'argento, — ciò che è pure
confermato da molti altri documenti — usa a questo pro
posito il termine generico di « profani ». L’opinione più
probabile sembra essere la prima; ciò tenuto conto degli
studi che furono fatti in proposito e dell argomento di tra
dizione.
Comunque sia andata la cosa, e certo che la refurtiva
cadde nelle mani di mercanti, cherano con tigni proba
bilità chic-resi. Ad essi sarebbe- stata ceduta dai soldati die
tro compenso. Alcuni studiosi del Miracolo di Torino avan
zano 1 ipotesi, sufficientemente fondata, che questi uomini
dediti al commercio fossero Ebrei, i quali in quel tempo
usavano seguire le truppe che andavano in guerra, per poi
comprare gli oggetti del bottino che i militari cedevano
loro a J un prezzo molto conveniente.
Che i ladri di Exilles (forse) fossero soldati è raccontato
da Gianmaria Sauna Solaro, (op. cit., pag.
5
», il quale dice
die *
Alcuni .li questi soldati. cristiani .li nume, ma senza
ti.h m legge, nitrati mila C h ina parrocchiali del castello,
in portarono uà quanto u trinarono di prezioso
». E alla
pagina seguente cosi conferma il suo asserto: «
Li imma
gini antiche
<
gli affreschi di una d ille sali d'onori del
p.ila::o municipali di Tonno, mostrano che i sacnlegi pro
fanatoti della C h in a di Exilles
i
r.mosoldat
».
Il
Bucci afferma Io stesso. F.gii dice che «
un soldato
intr.it>' m i
i
aerano d illa chiesa die piglio ad una custodia
d'arginto. m ila t/uah ira riposta la santissima Eucarestia,
i i/nella ni un j astio di taru rohbe ai volgendo e con forti
i
ordì stringendola
cari
co tutto sopra un somiero...
».
Che la refurtiva fosse ceduta a mercanti lo si deduce dagli
affreschi di cui parlammo sopra Sembra che il conduttore
del mulo non sia un soldato, ma invece un uomo vestito
secondo il costume del tempi
C
he questi mercanti fossero di Chieri l'attesta il
docu
mento galesiano della versione italiana del Valle «
Venendo
certi uomini de C h in o da c ir tj guerra, o discordia eiuale
era tra Francesi i Saiotant...
» l a preposizione « da »
ind.cacertamente provenienza. L'autore del documento volle in
dicare che questi «uomini de Cherio» fossero
gli
stessi
saldati al ritorno dalla guerra del Deifinaro.' In tal caso il
documento sarebbe contro la nostra precedente affermazione.
Pens .uno ptro che una tale opinione sia senz altro da esclu
dersi. poiché, come r.sulta dalla storia, ['esercito piemontese
riusci vittorioso dulia lotta contro il Duca d
Angio.
Lcser-
cito piemontese non subì alcuna rotta, ma rimase compatto.
Probabilmente quindi non o furono soldati
fuggiaschi ed
6
in una tale circostanza sarebbe- riuscito molto difficile uscire
d i ranghi per disertare.
I mercanti dunque caricarono le nusseriz.e su d un mulo
e s diressero a valie. Raggiunsero la cittadina di Susa,
scesero ad Avigliana e dopo non molto cammino furono a
Rivoli. Tra i documenti che abbiamo sottocchio alcuni ci
tano espressamente i nomi delle tre cittadine. Così nella
pergamena del notaio Valle, volgarizzazione del documento
gales.ano, è detto espressamente: « per Sussa, Avigliana e,
Rivole ».
Giunti sulle colline rivolesi i mercanti furono in vista
di Torino. La città non era ormai tanto lontana: un ultimo
sforzo, una diecina di chilometri ed avrebbero varcato
Porta Susina. Vi giunsero ch’era ancora giorno: erano le
cinque o le sei d un pomeriggio di giugno.
Ci occorrerà di riferire altre volte nel corso del pre
sente lavoro la data in cui è avvenuto il miracolo: il 6 di
giugno dell'anno
1453
, ore cinque o sei. Il lettore attento
naturalmente ci domanderà di documentare la nostra affer
mazione. Ciò ci è discretamente facile, poiché la quasi tota
lità dei documenti in nostro possesso, ricorda con mate
matica precisazione il giorno, il mese, l'anno, e, cosa sin
golarissima l'ora del fatto meraviglioso.
Ecco in sintesi la documentazione:
ai
Atto capitolare del
13
aprile
1558
. Il documento
parla della licenza concessa dall’Arcivescovo Claudio Seyssel
alla comunità di Torino di costruire un oratorio sul luogo
del miracolo. Parlando del fatto cosi dice: «
In quo loco
Deus et Dnminur noster Jesus Xps sua Ineffabili pietate
de anno quinquagesimo tertio supra millesimun quatercen-
tesimus dignatus est miraculos e...
».
h>
Pingone: «
Anno Chnsti MCCCCUII. Pndit noni
) uhi. bora vige sima...
».
ci
Bucci: «
Miraculo del Santissimo Sacramento Occor
so ni Tonno l'anno
145
). h
6
di giugno...
».
dì
Galesio i vers. Valle): «
Die. Solenne Miracolo della
sacratissima bastia fatto in Turino Del Anno 1 4
5
ì.
alli (1 di
giugno In giohia t/i Di - se apparse li santa hostia nella
Inilita citta de Turino, a bore .
20
m i ordine, e. modo
seguente...
».
ci
Documento della S. Congregazione dei Riti: «
Cum
uro complura antiqua monumenta. Hoc miraculum d e
6
Junii anni
145
i contigisse ferant...
».
La data del documento della Congregazione dei Riti è
del
14
aprile
175
v E' firmato: Card. Tamburinus, Prae-
fectus; Marius Marefuscus, Secretarius
Un solo documento cita come anno del miracolo il I »
5
-i.
E' lo scritto di Mons. Angelo Peruzzi, che come già ricor
dammo fu visitatore apostolico nella nostra città nellanno
1584
. Ecco il testo del documento che ci interessa «
in i
tati... oratorium... et ex mirai ulo. quod co loci apparuit.
quia dum sacrilegi quidam de anno
1454
et dum esset epi
scopus Taurinensis R.mus tunc tempori! Ludoucus Roma-
gnanus...
».
Secondo alcuni autori (cfr. ad es. Carlo
P rom is
in « R i
cerche storico-artistiche sopra il Tabernacolo del Sacramento
a Torino per Antonift Trucchi da Beinasco,
1455
»: Torino,
MDCCCLXX II - Stamperia Reale) un altro documento, il
terzo capitolare, quindi molto importante per l’anrh» in cui
fu redatto (
1456
), confermerebbe la tesi del Peruzzi Ma
Vincenzo Papa, nell'opera da noi già più volte citata, ha
ottimamente messo in luce [ abbaglio preso da questi autori
nella lettura assai difficile dell'originale.
II
documento parla del Corpo di Cristo «
Intenti et
pò
siti in hoc ecclesia
(Cattedrale di Torino)
die X X I Augusti
MccccLtij
». Le cifre però Liij furono scritte due volte e
la i cadde, la seconda volta, accidentalmente troppo vicina


















