
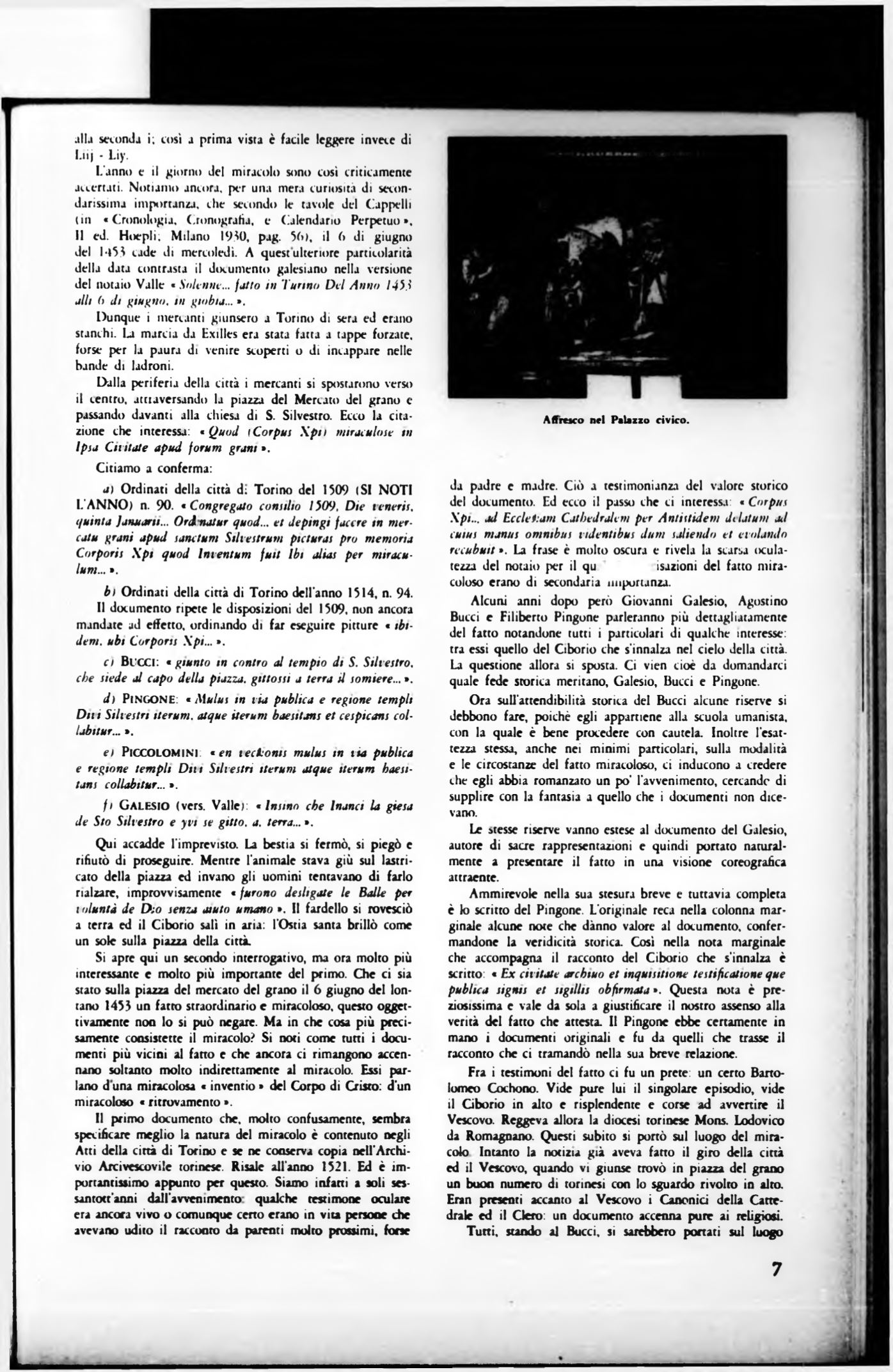
alla seconda i; così a prima vista è facile leggere invece di
Liij • Liy.
L'anno e il giorno del miracolo sono così criticamente
accertati. Notiamo ancora, per una mera curiosità di secon
darissima importanza, che secondo le tavole del Cappelli
(in «Cronologia, Cronografia, e Calendario Perpetuo»,
Il ed. Hoepli; Milano 1930, pag. 5(>), il 6 di giugno
del 1453 cade di mercoledì. A quest ulteriore particolarità
della data contrasta il documento galesiano nella versione
del notaio Valle «
Solenne... fatto in Turino Del Anno I45.Ì
alh
6
di giugno, in giobta...
».
Dunque i mercanti giunsero a Torini) di sera ed erano
stanchi, lu marcia da Exilles era stata fatta a tappe forzate,
forse per la paura di venire scoperti o di incappare nelle
bande di ladroni.
Dalla periferia della città i mercanti si spostarono verso
it centro, attiaversando la piazza del Mercato del grano e
passando davanti alla chiesa di S. Silvestro. Ecco la cita
zione che interessa: «
QuoJ
[Corpus Xpn
miraiulose
in
Ipsa Cintate apud forum grani
».
Citiamo a conferma:
a)
Ordinati della città d: Torino del 1509 (SI NOT I
L 'ANNO ) n. 90. «
Congregato constilo 1509, Die teneris.
(fuinta ]amarti... Ord natur qund... et depingi facere in mer-
catu grani apud sanctum Stlvestrum picturas prò memoria
Corporis Xpt quod Inventum futi Ibi alias per miracu-
lum...
».
b)
Ordinati della città di Torino dell'anno 1514, n. 94.
Il documento ripete le disposizioni del 1509, non ancora
mandate ad effetto, ordinando di far eseguire pitture «
ibi
dem. ubi Corpons Xpi...
».
ci
BU C C I:
«
giunto in contro al tempio di S. Silvestro,
che siede al capo della piazza, gittossi a terra tl somiere...
».
d)
PlNGONE: «
Mulus in via publica e regione templi
Dit i Silvestri iterum. atque iterum baesitans et cespicans col
labitur...
».
e)
P
ic c o l o m in i
: «
en t ecLonis mulus in via publica
e regione templi D m Silvestri iterum atque iterum haest-
tans collabitur...
».
fi
G a l e s i o
(vers. Valle): «
Instno che Inanci la giesa
de Sto Silvestro e yvt se gitto. a. terra...
».
Qui accadde l’imprevisto. La bestia si fermò, si piegò e
rifiutò di proseguire. Mentre l’animale stava giù sul lastri
cato della piazza ed invano gli uomini tentavano di farlo
rialzare, improvvisamente «
furono deshgate le Balle per
i
uluntà de D:o senza aiuto umano
». Il fardello si rovesciò
a terra ed il Ciborio salì in aria: l’Ostia santa brillò come
un sole sulla piazza della città.
Si apre qui un secondo interrogativo, ma ora molto più
interessante e molto più importante del primo. Che ci sia
stato sulla piazza del mercato del grano il 6 giugno del lon
tano 1453 un fatto straordinario e miracoloso, questo ogget
tivamente non lo si può negare. Ma in che cosa p iù preci
samente consistette il miracolo? Si noti come tutti i docu
menti più vicini al fatto e che ancora ci rimangono accen
nano soltanto molto indirettamente al miracolo. Essi par
lano d una miracolosa « inventio » del Corpo di Cristo: d’un
miracoloso « ritrovamento ».
Il
primo documento che, molto confusamente, sembra
specificare meglio la natura del miracolo è contenuto negli
Atti della città di Torino e se ne conserva copia nell’Archi
vio Arcivescovile torinese. Risale all’anno 1521. Ed è im
portantissimo appunto per questo. Siamo infatti a soli ses-
santott'anni dall'avvenimento qualche testimone oculare
era ancora vivo o comunque certo erano in vita persone che
avevano udito il raccooto da parenti molto prossimi, fone
Affresco nel Palazzo civico.
da padre e madre. Ciò a testimonianza del valore storico
del documento. Ed ecco il passo che ci interessa: «
Corpus
Xpt... ad Ecclef:am Cathedralem per Antittidem dilatimi ad
cuius manta omnibus videntibus dum saliendo et evolando
recubuit
». La frase è molto oscura e rivela la scarsa ocula
tezza del notaio per il qu
isazioni del fatto mira
coloso erano di secondaria importanza.
Alcuni anni dopo però Giovanni Galesio, Agostino
Bucci e Filiberto Pingone parleranno più dettagliatamente
del fatto notandone tutti i particolari di qualche interesse:
tra essi quello del Ciborio che s’innalza nel cielo della città.
La questione allora si sposta. Ci vien cioè da domandarci
quale fede storica meritano, Galesio, Bucci e Pingone.
Ora sull’attendibilità storica del Bucci alcune riserve si
debbono fare, poiché egli appartiene alla scuola umanista,
con la quale è bene procedere con cautela. Inoltre l’esat
tezza stessa, anche nei m inim i particolari, sulla modalità
e le circostanze del fatto miracoloso, ci inducono a credere
che egli abbia romanzato un po’ l’avvenimento, cercando di
supplire con la fantasia a quello che i documenti non dice
vano.
Le stesse riserve vanno estese al documento del Galesio,
autore di sacre rappresentazioni e quindi portato natural
mente a presentare il fatto in una visione coreografica
attraente.
Ammirevole nella sua stesura breve e tuttavia completa
è lo scritto del Pingone. L’originale reca nella colonna mar
ginale alcune note che dànno valore al documento, confer
mandone la veridicità storica. Così nella nota marginale
che accompagna il racconto del Ciborio che s’innalza è
scritto: «
Ex civitate arcbtuo et inquisitane testificatione que
publica signts et sigilla obfirmala
». Questa nota è pre
ziosissima e vale da sola a giustificare il nostro assenso alla
verità del fatto che attesta II Pingone ebbe certamente in
mano i documenti originali e fu da quelli che trasse il
racconto che ci tramandò nella sua breve relazione.
Fra i testimoni del fatto ci fu un prete: un certo Barto
lomeo Cochono. Vide pure lui il singolare episodio, vide
il G b o rio in alto e risplendente e corse ad avvertire il
Vescovo. Reggeva allora la diocesi torinese Mons. Lodovico
da Romagnano. Questi subito si portò sul luogo del mira
colo Intanto la notizia già aveva fatto il giro della città
ed il Vescovo, quando vi giunse trovò in piazza del grano
un buon numero di torinesi con Io sguardo rivolto in alto.
Eran presenti accanto al Vescovo i Canonici della Catte
drale ed il Clero: un documento accenna pure ai religiosi.
Tutti, stando al Bucci, si sarebbero portati sul luogo
7


















