
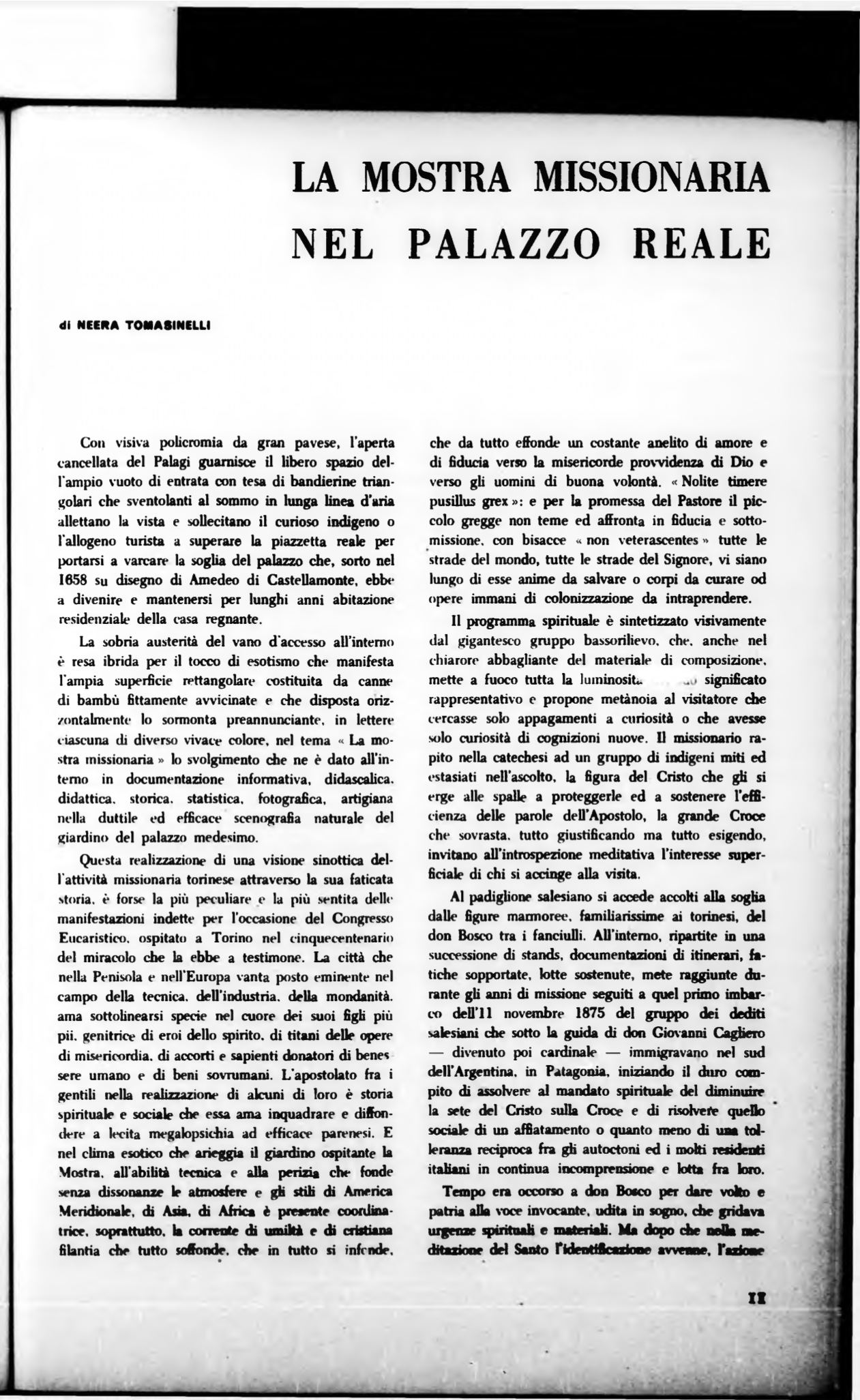
LA MOSTRA MISSIONARIA
NEL PALAZZO REALE
di NEERA TOMASINELLI
Con visiva policromia da gran pavese, l’aperta
cancellata del Palagi guarnisce il libero spazio del
l'ampio vuoto d i entrata con tesa d i bandierine trian
golari che sventolanti al sommo in lunga linea d ’aria
allettano la vista e sollecitano il curioso indigeno o
l'allogeno turista a superare la piazzetta reale per
portarsi a varcare la soglia del palazzo che, sorto nel
1658 su disegno di Amedeo d i Castellamonte, ebbe*
a divenire e mantenersi per lunghi anni abitazione
residenziale della casa regnante.
La sobria austerità del vano d'accesso a ll’interno
è
resa ibrida per il tocco di esotismo che manifesta
l’ampia superfìcie rettangolare costituita da canne
di bambù fittamente avvicinate e che disposta oriz
zontalmente lo sormonta preannunciante, in lettere
ciascuna di diverso vivace colore, nel tema « La mo
stra missionaria » lo svolgimento d ie ne è dato all’in-
temo in documentazione informativa, didascalica,
didattica, storica, statistica, fotografica, artigiana
nella duttile ed efficace scenografia naturale del
giardino del palazzo medesimo.
Questà realizzazione di una visione sinottica del
l'attività missionaria torinese attraverso la sua faticata
storia, è forse la più peculiare e la più sentita delle
manifestazioni indette per l’occasione del Congresso
Eucaristico, ospitato a Torino nel cinquecentenario
del miracolo che la ebbe a testimone. La città che
nella Penisola e nell’Europa vanta posto eminente nel
campo della tecnica. deH’industria. della mondanità,
ama sottolinearsi specie nel cuore dei suoi figli più
pii. genitrice d i eroi dello spirito, d i titani delle opere
di misericordia, di accorti e sapienti donatori di benes
sere umano e di beni sovrumani. L'apostolato fra i
gentili nella realizzazione di alcuni di loro è storia
spirituale e sociale die essa ama inquadrare e diffon
dere a lecita megalopsichia ad efficace parenesi. E
nel clima esotico che arieggia il giardino ospitante la
Mostra, all’abilità tecnica e alla perizia che fonde
senza dissonanze
le atmosfere
e gli stili d i
America
Meridionale,
di Asia, di Africa è presente coordina
trice. soprattutto, ia corrente di umiltà e di cristiana
filantia che
tutto soffonde, che
in
tutto
si infrnde.
•
che da tutto effonde un costante anelito d i amore e
di fiducia verso la misericorde provvidenza d i D io e
verso gli uomini d i buona volontà. « Nolite timere
pusillus grex »: e per la promessa del Pastore il pie-
colo gregge non teme ed affronta in fiducia e sotto-
missione. con bisacce « non veterascentes » tutte le
strade del mondo, tutte le strade del Signore, vi siano
lungo di esse anime da salvare o corpi da curare od
opere immani di colonizzazione da intraprendere.
11
programma spirituale è sintetizzato visivamente
dal gigantesco gruppo bassorilievo, che, anche nel
chiarore abbagliante del materiale di composizione,
mette a fuoco tutta la luminositi.
significato
rappresentativo e propone metànoia al visitatore d ie
cercasse solo appagamenti a curiosità o che avesse
solo curiosità di cognizioni nuove. 11 missionario ra
pito nella catechesi ad un gruppo d i indigeni m iti ed
estasiati nell’ascolto, la figura del Cristo che gli si
erge alle spalle a proteggerle ed a sostenere l'effi
cienza delle parole dell’Apostolo, la grande Croce
che sovrasta, tutto giustificando ma tutto esigendo,
invitano all’introspezione meditativa l’interesse super
ficiale di chi si accinge alla visita.
Al padiglione salesiano si accede accolti alla soglia
dalle figure marmoree, familiarissime ai torinesi, del
don Bosco tra i fanciulli. A ll’interno, ripartite in una
successione di stands, documentazioni di itinerari,
fa
tiche sopportate, lotte sostenute, mete raggiunte
du
rante gli anni di missione seguiti a quel primo
imbar
co dell’l l novembre 1875 del gruppo dei
dediti
salesiani che sotto la guida d i don Giovanni Cagherò
— divenuto poi cardinale — immigravano nel sud
dell’Argentina, in Patagonia, iniziando il duro com
pito d i assolvere al mandato spirituale del dim inuire
la sete del Cristo sulla Croce e d i risolvete quello
sociale d i un affiatamento o quanto meno d i
una
tol
leranza reciproca fra gli autoctoni ed i molti
residenti
italiani in continua incomprensione e lotta fra loro.
Tempo era occorso a don Bosco per dare volto e
patria alla voce invocante, udita in sogno, che gridava
urgenze spirituali e materiali.
Ma
dopo che
neBa
me
ditazione del Santo l'identificazione avvenne, l’azione
I I


















