
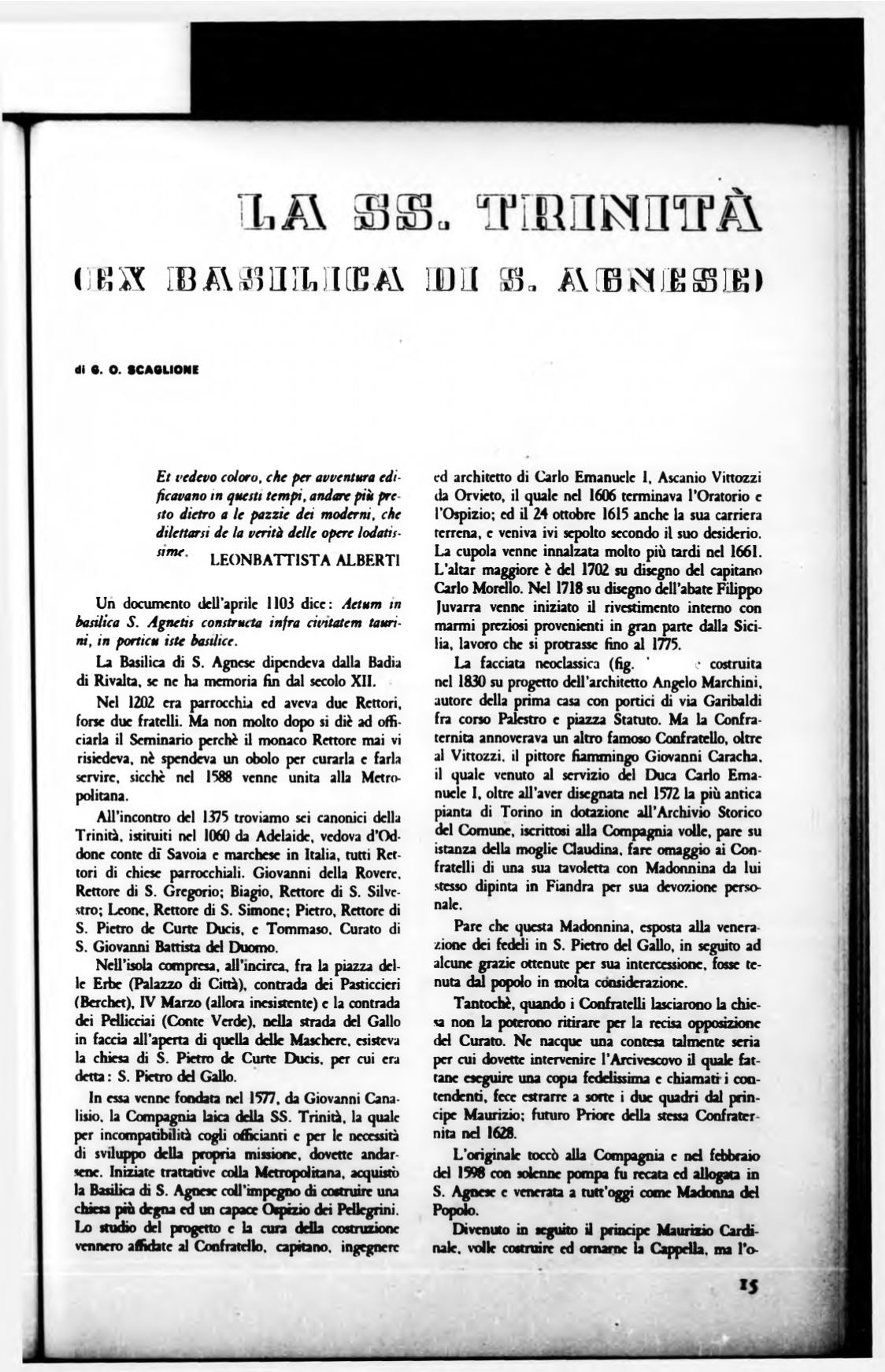
( I M IBA
3 5
BILUCEA ÌDII >Ti, M T J t ' I I S i K )
di G. O. SCAGLIONE
Et vedevo coloro, che per avventura edi
ficavano in questi tempi, andare più pre
sto dietro a le pazzie dei moderni, che
dilettarsi de la verità delle opere lodatis-
s,mr
LEONBATTISTA ALBERTI
Un documento dell’aprile 1103 dice:
Aetum in
basilica S. Agnetis construtta infra eiintatem tauri
ni, in porticu iste basilice.
La Basilica di S. Agnese dipendeva dalla Badia
di Rivalta, se ne ha memoria fin dal secolo XII.
Nel 1202 era parrocchia ed aveva due Rettori,
forse due fratelli. Ma non molto dopo si diè ad offi
ciarla il Seminario perchè il monaco Rettore mai vi
risiedeva, nè spendeva un obolo per curarla e farla
servire, sicché nel 1588 venne unita alla Metro
politana.
All’incontro del 1375 troviamo sei canonici della
Trinità, istituiti nel 1060 da Adelaide, vedova d’Od-
done conte dì Savoia e marchese in Italia, tutti Ret
tori di chiese parrocchiali. Giovanni della Rovere,
Rettore di S. Gregorio; Biagio, Rettore di S. Silve
stro; Leone, Rettore di S. Simone; Pietro, Rettore di
S. Pietro de Curte Ducis, e Tommaso. Curato di
S. Giovanni Battista del Duomo.
Nell’isola compresa, all'incirca, fra la piazza del
le Erbe (Palazzo di Città), contrada dei Pasticcieri
(Berchet), IV Marzo (allora inesistente) e la contrada
dei Pellicciai (Conte Verde), nella strada del Gallo
in faccia all’aperta di quella delle Maschere, esisteva
la chiesa di S. Pietro de Curte Ducis, per cui era
detta : S. Pietro del Gallo.
In essa venne fondata nel 1577, da Giovanni Cana-
lisio. la Compagnia laica della SS. Trinità, la quale
per incompatibilità cogli officianti e per le necessità
di sviluppo della propria missione, dovette andar
sene. Iniziate trattative colla Metropolitana, acquistò
la Basilica di S. Agnese coll’impegno di costruire una
chiesa più degna ed un capace Ospizio dei Pellegrini.
Lo studio del progetto e la cura della costruzione
vennero affidate al Confratello, capitano, ingegnere
cd architetto di Carlo Emanuele 1. Ascanio Vittozzi
da Orvieto, il quale nel 1606 terminava l ’Oratorio e
l’Ospizio; ed il 24 ottobre 1615 anche la sua carriera
terrena, e veniva ivi sepolto secondo il suo desiderio.
La cupola venne innalzata molto più tardi nel 1661.
L’altar maggiore è del 1702 su disegno del capitano
Carlo Morello. Nel 1718 su disegno dell’abate Filippo
luvarra venne iniziato il rivestimento intemo con
marmi preziosi provenienti in gran parte dalla Sici
lia, lavoro che si protrasse fino al 1775.
La facciata neoclassica
(fig.
’
e
costruita
nel 1830 su progetto dell’architetto Angelo Marchini,
autore della prima casa con portici di via Garibaldi
fra corso Palestra e piazza Statuto. Ma la Confra
ternita annoverava un altro famoso Confratello, oltre
al Vittozzi. il pittore fiammingo Giovanni Caracha.
il quale venuto al servizio del Duca Carlo Ema
nuele I, oltre all’aver disegnata nel 1572 la più antica
pianta di Torino in dotazione all’Archivio Storico
del Comune, iscrittosi alla Compagnia volle, pare su
istanza della moglie Claudina. fare omaggio ai Con
fratelli di una sua tavoletta con Madonnina da lui
stesso dipinta in Fiandra per sua devozione perso
nale.
Pare che questa Madonnina, esposta alla venera
/.ione dei fedeli in S. Pietro del Gallo, in seguito ad
alcune grazie ottenute per sua intercessione, fosse te
nuta dal
popolo
in molta considerazione.
Tantoché, quando i Confratelli lasciarono la chie
sa non la poterono ritirare per la recisa opposizione
del Curato. Ne nacque una contesa talmente seria
per cui dovette intervenire l’Arcivescovo il quale fat
tane eseguire una copia fedelissima e chiamati i con
tendenti, fece estrarre a sorte i due quadri dal prin
cipe Maurizio; futuro Priore della stessa Confrater
nita nel 1628.
L ’originale toccò alla Compagnia e nei febbraio
dd 1598 con solenne pompa fu recata ed allogata in
S. Agnese e venerata a tutt’oggi come Madonna dd
Popolo.
Divenuto in seguito il principe Maurizio Cardi
nale. volle costruire ed ornarne b Cappella, ma Po-


















