
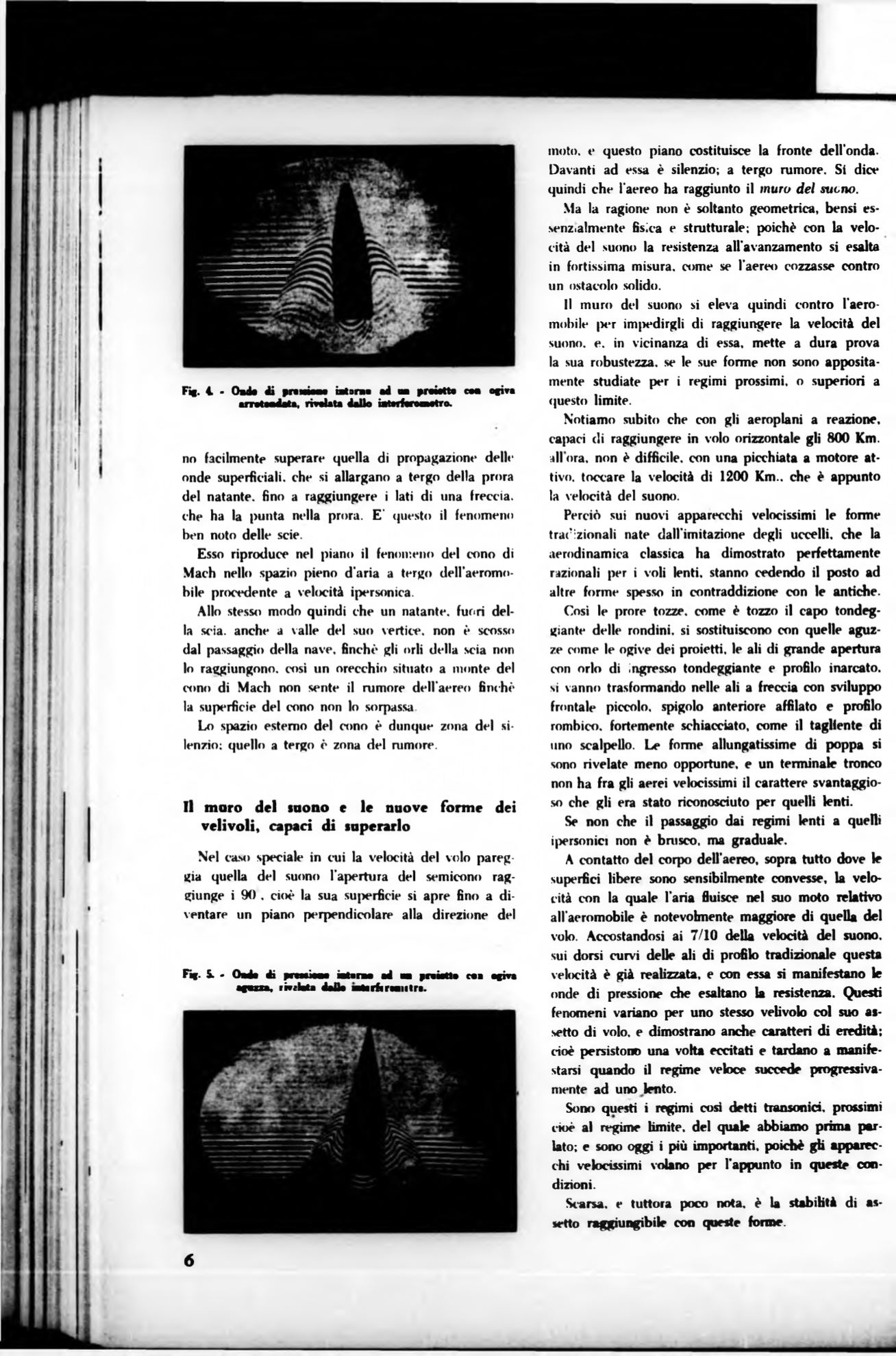
Fif. 1 - O
m
U di preirione intorno ad un proietto con ofiva
arrotondata, rivelata dallo interferometro.
no facilmente superare quella di propagazione delle
onde superficiali, che si allargano a tergo della prora
del natante, fino a raggiungere i lati di una treccia,
che ha la punta nella prora. E' questo il fenomeno
ben noto delle scie.
Esso riproduce nel piano il fenomeno del cono di
Mach nello spazio pieno d 'aria a tergo dell’aeromo
bile procedente a velocità ipersonica.
Allo stesso modo quindi che un natante, fuori del
la scia, anche a valle del suo vertice, non è scosso
dal passaggio della nave, finché gli orli della scia non
10 raggiungono, così un orecchio situato a monte del
cono di Mach non sente il rumore dell'aereo finché
la superficie del cono non lo sorpassa
Lo spazio esterno del cono è dunque zona del si
lenzio: quello a tergo é zona del rumore.
11 moro del suono e le nuove forme dei
velivoli, capaci di superarlo
Nel caso speciale in cui la velocità del volo pareg
gia quella del suono l’apertura del semicono rag
giunge i 90 , cioè la sua superficie si apre fino a d i
ventare un piano perpendicolare alla direzione del
moto, e questo piano costituisce la fronte dell'onda.
Davanti ad essa è silenzio; a tergo rumore. Si dice
quindi che l’aereo ha raggiunto il
muro del sucno.
Ma la ragione non è soltanto geometrica, bensi es
senzialmente fisica e strutturale; poiché con la velo
cità del suono la resistenza all'avanzamento si esalta
in fortissima misura, come se l’aereo cozzasse contro
un ostacolo solido.
Il
muro del suono si eleva quindi contro l'aero
mobile per impedirgli di raggiungere la velocità del
suono, e. in vicinanza di essa, mette a dura prova
la sua robustezza, se le sue forme non sono apposita
mente studiate per i regimi prossimi, o superiori a
questo limite.
Notiamo subito che con gli aeroplani a reazione,
capaci di raggiungere in volo orizzontale gli 800 Km.
allora, non è difficile, con una picchiata a motore a t
tivo. toccare la velocità di 1200 Km., che è appunto
la velocità del suono.
Perciò sui nuovi apparecchi velocissimi le forme
tradizionali nate dall'imitazione degli uccelli, che la
aerodinamica classica ha dimostrato perfettamente
razionali per i voli lenti, stanno cedendo il posto ad
altre forme spesso in contraddizione con le antiche.
Così le prore tozze, come è tozzo il capo tondeg
giante delle rondini, si sostituiscono con quelle aguz
ze come le ogive dei proietti, le ali di grande apertura
con orlo di ingresso tondeggiante e profilo inarcato,
si vanno trasformando nelle ali a freccia con sviluppo
frontale piccolo, spigolo anteriore affilato e profilo
rombico, fortemente schiacciato, come il tagliente di
uno scalpello. Le forme allupa tissim e di poppa si
sono rivelate meno opportune, e un terminale tronco
non ha fra gli aerei velocissimi il carattere svantaggio
so che gli era stato riconosciuto per quelli lenti.
Se non che il passaggio dai regimi lenti a quelli
ipersonici non è brusco, ma graduale.
A contatto del corpo dell'aereo, sopra tu tto dove le
superfici libere sono sensibilmente convesse, la velo
cità con la quale l’aria fluisce nel suo moto relativo
all'aeromobile è notevolmente maggiore di quella del
volo. Accostandosi ai 7/10 della velocità del suono,
sui dorsi curvi delle ali di profilo tradizionale questa
velocità è già realizzata, e con essa si manifestano le
onde d i pressione che esaltano la resistenza. Questi
fenomeni variano per uno stesso velivolo col suo as
setto d i volo, e dimostrano anche caratteri d i eredità;
cioè persistono una volta eccitati e tardano a manife
starsi quando il regime veloce succede progressiva
mente ad uno lento.
Sono questi i regimi cosi detti transonici, prossimi
cioè al regime limite, del quale abbiamo prima p a r
lato; e sono oggi i più importanti, poiché gli apparec
chi velocissimi volano per l’appunto in queste con
dizioni.
Scarsa, e tu ttora poco nota, è la stabilità di as
setto raggiungibile con queste forme.
Fi*. S. - Ondo di pretina* intorno ad un preietto eoa offra
aguzza, rivelata dallo ■X rfirw iiitre.
6


















